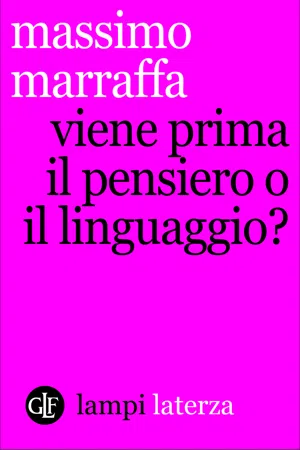
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Viene prima il pensiero o il linguaggio?
Informazioni su questo libro
Qual è la relazione tra il linguaggio e il pensiero? Il linguaggio dà forma al pensiero? Il pensiero è indipendente dal linguaggio? Il linguaggio serve solamente a trasmettere i pensieri da una mente all'altra?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Viene prima il pensiero o il linguaggio? di Massimo Marraffa in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Saggi di filosofia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Saggi di filosofiaViene prima il pensiero o il linguaggio?
La domanda
Vi siete mai chiesti come vengono dati i nomi ai colori? Perché mai dovremmo farci una domanda tanto bizzarra, direte voi. Dare nomi ai colori sembrerebbe la cosa più semplice di questo mondo. Di certo i bambini non incontrano difficoltà nell’imparare ad applicare i nomi messi a disposizione dalla propria lingua ai colori che percepiscono. Ma allora, dov’è il problema?
Tuttavia, forse, a ben guardare, qualche problema c’è, soprattutto in considerazione del fatto che le parole denotano i colori come entità discrete (ossia nettamente distinte l’una dall’altra), mentre – a quanto ci dicono i fisici – la gamma cromatica che noi percepiamo dal rosso al blu e dal bianco al nero è una dimensione continua. Almeno una domanda, allora, dobbiamo porcela: su che basi avviene la differenziazione che si rispecchia nelle forme linguistiche?
Una possibile risposta è questa: «i nomi sono attribuiti ai colori in modo del tutto arbitrario, determinato soltanto da fattori culturali». Ciò sembra dimostrato dal fatto che vi sono una molteplicità di sistemi di denominazione dei colori in uso nelle varie comunità linguistiche. Ad esempio, mentre le lingue indoeuropee hanno classificazioni di colori molto simili all’italiano, altre, appartenenti a ceppi diversi, come alcune lingue parlate in Nuova Guinea, hanno solo due termini: uno che corrisponde approssimativamente a brillante, con cui ci si riferisce al rosso e al giallo, e uno corrispondente a scuro, con cui si denotano il verde, il blu, o il nero.
A rafforzare la nostra ipotesi vi è anche l’osservazione che è più facile riconoscere un colore visto in precedenza nel caso in cui per quel colore esiste un nome specifico della nostra lingua, piuttosto che nel caso in cui un tale nome non sia disponibile.
Tuttavia vi sono altre evidenze che sembrano dar corpo a un’ipotesi diametralmente opposta. Se dal punto di vista della fisica nulla sembra giustificare il tracciare confini tra i colori, le cose cambiano quando si assume la prospettiva della neurofisiologia. Quest’ultima ha dimostrato che il sistema visivo contiene, nella retina, tre tipi di cellule sensoriali (i ‘coni’), ognuna con un pigmento differente; i coni sono collegate ad altre cellule (dette ‘gangliari’) in modo tale che queste ultime rispondono meglio alle macchie rosse su uno sfondo verde piuttosto o viceversa, al blu sul giallo e al nero sul bianco. Insomma, il sistema visivo organizza i colori in coppie di opposti: rosso/verde, giallo/blu, bianco/nero. Questo dato relativo a una segmentazione innata dello spettro dei colori ha trovato un preciso riscontro in una serie di ricerche condotte da psicologi e antropologi.
Innanzitutto si è constatato che i colori non sono tutti equivalenti dal punto di vista di chi li percepisce: alcuni – quelli, per l’appunto, corrispondenti all’organizzazione neurofisiologica del continuum cromatico, come il rosso fuoco, il verde erba, il giallo limone – sono ‘fondamentali’ e dunque più facilmente discriminabili anche da parte di quegli individui la cui lingua non fornisce nomi specifici per essi. Non solo, ma per quegli stessi individui, dei tanti colori denotati con un unico nome, quelli fondamentali costituiscono gli esemplari migliori allo stesso modo in cui una mela è un esemplare di frutto migliore di un’anguria. Alcune indagini antropologiche hanno infatti dimostrato che per le popolazioni della Nuova Guinea il rosso o il giallo sono istanze migliori di ‘brillante’ rispetto al rosa o all’ocra.
Secondo questa ipotesi, insomma, il modo in cui concettualizziamo i colori e attribuiamo loro nomi non è arbitrario, ma si fonda sulle proprietà innate del nostro sistema neurofisiologico che impone restrizioni e limiti ai diversi modi in cui le varie lingue possono segmentare il continuum cromatico che percepiamo.
Abbiamo dunque delineato due ipotesi. La prima asserisce che il modo in cui concettualizziamo i colori è determinato dai termini che una lingua ci mette a disposizione per organizzare il continuum dello spettro dei colori. La seconda sostiene che questo continuum è già organizzato e «non importa quanto il linguaggio possa essere influente: per un neurofisiologo sarebbe assurdo supporre che possa raggiungere la retina e riorganizzare le cellule gangliari»1...
Indice dei contenuti
- Viene prima il pensiero o il linguaggio?
- L’autore