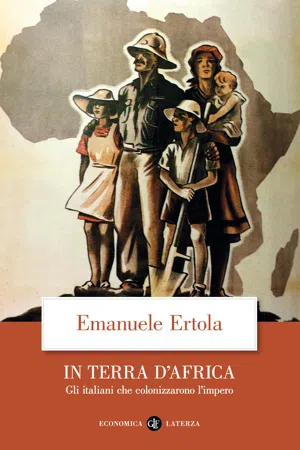1.
Emigrare nell’impero
1.1. Emigrazione e colonie
Quando si parla di colonialismo, si racconta una storia di emigrazione. Nei cinque secoli di storia dell’espansione coloniale, e specialmente tra Otto e Novecento, una marea umana si è riversata fuori dall’Europa: con modi e tempi differenti, milioni di europei – anglosassoni in particolare – hanno invaso le Americhe, l’Oceania, e porzioni di Asia e Africa, fondando società bianche oltremare. Come la rivoluzione industriale, così la «rivoluzione settler» ha ridisegnato il mondo. È all’interno di questo contesto globale che si colloca l’esperienza dei coloni italiani in Etiopia, fondatori di una società bianca che era il prodotto di una migrazione.
Si tratta di una premessa necessaria per comprendere come la colonizzazione fosse parte dell’emigrazione europea, uno dei più imponenti fenomeni sociali che investirono il continente tra XIX e XX secolo, e che ebbe come principale caratteristica quella di essere estremamente variegato, complesso ed eterogeneo: interessò una moltitudine di paesi di partenza e di destinazione – esterni o interni all’Europa –, persone di ogni occupazione e classe sociale, agricoltori come lavoratori urbani, spinti da diverse motivazioni. Si è stimato che questo incessante flusso di persone in cerca di opportunità coinvolse, tra il 1815 e il 1930, quasi 52 milioni di emigranti; di questi, circa 10 milioni furono italiani, secondi solo ai più di 18 milioni provenienti da Regno Unito e Irlanda. Un’emorragia che ebbe, in Italia come in Gran Bretagna, un andamento a parabola, rimanendo intensa e costante fino agli anni Trenta, per poi diminuire nel decennio successivo. Nel caso italiano, si passò dai 603.000 espatri medi annui dell’inizio del secolo, ai 70.000 del periodo 1931-40.
La parabola discendente dell’emigrazione italiana dipese in larga misura dalla combinazione tra la congiuntura internazionale e una decisa svolta nella politica migratoria. Il fascismo fu dapprincipio del tutto in linea con i precedenti regimi liberali, con iniziative volte a favorire l’emigrazione all’estero come soluzione dei problemi economici attraverso l’assorbimento della disoccupazione e l’afflusso di rimesse. Tuttavia, gli anni tra le due guerre mondiali videro l’applicazione di restrizioni sempre più severe all’immigrazione, in particolare negli Stati Uniti – meta principale degli emigranti europei – con i provvedimenti adottati nel 1921 e nel 1924, e questo contribuì al cambio di rotta che si sarebbe di lì a poco verificato. Se in Gran Bretagna si reagì con un riorientamento dei flussi migratori verso i dominions, in Italia a partire dal 1927 si iniziò a spostare l’accento sulla migrazione interna e sulle colonie. Con il «discorso dell’Ascensione», pronunciato da Mussolini il 26 maggio, il «problema demografico» passò al centro della politica fascista e l’emigrazione venne identificata come fenomeno pericoloso economicamente e politicamente.
Nata dalla necessità di individuare nuovi sbocchi per una spinta migratoria che non poteva più dirigersi in massa verso l’estero come in precedenza, e allo stesso tempo dalla volontà di non disperdere la propria forza demografica – concepita ora non più come peso ma come ricchezza e indice di potenza – tra nazioni concorrenti, la politica migratoria italiana si articolò così, a partire dalla fine degli anni Venti, secondo nuovi punti cardine: tolleranza dell’emigrazione temporanea ma non di quella stabile, regolata da criteri estremamente restrittivi; esportazione della classe dirigente – tecnici e professionisti – ma non di manodopera; assorbimento della disoccupazione di quest’ultima categoria grazie ai lavori pubblici e alle nuove opere di bonifica e colonizzazione; conseguente orientamento della spinta migratoria delle classi lavoratrici verso le aree di colonizzazione interna, come l’Agro Pontino, e l’oltremare. In questo modo l’emigrazione, diretta non più verso l’estero ma verso l’interno o le colonie, avrebbe dovuto trasformarsi da segno di crisi sociale, e implicitamente di critica, a segno di adesione alle scelte del governo e di successo propagandistico per il regime.
Si trattò di un decisivo momento di svolta nella storia dell’Italia contemporanea, una scelta politica gravida di conseguenze per gli italiani, per le popolazioni colonizzate, e per gli equilibri internazionali. L’espansione coloniale italiana fu connotata fin dall’inizio, e in particolare con la conquista della Libia, dall’esigenza di creare sbocchi migratori: il discorso colonialista italiano aveva tra le sue prime istanze la creazione di colonie di popolamento in cui insediare masse di emigranti italiani, che però rimasero teoria e propaganda, scontrandosi con le difficoltà di un dominio incerto e contrastato. Il 1927 costituì il turning point della politica coloniale italiana, perché a partire da quell’anno il regime moltiplicò le energie investite e la radicalità dei mezzi utilizzati in colonia, e con la brutale «pacificazione» della Libia e la successiva conquista dell’Etiopia poté iniziare a concretizzare l’idea di un impero settler, popolato da masse di italiani.
In realtà gli italiani non avevano mai avuto molta intenzione di trasferirsi nel «continente nero». Più in generale l’Africa, per gli europei, non era mai stata una destinazione tra le più ambite verso cui emigrare. Alla fine dell’Ottocento la meta preferita dagli emigranti britannici erano gli Stati Uniti, e dei circa 20 milioni che partirono per destinazioni extra-europee tra il 1815 e il 1914, solo il 38% si diresse verso le colonie – e più del 30% di questi scelse i dominions, soprattutto il Canada. Ad ogni modo, l’introduzione di restrizioni all’immigrazione negli Stati Uniti contribuì ad un generale riorientamento dell’emigrazione verso le colonie anche per quanto riguarda la Gran Bretagna, dove già dal primo dopoguerra – e in particolare con l’Empire Settlement Act del 1922 – i governi si erano impegnati a finanziare l’emigrazione assistita verso l’impero per ricollocare i veterani e assorbire la disoccupazione postbellica. Si assistette così ad un progressivo aumento della quota «imperiale», che arrivò a comprendere circa quattro quinti degli emigranti britannici alla metà del XX secolo.
Tale incremento del flusso migratorio verso l’impero si articolò in funzione delle prospettive economiche, e la scelta della destinazione era orientata dalle possibilità offerte in loco dal mercato del lavoro. L’India, ad esempio, principale possedimento britannico e gioiello dell’impero, non necessitava di manodopera britannica, tranne pochi elementi fra l’élite istruita (personale amministrativo e professionale di alto livello), perché la reclutava – risparmiando – tra la popolazione locale o comunque non europea; per questo nell’enorme Raj nel 1921 c’erano solo 116.000 britannici, tendenzialmente in diminuzione. Nelle grandi settler colonies in Nord America e Oceania il mercato del lavoro era completamente differente: non avendo a disposizione una sufficiente quantità di manodopera «indigena», dette colonie dipendevano in larga misura dagli stessi coloni per sostenere la propria economia; pertanto Canada, Australia, e in minor proporzione Nuova Zelanda, divennero le destinazioni principali. Per quanto riguarda le colonie africane, soprattutto dopo la Grande Guerra queste attirarono una certa quantità di cittadini britannici in cerca di fortuna, tuttavia i numeri rimasero molto bassi: Sudafrica e Rhodesia Meridionale, le più popolate, tra il 1922 e il 1935 furono meta solo dello 0,2% degli emigranti diretti verso l’impero.
Si trattava di una tendenza generale: con l’eccezione dell’Algeria, che aveva già una lunga storia di immigrazione alle spalle, le colonie africane – comprese quelle di insediamento –, anche se conobbero un incremento della popolazione europea, rimasero comunque ben poco abitate da coloni, scoraggiati da un mercato del lavoro già saturo di manodopera a basso costo e dalla difficoltà di impiantare un’attività agricola ...