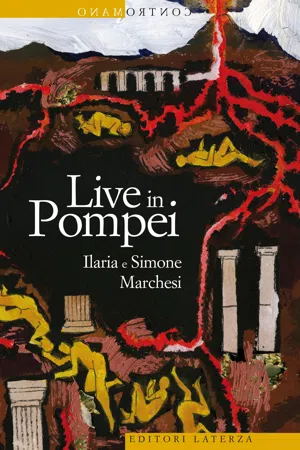Uno di questi giorni
Il gong ha suonato. Vuol dire che la colazione è pronta. Usciamo dalle camere e ci incontriamo sulle scale, i genitori ancora assonnati, i bambini che si sono vestiti in fretta e fanno di corsa i gradini davanti a noi. Ci sorridiamo scendendo giù verso la sala da pranzo. Al piano seminterrato della Villa c’è una stanza, stretta e lunga, occupata quasi per intero da una grande tavola, grande abbastanza perché ci possiamo sedere tutti lì. È una stanza senza finestre, per metà sotto il livello del terreno. Sono lì accanto anche la cucina e i locali di sgombero della Villa. E devono essere su questo livello anche le camere in cui dormono il giardiniere e il cameriere che serve la colazione. Forse dormono qui anche le altre persone di servizio della casa, ma non sono ancora riuscito a capire come sono disposti gli altri locali.
Penso di aver intravisto una di queste camere in fondo a un androne, mentre scendevo, ma non ne sono sicuro. Qualcuno doveva essersi dimenticato di chiudere la porta a vetri opaca sull’ultimo pianerottolo e ho fatto in tempo, per un attimo, a vedere che dietro c’era un corridoio con due porte per lato e una di queste era aperta. Nella semioscurità della stanza ho intravisto il bianco di una federa e un lenzuolo su di un letto rifatto con cura e accanto una sedia con degli abiti appoggiati alla spalliera. Dall’altra parte, più in alto, la lumeggiatura di una feritoia era ferma sullo schermo di una vecchia TV. Ho visto qualcosa che sembrava la camera di qualcuno che vive su questo piano, anche se non so esattamente cosa ho visto. Di solito sono piuttosto bravo a intuire da fuori come funzionano le case dentro, specie quelle della fine del secolo scorso, ma con questa ho qualche problema. Ci sono parti che resistono ad ogni ipotesi di congruenza tra facciata e interni, tra finestre e camere, balconi e corridoi. Specie al piano che è affondato per metà sotto la linea di terra. Non è una casa confusa, ma è una costruzione che un po’ mi confonde. Lascio stare le ipotesi, quindi, mentre scendo le scale. Specialmente perché ho fame, stamattina.
La mattina ho sempre fame, penso, ma mi correggo subito, mentalmente. Lo so che l’appetito che mi ha fatto alzare dal letto stamattina e dire a Virginia di sbrigarsi a vestirsi per scendere giù a fare colazione non è fame. E devo ogni giorno ripetermi che, se chiamo ‘fame’ questa cosa che provo la mattina, significa che sono stato piuttosto fortunato. Se il digiuno più lungo che conosco è quello che viene interrotto dalla colazione, dal mio breakfast quotidiano, significa che nella mia vita la fame vera non l’ho mai provata. E questo vuol dire anche che la mia abitudine a chiamare fame quello che non è altro che un minimo appetito è una brutta abitudine. Ed è potenzialmente un’abitudine pericolosa, perché può abituarmi a credere di sapere cosa sono le stanze che si aprono nei corridoi oscuri di questa casa e di essere in grado di parlare di chi le abita dicendone la verità. E così, per rispetto della verità di chi si trova a vivere in quelle stanze e in quei corridoi che non ho dovuto vedere, e quindi per rispetto di una verità che non ho il diritto di pensare che sia anche la mia, ogni mattina mi ricordo di non chiamare fame il mio appetito. Perché non è, semplicemente, vero che ogni vita sia uguale ad ogni altra. Me lo ripeto anche oggi, mentre scendo con gratitudine le scale verso il piano più basso della casa per la colazione.
La sala dove ci troviamo a convergere tutti corrisponde a una sezione dell’atrio su cui si affacciano le stanze della zona giorno: gli uffici dell’amministrazione, alcuni studi che si trasformano in camera quando la Villa ha fatto il pieno di ospiti, la biblioteca, i bagni. L’altra metà del corridoio è, in pratica, la sala dei seminari. Ma questo avviene al piano nobile; noi siamo sotto, con il basso soffitto a volta a fare da sostegno al pavimento della stanza in cui adesso non c’è nessuno, perché siamo tutti qui intorno alla tavola apparecchiata per noi. Mi rendo conto subito che, come il registro delle presenze, anche la colazione alla Villa parla più di una lingua, o almeno che chi l’ha preparata per noi è una persona pronta a dialogare con le diverse inflessioni dell’appetito degli ospiti del centro. Ci sono fette di pane fresco accanto a ciotole con i cereali, vasetti di marmellata e miele insieme a sale, pepe e bottiglie di ketchup, succhi di frutta alternati a bricchi di latte. I bimbi sono felici di poter scegliere. E sanno scegliere molto bene. Ognuno di loro ha già un palato che conosce almeno due lingue.
Faccio qualche conto, mentre li guardo servirsi: dei quattordici bambini che si sono già seduti intorno al tavolo, e i più piccoli ai quali stiamo ancora spalmando la marmellata sulle fette biscottate o versando il latte nelle tazze, due sono vissute per un terzo della loro vita in Inghilterra; una ha la doppia cittadinanza italoamericana; una è nata in Olanda da genitori italiani e vive in Svizzera; due abitano nell’Italia del Nord, ma passano ogni anno un mese d’inverno in un diverso paese del Sudamerica; altri due hanno fatto finora tutte le scuole in lingua tedesca. Quasi ciascuno di loro parla correntemente un’altra lingua oltre all’italiano e sa essere bambino in un’altra cultura. E questo, a quell’età, significa semplicemente che ciascuno di loro sa funzionare perfettamente in due mondi.
E non è solo da come parlano che si capisce. È anche da come mangiano che si vede quanto il loro orizzonte sia diverso da quello con cui siamo cresciuti noi genitori. Si vede che forse hanno meno bisogno di noi di fare esperienza del mondo antico come un’occasione per imparare a sentirsi a casa in un altro ‘dove’ o in un altro ‘quando’, un esercizio di domesticazione che, invece, è stato per me disciplina quotidiana in vent’anni di vita all’estero. Ora, a guardarli fare colazione e muoversi agilmente tra le uova con la pancetta e le fette biscottate con la marmellata, tra lo yogurt col miele e il pane col formaggio, tra i biscotti e i succhi di frutta, tra i resti di una cultura basata su olio, grano e vino e il trionfo di un’altra basata su latte, carne e birra, mi sembra che per loro il bisogno di fare quell’esperienza davvero non esista.
***
Comunque il pane è una gran bella invenzione e, prima o poi, bisogna che gliene parli, ai bimbi, di quanto è importante – anche se forse lo sanno già, o, comunque, l’hanno visto da subito. Per partire presto bisogna alzarsi presto, gli ho detto ieri sera e loro hanno capito. Così, mentre i genitori hanno fatto un grosso sforzo, ogni giorno, per presentarsi a colazione, i bimbi li abbiamo trovati sempre puntualissimi, seduti già a tavola, pronti per il loro pane quotidiano. Certo non è solo il pane ad attirarli: parte del merito va al companatico. Specialmente, sospetto, a quei barattoloni di Nutella che troviamo disposti sulla tavola affettuosamente apparecchiata e a quella continua produzione di uova al tegamino e in camicia che arriva dalla cucina. Ma è giusto così: ci sarà bisogno di energia anche oggi.
In autobus, dopo colazione, attraversiamo di nuovo tutto il golfo, costeggiando Napoli dall’alto della bretella autostradale tra Soccavo e il Vomero. Ci vuole un po’ per raggiungere Pompei da Cuma, ma il tempo mi serve per fare qualche programma. E poi la strada è sgombra stamattina e il passaggio tra il Vesuvio e il mare è libero. Mentre ci avviciniamo alla città morta dalla parte di Portici e Torre Annunziata, mio marito attacca discorso con l’autista, il signor Franco, che guida il pullman per la Sibylla Tours. Gli chiede come vanno gli affari, se si lavora molto di questi tempi e con chi. Soprattutto con le navi da crociera, risponde Franco, anche se non è più come una volta, che oggi per lavorare ci sono armatori che fanno prezzi stracciati e viaggia certa gente, oggi, che non si crederebbe. Vaticina per luoghi comuni, pensiamo. Ma è solo all’inizio; poi si scalda e comincia a parlare dei gruppi che porta più lontano, con le parrocchie, e dice che lo faranno diventare ateo, prima o poi, questi viaggi da Padre Pio e dalla Madonna delle Quattro e Mezzo a Medjugorie. Anche lì non è più come una volta, aggiunge. Ma stavolta non sembra un luogo comune; perché stavolta parla e dice che chiudono tutti, anche a Lourdes e a Fatima, non solo gli altri: chiudono gli alberghi dei pellegrini, perché ne arriva il cinquanta per cento in meno adesso; chiudono, uno dopo l’altro, nel giro di pochi anni. Vogliamo parlarne? E si risponde da solo: parliamone, dice, con lo sguardo fisso alla strada. È un disagio che può dare dipendenza, conclude. Non capisco che cosa vuol dire, e forse ho sentito anche male, ma non c’è tempo per seguirlo anche qui. Devo tornare a concentrarmi e pensare a dove possiamo andare oggi. Il piano è di passare al setaccio le regioni che non abbiamo toccato ieri. C’è ancora molto da fare e, mentalmente, organizzo gli spostamenti. Non è sempre facile: alcune vie sono chiuse, transennate, e ci sono passaggi che diventano obbligati.
È per questo che, quando siamo di nuovo sugli scavi, ci troviamo a ripercorrere delle strade che avevamo già fatto e i bimbi le riconoscono. Su via dell’Abbondanza ci fermiamo davanti alla Fullonica di Stefano. È chiusa anche questa: peccato. In restauro, dice. Sarà per un’altra volta, dico. Speriamo. È davvero un peccato, però. Ci tenevo che la vedessero, perché era piaciuta molto, ai bambini, l’idea che ci fossero grandi vasi fuori della porta, a disposizione dei passanti per farvi la pipì, quella pipì che serviva ai lavandai per smacchiare i vestiti. Era la loro Varichina, il loro Oxiclean, l’Omino bianco, lo Smacchiatutto. È bello andare in giro con i bambini. I loro genitori cercano la strada dei lupanari o, con la scusa di uno scorcio archeologico, si portano a casa l’immagine di qualche ragazzona del Nebraska con poca stoffa tra maglia e bermuda. Loro, invece, mi continuano a chiedere di pipì e popò. Saltano da una pietra all’altra nei punti di attraversamento delle strade, facendo finta di dover schivare gli escrementi dei cavalli antichi, sbarrano gli occhi nell’apprendere che c’è chi studia le feci trovate nelle fogne di Ercolano per scoprire le abitudini alimentari della zona; impazziscono di gioia quando arriviamo alle latrine delle terme, e vedono come i romani, così loro chiamano questi pompeiani antichi, sedevano lì, uno accanto all’altro, a conversare amabilmente fra loro, mentre liberavano l’intestino.
***
Certo che i bambini, a volte, sono strani, penso. Il primo giorno, mentre visitavamo l’acropoli di Cuma, ne ho visti due accucciati che raschiavano il terreno dove finisce la piattaforma del Tempio di Giove. Erano Virginia e Guia. Quando mi avvicino, vedo che stanno accumulando su di un frammento di corteccia di pino le briciole di terra che hanno scavato con un grosso chiodo. Parlano fra loro, ma c’è troppo vento e non sento che cosa si dicono. Allora mi accosto e chiedo che cosa stanno facendo. Mi rispondono, con grande semplicità, che stanno giocando all’orfanotrofio dei vermi. Non sono sicuro di aver capito di che gioco si tratti, ma non voglio insistere. A volte, con i bambini, davvero è meglio non chiedere. Ma non chiedo niente, anche perché ho visto meglio il pezzo di metallo con cui stanno scavando. Non è un chiodo qualunque: è lungo una decina di centimetri, a sezione quadrata, ed ha la testa a tronco di piramide. È decisamente antico. Forse non è romano: la città è stata viva, passando di mano in mano tra greci, etruschi, campani, romani, bizantini e saraceni, fino al Medioevo. Ma è sicuramente antico. Che fare? Chiamo da parte mia moglie e il padre di Guia; espongo il problema. Quale lezione vogliamo dare ai nostri figli?
È più significativo che questo reperto, uno tra mille che lo scavo può ancora produrre, renda per loro più viva e più vera l’esperienza che stanno facendo? È più importante, cioè, che Guia e Virginia siano ricompensate in qualche modo per il piccolo lavoro che hanno fatto, archeologhe oggi per gioco? È utile mostrare loro che ci può essere un frutto concreto, un oggetto in cui condensare l’impegno che hanno messo a giocare, costruendo così un legame effettivo tra il passato e il presente in cui vivono? Oppure è più giusto insegnare che questi oggetti che vengono dal passato non appartengono a nessuno di noi in particolare, neppure a chi li trova giocando a scavare l’orfanotrofio dei vermi nel terreno accanto al Tempio di Giove? Che sono, piuttosto, patrimonio di tutti e che ci sono persone più esperte di noi che li usano per capire il passato, istituzioni che sono preposte alla loro conservazione e programmi attraverso i quali chiunque sia interessato può avervi accesso? Che, cioè, se archeologi, sovrintendenze e musei esistono, è appunto per difendere i beni comuni dall’appropriazione privata, per far sì che ciò che appartiene a tutti sia davvero condiviso?
La decisione non è difficile. Non sarebbe, cioè, difficile, se il chiodo lo avesse trovato uno di noi adulti. Ci blocca solo un po’ l’idea che, se le invitassimo a fare la cosa giusta, l’entusiasmo che ha preso Guia e Virginia quando si sono trovate fra le loro mani di bambine un pezzo minuscolo di storia, così come si è acceso, ecco, quell’entusiasmo potrebbe anche spegnersi. Ma se sono abbastanza grandi per provare l’emozione della scoperta, concludiamo, sono anche abbastanza grandi per capire le ragioni di un ‘no’ motivato, opposto al loro desiderio di tenere il chiodo in questione.
Così spieghiamo le ragioni per cui non sarebbe giusto portarsi a casa quel reperto. Piuttosto, le invitiamo a marcare con un legnetto il luogo dove hanno scavato, tornare verso la piccola baracca di legno, dove, salendo, avevamo visto un custode ripararsi dal sole, e consegnare a lui quello che hanno trovato. Ed è questo quello che fanno, ubbidienti e comprese. Noi adulti restiamo indietro, volontariamente: questa cosa sta a loro portarla in fondo. Le vediamo da lontano scendere giù verso la baracca, richiamare l’attenzione del vecchio custode, parlare per un attimo con lui tendendogli la mano, poi voltarsi e tornare di corsa sui loro passi, con un sorriso di perfetta letizia sul volto. Non facciamo neanche in tempo a chiedere come è andata. «Ci ha detto che lo possiamo tenere!», ci gridano da lontano. «È nostro: lo possiamo tenere!». E vabbè: noi ci abbiamo provato. E poi, come bilancio del primo giorno, non è male.
***
Ma questo era il primo giorno, quando c’era un sole che spaccava le pietre. Un sole estivo inaspettato, che ha sbruciacchiato le teste pelate dei babbi, e colorito il viso dei miei bimbi mentre eravamo sugli scavi. Oggi nuvole sparse fanno da ombrello e facilitano il cammino. A un tratto, però, viene giù uno scroscio d’acqua incredibile, che ci sorprende proprio mentre stiamo entrando nella Casa del Principe di Napoli. I turisti intorno si dileguano; sciamano, correndo, non so dove. Forse in quello spaventoso autogrill che qualcuno ha avuto la brillante idea di costruire lungo la strada che porta al foro o, meglio, di incastrare in mezzo a pietre bimillenarie, accanto all’Arco di Nerone, al confine tra la Regione VI e la VII, con le cucine praticamente a parete con le Terme del Foro.
È un autogrill con tutti i crismi, tale e quale a quelli che trovi in autostrada. Preciso sputato. Sono gli stessi anche i panini e le vaschette del gelato. Un obbrobrio architettonico che il Ministero dei Beni Culturali ha tentato di difendere come ‘servizio indispensabile’ per i visitatori e di cui si compiace il direttore generale del gruppo Autogrill SPA quando afferma che, e cito, «l’importanza di un sito come quello di Pompei e la sua capacità di attrarre un pubblico internazionale meritavano l’attenzione di una società come Autogrill». Mi viene da pensare all’etimologia della parola ‘meritare’. Viene dal latino mereo, lo stesso verbo che in italiano, con un latinismo crudo che abbiamo ormai perfettamente digerito, ci dà la merenda. Ecco, sono sicura – no, sicurissima – che i pompeiani quella parola non l’avrebbero mai usata in una frase come quella riportata qui sopra. Piuttosto, avrebbero potuto chiedersi che cosa avessero mai fatto per ‘meritare’ tutto questo.
Noi invece non siamo scappati. Siamo rimasti dove eravamo, per quei trenta minuti esatti di acqua torrenziale, nella Casa del Principe di Napoli. Dopo ore e ore di cammino fra la folla, fa un certo effetto essere di nuovo solo noi. Soli, con il rumore della pioggia. Approfitto di questa pausa forzata e di tutta quell’acqua che viene giù per far notare ai bimbi come funziona l’impluvium, la piscinetta al centro di ogni atrio delle case romane che raccoglie l’acqua piovana. Ne abbiamo già visti molti: semplici, a mosaici, adorni di statue, come quella del fauno, che è così piccola e insieme così potente che mette quasi soggezione. Ormai lo conoscono, dicevo, l’impluvium: all’esame ne sapranno anche sillabare il nome. Ma adesso lo vediamo in azione, e finalmente Miriam si tranquillizza. L’acqua è davvero tanta oggi, viene giù a scrosci, ma si vede che non può straripare: c’è una cisterna, sotto, che raccoglie quella in eccesso.
È bella questa cosa dell’acqua che entra in casa da un buco nel soffitto: bella per l’udito, per la vista, per il tatto. Serviva a rinfrescare l’ambiente nelle giornate estive, dicono i manuali di storia dell’architettura. Ma più che altro era bella, secondo me. I romani le case le facevano belle. Io me ne vorrei costruire una uguale, da qualche parte in Toscana. Ginevra è d’accordo: lei addirittura dice che vorrebbe essere vissuta lì. Tranne che per l’eruzione, ci tiene a sottolineare. E ci affacciamo alla porta di casa per vedere come l’acqua scorra veloce nella strada in pendenza, e la immaginiamo pulire le strade dallo sporco di cavalli ed esseri umani, quelle fogne a cielo aperto che tanto affascinano Tommaso e Camilla. E speriamo tutti che ne abbiano avute parecchie, di queste piogge torrenziali, a pulire le strade, a smussare gli odori.
Noi grandi ci disperdiamo poi fra le stanze. Qualcuno osserva dalla finestra di un cubiculum il tempietto dei Lari in giardino; altri guardano il tavolo di marmo dalle zampe di leone alato; altri ancora studiano i resti della scala che portava al piano superiore. Dopo poco, però, attirata da un silenzio durato un po’ troppo a lungo (quello della misura dei silenzi è uno dei sensi che si sviluppano da genitori), mi volto e cerco con lo sguardo i miei bimbi. Tutto a posto: non c’è nessun problema. Sono solo tutti lì nella stanza accanto, seduti in cerchio sul pavimento del salotto affrescato; stanno facendo una partita a carte, aspettando che spiova. I più grandi tengono i più piccoli in braccio e indicano, sfiorandole con un dito, le carte da giocare. Sotto secoli di storia, noncuranti di quelle teste di Medusa dietro le spalle, degli intarsi di marmo su cui incrociano le gambe, a proprio agio fra queste mura, fra Paride e Perseo. Come se trovarsi lì e compiere quei gesti fosse la cosa più naturale del mondo. E lo è, ...