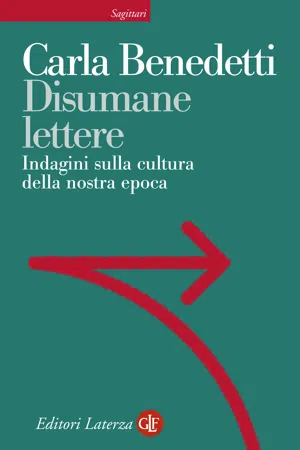1. Lo sfondo aperto
Dove si guarda il cielo e si capisce che non è un fondale. Dove si cercano antidoti all’astrazione di tante narrazioni odierne che separano le storie degli uomini dal «profondo abisso del mondo».
1. Il mondo che mi sopravanza
Da piccola facevo fatica a immaginarmi lo spazio infinito. «Ma ci sarà pure un luogo in cui finisce!» mi dicevo. «Cammina cammina, alla velocità della luce, si arriverà a un punto di arresto. Prima o poi si incontrerà come un muro di cinta che racchiude tutto». Me lo immaginavo di cemento grigio, poroso, come quelli che delimitano le proprietà, ma a forma di cubo, con anche il soffitto chiuso. «Ma poi, mi dicevo, fuori da quelle sei mura che segnano il confine estremo del mondo, che cosa ci sarà? Un vuoto, certo. E quindi un altro spazio. Il quale andrà avanti così, all’infinito... fino a che non troverà un altro muro? E allora siamo da capo». Vedevo un altro cubo, e poi di nuovo il suo esterno, che non smetteva mai di continuare.
Il mondo non può essere pensato come chiuso, perché nel momento in cui lo pensiamo tale subito si spalanca il suo fuori. Eppure, nonostante quest’impossibilità, esistono nella nostra cultura delle rappresentazioni del mondo che pretendono di racchiuderlo. Non è che lo dicano esplicitamente: «Guardate, il mondo sta tutto qui dentro», però lo implicano nelle premesse. Certi modi di pensare, di narrare e a volte persino di presagire ciò che sta per accadere, danno per scontato che non ci sia un esterno fuori da ciò che viene rappresentato.
Cosa direste di qualcuno che sostenesse che fuori dalle mura di Roma non c’è nulla? Come se un Dio cibernetico avesse disegnato i tracciati cittadini ma non quelli della campagna circostante. O di qualcuno che affermasse che tutto il pensabile è già stato pensato? O che tutto il visibile è già stato visto e ripreso, e a noi non resta che rivederne le sequenze variamente montate? Ecco una frase che ho letto su un quotidiano:
Nel cinema come nel piccolo schermo non esiste sequenza che non sia già stata effettuata. Tutto è già stato ripreso e visto. È come se non ci fosse mai una prima volta.
A dirla è Enrico Ghezzi, in un’intervista1. Sta spiegando il «fondamento teorico» di Blob, la trasmissione da lui ideata e riproposta per anni. Faccio parte dei milioni d’italiani che si sono divertiti a guardarla. Ma quella affermazione è assurda. Non è vero che tutto è già stato ripreso e visto. L’onda dello tsunami che si è abbattuta sulle spiagge asiatiche il 26 dicembre del 2004 non era mai stata ripresa prima, le immagini di Marte trasmesse dalla sonda satellite non erano state viste prima, e così le uccisioni in massa di enormi quantità di bovini all’epoca della mucca pazza, e i politici che mangiano cosciotti di pollo in diretta, e il kamikaze ripreso dalla telecamera della metropolitana di Londra pochi minuti prima di farsi esplodere, e il ministro Calderoli che si sbottona la camicia in un talk show per mostrare la vignetta proibita, stampata sulla maglietta che indossa sotto. E tutto quello che succede nel mondo di terribile, di ingiusto, di atroce, che nessuna tv e nessun giornale illumina.
Sostenere che tutto è già stato ripreso è come mettere un cubo di cemento attorno all’universo. Questo è il «fondamento teorico» di molte forme di rappresentazione del nostro tempo, non solo della televisione, anche se quest’ultima lo rivela in modo più esplicito. Essa ha questo messaggio incorporato dentro al suo stesso esistere: «Il piccolo mondo che ti mostro è tutto il mondo. Non c’è alcun mondo che mi sopravanzi».
Poiché la premessa è falsa, falsanti ne saranno anche gli effetti. Quando il mondo esterno al mezzo viene cancellato, anche i rapporti interni a quel mondo saranno in qualche modo distorti. Tutto si curva in una maniera irreale. In un mondo chiuso non c’è più niente che sia falsificabile e ogni cosa si autoconvalida. Ma è sorprendente che esista una zona del nostro mondo in cui ancora si può teorizzare che tutto è già stato visto, che tutto l’esperibile è già da noi dominato. La terra ruota nel campo gravitazionale, siamo attraversati da materia oscura, ogni cosa è in vorticoso movimento, il clima si sta modificando, la specie umana chissà per quanto tempo avrà ancora questo pianeta a disposizione, eppure c’è un piccolo mondo sotto vetro che pretende di essere tutto il mondo.
2. La finzione prima
Anche certi romanzi contemporanei sembrano chiudere il mondo dentro a un cubo di cemento.
Per spiegare concretamente cosa intendo, inizierò da un esempio contrario: da una forma narrativa non astratta ma improntata a un acuto sentimento della complessità e retta da una tensione all’inseparato. Molti dei grandi romanzi del passato potrebbero servirci da punto di partenza, perché questo tipo di astrazione narrativa è cosa del nostro tempo. Ma tra i tanti esempi possibili ne prendo uno non troppo lontano: un romanzo di Carlo Emilio Gadda scritto alla fine degli anni Trenta e uscito in volume nel 1963. Da qui poi lo sguardo si sposterà su esempi contemporanei. Lo scelgo per diverse ragioni, che si chiariranno più avanti. Ma una posso dirla subito.
La cognizione del dolore, che lessi a diciannove anni su suggerimento di una mia insegnante, mi lasciò uno strascico curioso: altri romanzieri contemporanei che mi capitò di leggere dopo mi parvero artificiosi – persino Alberto Moravia, che pure ha una scrittura piana, solitamente considerata funzionale alla narrazione. Al contrario, di Gadda si dice spesso che egli carichi la pagina di eccessive notazioni, biologiche, storiche, filosofiche, tecniche, fin quasi a far naufragare la storia narrata. Quindi, tra i due avrebbe dovuto semmai apparirmi più artificioso il secondo. Allora credevo che la mia impressione dipendesse dalla lingua, molto ricca in Gadda, assai semplificata in altri narratori contemporanei. In quegli anni, del resto, tutti celebravano l’autore della Cognizione del dolore per il suo originalissimo impasto linguistico che si allontanava dalla lingua media2 – e anche l’insegnante che mi introdusse alla sua lettura me l’aveva presentato in quella chiave: uno scrittore espressionista, autore di mirabili pastiche, trasgressore di galatei linguistici. Poco importava che fosse anche un narratore. E se gli concedevano di aver scritto romanzi era per constatare che si trattava di anti-romanzi. Anch’io fui condizionata da quell’interpretazione critica, che del resto domina ancora oggi le storie letterarie. Ma col tempo mi divenne evidente che non poteva essere quella la ragione del fascino di quel romanzo né soprattutto del senso di artificio che mi trasmettevano altri. Se fosse stata solo una questione di lingua il modo di narrare di Moravia, ad esempio, avrebbe dovuto apparirmi inespressivo, banale, ma non artificioso. Oggi me lo spiego così.
Nella Cognizione del dolore tutto accade in un intreccio di chimismi, di attività di cellule, di vita animale e vegetale, di fulmini e di altre forze inanimate della materia. L’aria e lo stesso spazio sonoro dentro a cui parlano i personaggi è zeppo, non solo di parole ma anche di tutto «il crepitio infinito della terra». Tutto è colmo. Persino il silenzio, persino la luce che avvolge ogni cosa nell’estate. Ecco un piccolo esempio. Siamo nel terzo tratto del romanzo e il protagonista sta parlando con il medico fuori della sua casa di campagna. È estate, è mezzogiorno, la luce è al suo grado massimo d’intensità, le campane suonano l’ora.
Intanto, dopo dodici enormi tocchi, le campane del mezzogiorno avevano messo nei colli, di là dai tègoli e dal fumare dei camini, il pieno frastuono della gloria. Dodici gocce, come di bronzo immane, celeste, eran seguitate a cadere una via l’altra, indeprecabili, sul lustro fogliame del banzavóis: anche se inavvertite al groviglio dell’aspide, molle, terrore maculato di tabacco. Vincendo robinie e cicale, e carpini, e tutto, le matrici del suono si buttarono alla propaganda di sé, tutt’a un tratto: che dirompeva nella cecità infinita della luce. Lo stridere delle bestie di luce venne sommerso in una propagazione di onde di bronzo: irraggiàrono la campagna del sole, il disperato andare delle strade, le grandi, verdi foglie, laboratorî infiniti della clorofilla: cinquecento lire di onde, di onde! cinquecento, cinquecento!3
Cinquecento lire è la somma che don Francisco Pirobutirro, padre del protagonista, aveva donato alla chiesa per fabbricare le nuove campane. E queste, a ogni rintocco, riaccendono il risentimento del figlio per quella esorbitante beneficenza, non dettata da devozione ma dal bisogno di marcare uno status sociale, e quindi tutta intrisa di ipocrisia – il peggiore dei peccati secondo Gadda4. L’ipocrisia del padre si estende così alle campane stesse, qui viste come bestie pazze che si lanciano alla «propaganda di sé» (in un altro passo vengono chiamate «bronzi ebefrenici»). Cinquecento lire di onde di bronzo, ipocrite, che lacerano lo spazio fino a coprire il verso delle cicale («lo stridere delle bestie di luce»).
In questo breve passo c’è in piccolo il nucleo tragico dell’intero romanzo. È il conflitto che oppone il figlio al «consorzio» umano costruito dai padri, da loro decantato come il migliore dei mondi, ma che in realtà è una società inficiata di male. Un conflitto quindi di natura sociale e familiare, che però qui esplode in uno spazio tutto gremito di altre vite, non solo umane, ivi compresa la vita vegetale che si riproduce in continuazione nei miliardi di laboratori della clorofilla ospitati dalle foglie. E tutti questi elementi, sociali e «naturali» sono tenuti assieme, in un unico grembo, non separati e ripartiti tra primo piano e sfondo. Anzi, quello sfondo di carpini, robinie, cicale, aspidi, che probabilmente in altre narrazioni non sarebbe che il fondale immobile della vicenda, qui...