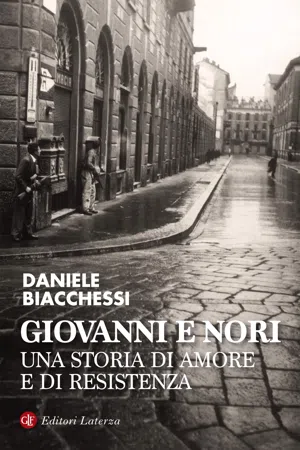Giovanni e Nori in tempo di pace
Nel dopoguerra l’Italia è a pezzi, ma è ancora viva. La guerra partigiana è stata decisiva nella Liberazione e ha guadagnato il biglietto di ritorno alla democrazia e al consesso delle nazioni civili. I vincitori, gli italiani come Giovanni e Nori che hanno combattuto per lunghi anni per essere liberi, non hanno complessi di inferiorità verso gli anglo-americani: pensano di essersi meritati il diritto di decidere del loro futuro, pensano di poter risolvere i problemi di un Paese che è devastato, ma comunque resta in piedi, con dignità.
Gran parte delle città del Nord sono distrutte. Ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali e fabbriche sono salvi e funzionanti perché gli operai li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi durante la Liberazione.
Le condizioni di vita della popolazione rimangono sotto i livelli minimi della sussistenza: miseria, fame, disoccupazione ovunque. L’economia riprende con lentezza e la nazione resta divisa in due. Nella parte settentrionale e centrale permangono sogni e speranze di cambiamento della società. I cittadini, pur nella povertà assoluta, non intendono tornare all’Italia liberale precedente al fascismo. In sostanza, al Nord gli italiani chiedono una democrazia più aperta, ma al Sud la società resta immobile. Le vecchie classi dirigenti, appoggiate dagli alleati, mantengono il loro predominio politico e sociale, in alcune regioni anche con il consenso determinante delle mafie.
La guerra si porta via un carico di distruzione, orrore, rancori. Milioni di morti, dolori e ferite mai rimarginate. E dopo la grande pioggia, pure l’aria sembra più pura, persino la natura più bella. Quanta fiducia negli uomini, quanta speranza che sia giunta finalmente l’era della buona volontà, il tempo dei disinteressati, con le ambizioni oneste, per cui gli alti uffici siano un dovere e una missione.
E invece no. Perché numerosi esponenti del regime condizionano negli apparati dello Stato il delicato passaggio verso la democrazia. Tra le decine di migliaia di impiegati e dirigenti dei ministeri fascisti, solo in 449 vengono rimossi dai loro posti di potere. Su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura; 241 viceprefetti provengono dall’amministrazione dello Stato fascista; 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali e segrete della Repubblica di Salò; 139 vicequestori sono entrati in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla Resistenza.
C’è molto di più. Nell’immediato dopoguerra, i servizi segreti americani arruolano i criminali nazisti responsabili delle stragi di piazzale Loreto a Milano e delle Fosse Ardeatine a Roma, in funzione anticomunista: i casi di Theodor Saevecke, Karl Hass, Karl-Theodor Schütz sono emblematici.
I partigiani tornano a casa, riprendono la vita normale, si impegnano alla ricostruzione democratica del Paese. In particolare, Giovanni e Nori confermano il loro impegno politico e l’iscrizione al Partito comunista italiano non più clandestino. Sono momenti di smarrimento per Giovanni Pesce.
Per noi, pur nell’esultanza del sogno che avevamo lungamente atteso, che avevamo sofferto con struggimento senza fine, non era facile cambiare vita, abitudini, riacquistare in pochi minuti, in qualche ora, la disinvoltura, la naturalezza che l’imminente insurrezione ci prometteva, noi che l’insurrezione avevamo preparato di lunga mano quando ancora le divise della Wehrmacht torreggiavano insolenti dai carri armati e sembravano invincibili.
Giovanni vorrebbe tornare subito a La Grand’ Combe, magari per lavorare ancora in miniera, ma l’amore per Nori, la sua più bella staffetta, e il desiderio di cambiare l’Italia lo trattengono a Milano. Così Giovanni propone a Nori di sposarsi e lei accetta con entusiasmo, senza alcuna esitazione. Le nozze si celebrano con rito civile il 14 luglio 1945, l’anniversario della presa della Bastiglia, in onore dei trascorsi francesi di Giovanni. Non possiedono niente, solo la gioia per la ritrovata libertà e la speranza per il nuovo percorso di vita da compiere insieme. Sono senza una lira, ma quel giorno sono felici. Si sposano in un edificio accanto a Palazzo Marino, devastato dai bombardamenti. L’abito di Nori è frutto del paziente lavoro della sorella Wanda, sarta molto apprezzata. Quello del primo sindaco socialista di Milano Antonio Greppi è un intervento appassionato e interminabile, davanti ai gappisti e ai testimoni Francesco Scotti Grossi, comandante generale delle brigate Garibaldi in Piemonte, e Giovanni Nicola, membro del Triumvirato insurrezionale piemontese. Il pranzo e la successiva festa si tengono nella Casa del Popolo della sezione Venezia del Partito comunista italiano, in via Andrea del Sarto. Il menù è preparato con cura e dedizione da Maria Brugnoli Tatiana, la madre di Nori, e da alcune compagne che compiono un vero miracolo gastronomico. La foto scattata al termine del banchetto nuziale ritrae Giovanni con un elegante completo grigio, una raggiante Nori avvolta nel vestito bianco e alcuni dei gappisti più importanti della storia della Resistenza di Milano e Torino. Gli sposi vanno ad abitare nell’appartamento di via Macedonio Melloni 76, a Milano, dove è nato il loro incontro durante l’occupazione tedesca e la dittatura fascista.
Mentre la coppia si ritaglia alcune settimane di riposo a Visone d’Acqui, l’11 agosto 1945, Renzo Novelli, uno degli ex gappisti più vicini a Giovanni, viene ucciso in uno scontro a fuoco con i carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria di Milano. Si recano in borghese nell’abitazione di Renzo Novelli, in via Triboniano 9, per eseguire un mandato di cattura per il duplice omicidio di due fascisti, avvenuto due giorni prima a Marmirolo, in provincia di Mantova. I due carabinieri suonano il campanello, Novelli li scambia per sicari fascisti, spara a ripetizione contro la porta e gli investigatori cadono fulminati sull’uscio di casa. Un terzo carabiniere, rimasto in cortile di copertura, ferisce Novelli a colpi di pistola in più parti del corpo. Dopo il conflitto a fuoco avviene però un fatto strano: gli ex gappisti Riziero Galli e Alfredo Sinistro accorrono in soccorso di Renzo Novelli che versa in gravissime condizioni. Per guadagnare tempo prezioso, lo trasportano all’ospedale utilizzando l’autolettiga militare con cui i carabinieri avevano raggiunto il quartiere di Musocco.
Galli e Sinistro controllano per mero scrupolo le carte di circolazione del mezzo e in una busta viene alla luce un documento di polizia giudiziaria, firmato dal maresciallo dei carabinieri Battaglia, con cui si autorizza il trasferimento di una generica salma da Acqui Terme a Milano. Ad Acqui Terme è in vacanza Giovanni Pesce. Lo scenario è a dir poco inquietante e mai chiarito: qualcuno voleva certamente assassinarlo. Con ogni probabilità i presunti killer intendevano utilizzare Renzo Novelli come esca per catturare e uccidere Giovanni Pesce. I mandanti di questa orribile messa in scena non sono mai stati individuati.
Sono i mesi in cui l’azionista Ferruccio Parri Maurizio guida il primo governo democratico del dopoguerra. È un esecutivo di unità nazionale, sostenuto da Democrazia cristiana, Partito comunista italiano, Partito socialista italiano di unità proletaria, Partito d’Azione, Partito liberale italiano, Partito democratico del lavoro. In sostanza, almeno sulla carta, è l’espressione diretta del fronte antifascista che esce vincitore dalla guerra di Liberazione. Si trovano per la prima volta insieme al vertice della nazione, Pietro Nenni (vicepresidente del Consiglio), Giorgio Amendola (sottosegretario alla presidenza del Consiglio), Alcide De Gasperi (Affari esteri), Palmiro Togliatti (Grazia e Giustizia). Il governo Parri è lacerato dagli scontri tra sinistra e liberali, ma riesce comunque a varare i primi provvedimenti economici: l’epurazione finanziaria per i profitti di regime, una tassa sul capitale, il risarcimento in dollari pagato dagli Stati Uniti per le truppe d’occupazione. Il governo resta in carica dal 21 giugno al 24 novembre 1945. Gli Stati Uniti criticano i provvedimenti di politica economica di Parri; democristiani e liberali si schierano con gli americani e abbandonano i loro incarichi nei ministeri; la sinistra accusa il governo di immobilità, non decisionismo, incapacità di spingere l’azione politica sul terreno delle riforme. Alla fine Ferruccio Parri si dimette.
Pci e Psiup intendono mantenere un buon rapporto con la Dc e accettano l’esclusione di Parri dalla presidenza del Consiglio. E sul nuovo compromesso politico nasce il primo governo presieduto da Alcide De Gasperi. Restano nell’esecutivo Pietro Nenni alla Costituente, Palmiro Togliatti alla Giustizia, ma il sogno partigiano ormai si è frantumato.
Per quelli come Giovanni Pesce e Nori Brambilla è una dura sconfitta.
Nel frattempo il 17 febbraio 1946, Giovanni Pesce diventa presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di Milano. Il suo compito è assai difficile. Con l’ausilio del vicepresidente Tino Casali, Giovanni deve garantire il reintegro dei partigiani nel mondo del lavoro e nella nuova società democratica, aiutare le famiglie dei resistenti caduti nel conflitto bellico, contrastare l’esclusione dei liberatori dai luoghi di potere e combattere l’inserimento dei fascisti nelle strutture pubbliche e nelle cariche dello Stato. E, ancora, deve frenare le spinte violente di alcune frange minoritarie ma agguerrite di partigiani che si sono rifiutati di consegnare le armi agli alleati e nello stesso tempo mediare le diverse posizioni politiche presenti all’interno dell’Anpi, che sfoceranno nella scissione della componente democristiana e cattolica e nella fuoriuscita di Ferruccio Parri e degli azionisti.
Poco dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 in cui vince la Repubblica, l’Anpi di Giovanni Pesce deve anche fare i conti con l’amnistia ai fascisti. Il 22 giugno 1946, il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti emana un provvedimento di condono per i reati con una pena detentiva non superiore ai cinque anni, per quelli commessi da fascisti e partigiani dopo l’inizio del governo militare alleato, per i delitti avvenuti dopo l’8 settembre 1943 nel territorio rimasto sotto l’amministrazione del governo legittimo italiano. Togliatti intende così realizzare un atto di pacificazione a guerra finita, ma con molte eccezioni e limitazioni.
Si trattava prima di tutto di staccare il paese e alcune autorità di esso da quell’atmosfera di lotta, anzi di guerra civile, cui erano ancora in gran parte ispirati i giudizi che venivano pronunciati in quel tempo. Si trattava in secondo luogo di iniziare una larga azione di conquista alla democrazia di uomini, di giovani soprattutto, che noi sappiamo che avevano commesso atti condannati e condannabili, ma che avevano però diritto a parecchie attenuanti, soprattutto nel momento in cui si trattava di allargare il più possibile le basi del nuovo Stato repubblicano.
In realtà, nel tempo, l’amnistia sarà interpretata dalla Corte Suprema di Cassazione e dai Tribunali ben oltre le intenzioni del legislatore e applicata sempre a favore dei fascisti.
Nel Paese nasce un risentimento radicale.
L’epicentro della rivolta è nelle province di Asti e Cuneo, ma moti di ribellione si verificano anche in Valle d’Aosta, Liguria, Veneto e Lombardia. La scintilla che innesca la protesta è l’allontanamento dalla polizia di Asti del capitano Carlo Lavagnino, ex comandante delle formazioni garibaldine. La notte del 20 agosto 1946, una sessantina di uomini, fra ex partigiani e ausiliari, si dirige verso Santa Libera, vicino a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Li guidano Armando Valpreda, nome di battaglia Armando, già nella brigata Rosselli della I divisione alpina Giustizia e libertà del Cuneese, e Giovanni Rocca Primo. Il quartier generale del gruppo si insedia nel rudere di un’antica torre, sopra Santa Libera. I ribelli organizzano posti di blocco con mitragliatrici pesanti. Sono dotati anche di armi individuali, perfettamente oleate e mai riconsegnate alla fine della guerra. Il colpo di mano suscita un notevole clamore politico. Il 21 agosto 1946, il ministero dell’Interno fa convergere sul posto un battaglione di fanteria, con pezzi di artiglieria e mortai, ma il prefetto di Cuneo Renato Pascucci sceglie la strada della trattativa.
Altri gruppi partigiani seguono l’esempio di Santa Libera. La ribellione si allarga in Val Felice, Bagnolo Piemonte, Monastero di Lanzo. A La Spezia, il comando dei rivoltosi viene assunto da Paolo Castagnino, maresciallo ausiliario di Pubblica sicurezza.
Si muovono anche i partigiani dell’Oltrepò pavese. Angelo Cassinera Mufla, Luigi Bassanini, Vittorio Meriggi e Luigi Vercesi si insediano con i loro uomini a Brallo, una località montana dell’Alta Valle Staffora, al confine fra le province di Pavia e di Alessandria. Posseggono mortai, mitragliatrici, pistole, esplosivi e un autoblindo.
Il 23 agosto 1946, ad Aosta, 300 ex combattenti e internati, insieme alla popolazione civile, assaltano il carcere e tentano di liberare i resistenti detenuti.
A Casale Monferrato, viene indetto uno sciopero generale spontaneo contro la revisione della sentenza di condanna di sei fascisti, tra cui l’ex segretario del Pnf locale Giuseppe Suardi. Intervengono polizia, carabinieri ed esercito. Solo la mediazione del segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio evita la rivolta armata.
Il 29 agosto 1946, a Pallanza, in Piemonte, in 200 entrano nelle carceri, disarmano le guardie e liberano tre loro compagni arrestati per un omicidio politico a Viareggio.
Al governo, i ribelli chiedono la revoca dell’amnistia, l’allontanamento dall’impiego di tutti gli ex fascisti, l’assunzione dei partigiani con precedenza assoluta, miglioramenti salariali per gli ausiliari, l’unificazione dei corpi di polizia con riconoscimento dei gradi partigiani, la soppressione dell’«Uomo qualunque» e il processo per Guglielmo Giannini, ritenuto diffamatore dei partigiani.
La trattativa è serrata e impegna tra gli altri Pietro Secchia, Celeste Negarville detto Nega, il capo redattore de «l’Unità», Davide Lajolo Ulisse, l’avvocato Felice Platone Gamba, l’allora redattore della terza pagina de «l’Unità», Raf Vallone, deputati comunisti nazionali e locali.
Il vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni garantisce l’approvazione del decreto che equipara i partigiani ai volontari di guerra e riconosce i gradi militari ai fini amministrativi.
Giovanni Pesce convoca subito l’Ufficio di presidenza dell’Anpi: giudica quelle manifestazioni come provocazioni avventuristiche, perché le sedi naturali dove porre le critiche all’amnistia di Palmiro Togliatti restano comunque i partiti, i sindacati e l’Anpi. Al di là degli interventi pubblici, sotto traccia permane il malcontento di Giovanni.
Non era tollerabile che una decisione assunta per cercare di gradualizzare le pene e portare il Paese verso ...