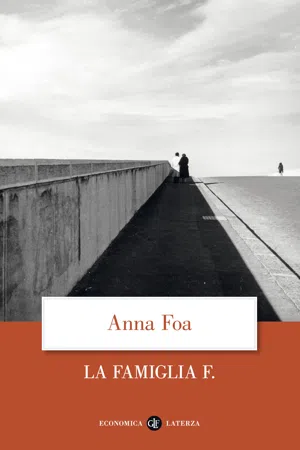«La città dove par di sentire ruggire i leoni»
Con il dopoguerra, ricominciava la vita politica. Ed essa aveva una sua sede naturale: Roma. La capitale, la città dove avevano sede i ministeri, il Parlamento, i partiti. Vittorio divenne uno dei leader del Partito d’Azione, con Lussu, La Malfa, Reale e Spinelli, e partecipò attivamente alla sua breve vita politica. Come il nonno Giua, anch’egli eletto all’Assemblea nazionale costituente, ma per il Partito socialista. In quei due anni, fra il 1945 e il 1947, fu quasi sempre a Roma. Furono anni difficili in cui si gettarono le basi degli sviluppi successivi della politica italiana. Il governo azionista di Parri durò solo fino al dicembre 1945, poi gli subentrò un governo di ampia coalizione diretto dal leader della Democrazia cristiana, De Gasperi. Nel 1947 si sciolse il PdA, con una diaspora dei suoi membri nei vari partiti. Vittorio entrò nel Partito socialista. Nello stesso 1947 i ministri comunisti furono espulsi dal governo. Cominciava la Guerra Fredda, le cui prime avvisaglie già si erano viste chiaramente ancora nel corso della guerra.
Sono anni che, nella sua autobiografia, Vittorio ricorda come un periodo «non luminoso». La militanza dentro il PdA gli era sembrata, uscito dal carcere, un prolungamento naturale degli anni di prigionia. Con il venir meno del Partito d’Azione, ricordava, venivano meno anche molte delle illusioni della Resistenza. Ma, nella sua interpretazione più tarda, non era questione, o almeno lo era solo in parte, di un tradimento dell’antifascismo. La colpa la attribuiva, da vecchio, anche al Partito d’Azione, stretto in un’ambiguità fondamentale tra la costruzione di una democrazia «esente dai compromessi e dalle viltà della vecchia democrazia liberale» e l’uso senza remore degli strumenti della democrazia tradizionale. Gli sembrava, ripensandoci, che fosse cambiata la natura della politica, ridotta a mera tecnica anche per loro che avevano vissuto il fascismo in galera. Era diventato un professionista della politica. «Ci dividemmo allora – scrisse nel 1967 – tra chi credeva nella tecnica politica e chi riaffermava il valore della poesia e della verità. E cademmo tutti insieme, i poeti (come Carlo Levi, Emilio Lussu, Guido Dorso e Ferruccio Parri) e ‘i tecnici’». Da vecchio scriveva di essere diventato anche lui partecipe di un’idea della politica come tecnica, e non come verità e moralità: «E questo spiega il mio disagio, il mio smarrimento di quel tempo, l’effetto di sterilità di correre sempre, ogni momento, dietro il contingente. Spiega perché mi sono sentito così orfano per la fine del Partito d’azione». Diverso il giudizio che dava della stagione dei lavori della Costituente, un momento felice dove i partiti si scontravano duramente fra loro ma anche partecipavano insieme al progetto di una nuova Italia.
Per Vittorio, almeno nella sua riflessione successiva, il Partito d’Azione avrebbe continuato a vivere in lui come una metafora della ricerca, come un criterio di distinzione etica, nonostante le ambiguità che gli riconosce. Aveva difficoltà, per questo, a capire gli attacchi che negli anni Novanta ed oltre vennero rivolti al PdA come se fosse stato il baluardo dello stalinismo nell’Italia del dopoguerra. Perché proprio noi che cercavamo una via mediana e non siamo mai stati comunisti?, si domandava, pur sapendo benissimo che forse era proprio questa la ragione per cui erano attaccati: spesso vengono attaccati coloro che cercano una terza via.
A Roma, in quei primi anni della Costituente, Lisetta aveva difficoltà ad adattarsi. Si sentiva «straniera», e si stupiva per l’aspetto «quasi gaudente» della città, contrapposto all’austerità della Torino del dopoguerra. Risale a questo periodo una lettera della nonna Lelia indirizzata alla figlia Anna, negli Stati Uniti, in cui descrive Vittorio «come uno zingaro», noncurante, nonostante la famiglia e i due bambini, di trovarsi un posto stabile e remunerato, insomma un po’ sciagurato. Quando, dopo una visita a Boston a mia zia, ho portato la fotocopia di questa lettera a mio padre, ne è rimasto molto stupito. Allora era stato eletto alla Costituente, aveva una carriera politica davanti a sé. Credeva che la sua famiglia fosse fiera di lui, di quello che stava facendo, anche in termini di successo personale, e invece si trovava descritto come un disoccupato. Eppure, i suoi genitori non erano chiusi alla politica. Quando Vittorio era in carcere non lo avevano mai spinto a chiedere la grazia, nemmeno quando si ammalò di morbo di Basedow, e lui gliene fu sempre grato. Ma anche nelle sue lettere del 1945-1946, alcune indirizzate al cugino Piero, traspare un’incertezza di fondo: incertezza sulla vita politica in Italia, perché teme ancora il ritorno di un regime autoritario, e incertezza anche sulla sua vita randagia tra Roma, Milano, Torino, e sulle sue stesse scelte lavorative. «Vivo senza prospettive – scrive – risucchiato irresistibilmente dall’attività politica». In fondo, che sua madre lo vedesse come «uno zingaro» non mi stupisce, dal momento che era la percezione che lui stesso aveva di sé in quel momento. Forse più tardi se ne dimenticò.
Per cogliere il clima della Roma di quegli anni più che ai ricordi miei o della mia famiglia ho attinto a un libro straordinario, scritto proprio in quel periodo non da un politico, ma da un artista, Carlo Levi: L’Orologio. Il libro si apre proprio con il ruggito dei leoni: «La notte, a Roma, par di sentir ruggire leoni. Un mormorio indistinto è il respiro della città, fra le sue cupole nere e i colli lontani, nell’ombra qua e là scintillante; e a tratti un rumore roco di sirene, come se il mare fosse vicino, e dal porto partissero navi per chissà quali orizzonti. E poi quel suono, insieme vago e selvatico, crudele ma non privo di una strana dolcezza, il ruggito dei leoni, nel deserto notturno delle case». In questa Roma, si muovono i politici nel 1945, gli azionisti eletti alla Costituente. Levi ritrae due di loro, Fede e Roselli. Fede è Vittorio, Roselli è Altiero Spinelli. Carlo Levi e Vittorio erano vecchi amici e compagni di antifascismo. Nel maggio 1935 erano stati arrestati insieme, poi Vittorio era finito in carcere e Levi al confino. Un mese prima di essere arrestato, come si è già detto, Vittorio era stato ritratto da Carlo Levi, un ritratto bellissimo con il volto già tirato dalla consapevolezza che la polizia era sulle sue tracce. Ora, Levi lo ritrae ancora, questa volta con la penna e non con i pennelli:
«Fede [...] era piccolo, sottile, fragile, con un viso allungato e trasparente, scintillante del brillio degli occhiali, un naso appuntito, diritto in mezzo alle guance pallidissime, come una sentinella in un campo coperto di neve. Sotto, si apriva una bocca minuta dalle labbra arcuate e carnose: il mento, robusto, era spaccato in mezzo da una fossa. Aveva un’aria concentrata, attenta, come di chi abbia per le mani una pistola carica; e, quando taceva, non pareva ascoltare o riposarsi, ma badare piuttosto a far sì che il grilletto della sua arma non scattasse inavvertitamente. E l’arma c’era davvero, e pericolosa; perché, quando parlava, non era un colpo di pistola, ma una scarica di mitragliatrice, anzi un fuoco multiplo e incrociato di tiri arcuati che non si capiva di dove venissero. Questa abilità, questa astuzia della mente, che lo portava a nascondere gli argomenti per tirarli fuori improvvisi nel momento più inaspettato, che lo faceva girare attorno ai concetti, attorcigliandoli in matasse e in gomitoli e sciogliendoli a un tratto, come un pescatore di trote che avvolge paziente la lenza sul verricello con mossa annoiata e monotona e poi lancia lontano, con subita violenza, gli era naturale. Ma la natura era rafforzata dalla volontà. Nelle sue meditazioni su quel cielo della politica dove ora spaziava, egli pensava di averne scoperte le leggi, immutabili e eterne; dure, machiavelliche leggi alle quali si confermava con sicurezza entusiasta, come un eroe di Stendhal.
E molto più egli aveva del Julien Sorel quando doveva, per qualche breve istante, volger gli occhi a qualcosa di diverso da quel suo cielo politico. Come chi aveva poco vissuto ed era stato privato, sotto una campana di vetro, degli anni migliori, egli sentiva un bisogno irresistibile di vivere, di vivere in fretta, di rifarsi del tempo perduto, di invecchiare, di raggiungere la propria età, come un soldato rimasto indietro in una marcia, che corra lungo il reggimento per ritrovare il proprio posto nella fila. Ma proprio la troppa fretta, l’ansia di esperienza, gli impediva di vedere le cose e di riuscire veramente a toccarle; come un affamato che inghiotta in furia, tutti insieme, i cibi di una grande tavola, senza poter distinguere il gusto di nessuno».
Non è il ritratto, davvero, di un professionista della politica, troppo sognatore, troppo poco realista. Eppure, è questo il giovane, aveva trentacinque anni, per i tempi un’età già matura, che si butta nella vita politica, fino a rimanere scottato dalla scomparsa del suo partito, che partecipa attivamente all’elaborazione della Costituzione fino a ritrovarsi, nel 1948, come lui dice, «disoccupato». Già allora il suo rapporto con la politica lo doveva intrigare, se scriveva di sé al cugino Piero: «la mia vocazione politica è forte ma piuttosto incongruente alla situazione di riflusso che si va sempre più accentuando fra noi. Si richiedono oggi doti che io non posseggo, di equilibrio parlamentare: la mia posizione caratteristica e mentale ha troppe implicazioni rivoluzionarie per non essere alla lunga gettata ai margini del gioco politico».
Di questo periodo, prima dello scioglimento del PdA – raccontava di sé molti anni dopo – fu molto sollecitato a diventare sottosegretario, ad entrare nella carriera politica istituzionale. Mia madre era molto contraria – non perché lo considerasse un tradimento, ma perché lo vedeva come una cosa «di cattivo gusto» – e questo lo spinse a scegliere un’altra strada, quella del sindacato, che invece Lisa approvava perché, come lui stesso mi diceva, la considerava anti-istituzionale. Torna così a Torino, comincia a lavorare nel sindacato, dal basso, finché, nel 1950, comincia a collaborare con Di Vittorio ed entra nella segreteria della CGIL. È lo spostamento definitivo a Roma.
Il primo inverno, tuttavia, noi bambini lo passammo con nostra madre a Positano. Nostro padre era a Roma ma non trovava casa per noi dal momento che gli affitti erano carissimi. Di Positano ho vaghissimi ricordi: una scalinata che portava verso la spiaggia e noi che la scendevamo tutte le sere per andare a prendere il latte reggendo un secchiello di alluminio che dondolava nelle nostre mani. Della casa, che era di Manlio Rossi-Doria che ce la aveva imprestata, non ho ricordi. Penso che sia stato un periodo felice, me ne viene un’immagine di serenità. Con Manlio i miei erano molto amici; sue erano delle storie per bambini che i nostri genitori ci raccontavano e che poi io, a mia volta, ho trasmesso ad Andrea e alle sue figlie (ed ora le racconto alla mia pronipotina di sei anni, che ci aggiunge sempre qualcosa di suo). Non sapevo che fossero di Manlio quelle storie, ma una volta ne parlai con sua figlia Anna, mia amica, e lei le riconobbe con sorpresa e gioia.
Quando finalmente riuscimmo a trovar casa a Roma, abitavamo a Testaccio, in via Vanvitelli. La casa era piccola, ma costava tantissimo, più di metà dello stipendio di Vittorio, e così eravamo molto poveri, al punto che quasi non avevamo da mangiare. Le leggende famigliari raccontano di spinaci messi a bollire; gli spinaci erano per noi bambini, l’acqua della bollitura per Lisa e Vittorio. O di un uovo che Lisetta aveva tenuto da parte per friggerlo a Vittorio e che conteneva un pulcino. Ma le foto li mostrano, seppur ancora magri, più in carne rispetto agli anni della guerra. Anni in cui, scrive Vittorio, loro, già clandestini, non si rivolgevano neanche al mercato nero per l’ambiguità delle persone che lo esercitavano. Chi vendeva al mercato nero poteva anche vendere esseri umani!
Lentamente, a fatica, ci si avviava verso l’età del benessere. Nonostante le difficoltà, noi bambini fummo molto protetti, e non avemmo mai la sensazione di essere poveri o di non poter fare cose che altri facevano. Forse perché tutti vivevano nella stessa situazione. Il consumismo era ancora lontano, anche se poi il benessere cambiò il mondo con rapidità. Cominciammo a Roma le scuole elementari. Era una scuola all’aperto all’Aventino, la Gian Giacomo Badini: tante casette verdi in mezzo a un grande giardino. Era una scuola per bambini predisposti alla tubercolosi. Mangiavamo in gavette di alluminio che puzzavano in modo strano, e ci davano delle cotiche di maiale che io nascondevo nel grembiulino o, se mangiavamo all’aperto, sotto la ghiaia. Eppure, potevamo dirci fortunati. Di quella scuola rammento molte cose, tutte connesse con la guerra e la Resistenza.
Frequentavo forse la seconda elementare quando feci un sogno che ricordo ancora vividamente. Eravamo a scuola, tutti noi bambini con le maestre, e i nazisti l’avevano circondata per portarci via. Tutti intorno alla scuola, i genitori dei bambini, accalcati, rumorosi, per sapere cosa succedeva, per salvarci. E poi c’era un pappagallo dai colori smaglianti, giallo, verde e rosso che parlava gracidando. Avevo forse sette anni ed ero evidentemente già molto influenzata da quanto si raccontava in famiglia sulla guerra e sulla lotta partigiana. E in quegli anni ebbi anch’io la sensazione della differenza tra Torino e Roma. Torino era per me la città della Resistenza, Roma, così mi sembrava, ignorava quella Resistenza e nemmeno voleva saperne niente. Mi sentivo sola a portare sulle mie spalle il peso di quelle memorie, di cui, appena capace di leggere da sola, avevo cominciato a divorare i libri che trovavo negli scaffali di casa. Di questo ho un ricordo molto chiaro. Anche se in senso stretto non lo ero, mi dicevo ebrea. Venivo continuamente smentita da una mia compagna di scuola ebrea (di cui ricordo solo il cognome, Dell’Ariccia) che mi interrogava sul perché non andavo mai al Tempio e non portavo al collo la medaglietta con la stella di David. A sei anni, il mio ebraismo si identificava con l’Olocausto e non mi veniva neppure in mente che ci fosse un altro modo per essere ebrei, fatto di medagliette e di sinagoghe.
In quegli anni lessi tutto quello che mi capitava sotto gli occhi sui campi e sulla Resistenza. E quella sensazione di possedere un sapere nascosto e non condiviso mi accompagnò a lungo. Eppure, ero nel luogo che era stato il cuore di una persecuzione feroce, quella degli ebrei di Roma, che sessant’anni dopo avrei studiato nei dettagli. Mi sembrava che nessuno ne parlasse. Forse mi sbagliavo, forse gli ebrei ne parlavano fra loro, senza partecipare la loro memoria ai non ebrei. Ma me ne derivava un’estraneità, la percezione di essere diversa, che continuai a sentire negli anni, e che allora assumeva l’aspetto dei campi di sterminio e della Resistenza. Ho ritrovato per caso, molti anni dopo, per poi purtroppo perdere subito il suo numero di telefono, la figlia di quella mia maestra delle elementari, che mi ha parlato dell’affetto che sua madre aveva per me. Ero molto amata, evidentemente, ma per non sentirmi sola avrei avuto bisogno di una cultura condivisa e questa a Roma non riuscivo a trovarla.
Diventavamo piano piano, comunque, sempre più romani. Renzo cominciava a mescolare al vecchio accento torinese il nuovo accento romano, io avevo invece perso ogni accento. Fino ad oggi, però, non mi sento romana e mantengo l’enfasi sul mio essere torinese. Ma a Torino non mi sento del tutto a posto in questa identità torinese mantenuta artificialmente nel tempo e che lì non mi viene troppo riconosciuta.
Mi sono domandata in anni recenti quanto abbiano influito sulla vita successiva di mio padre gli oltre otto anni passati in una cella. Non mi riferisco solo alla sua vita pubblica, alla politica, ma anche alla sua vita personale, alla sua dimensione privata, famigliare. Dico in anni recenti perché per molto tempo la sua scelta antifascista mi è sembrata talmente normale da non lasciar spazio a domande del genere. E soprattutto, l’idea dell’«università del carcere» mi impediva di concepire quegli anni come perduti: il carcere come luogo di crescita, di maturazione, di apprendimento. Era un’idea che Vittorio condivideva con tutti gli antifascisti confinati o incarcerati come motivo di orgoglio identitario. Non li considerava certo anni perduti, e avevano uno spazio immenso nella memoria di mio padre, eppure non potevano non esserlo, per la giovinezza mai vissuta, gli amori, le esperienze proprie dei giovani, la spensieratezza delle passeggiate fra i viali, con gli amici. L’ho percepito con chiarezza quando anche lui, già molto vecchio, ripubblicando in edizione ridotta le sue Lettere della giovinezza, e rileggendole insieme a Federica Montevecchi, che le curava con lui, era sommerso dal rimpianto e si commuoveva ad ogni passo piangendo calde lacrime: «Le avevo scritte con allegria – mi disse –. Ora mi destano un’angoscia profonda. Mi ricordano la dispersione della famiglia, lo sfascio dell’Europa, il rischio d’un futuro vissuto come schiavi. Mi fanno piangere».
Mi sembra, ripensandoci ora, che i primissimi tempi dopo il carcere, durante la Resistenza, ne siano stati quasi un ovvio e spontaneo proseguimento: l’idea che bisognasse continuare a comportarsi come quando si era detenuti, a lottare. E non credo sia stato un caso che mio padre si sia innamorato proprio della figlia del suo compagno nella condanna al tribunale speciale, la sorella di quel Renzo di cui, forse, aveva un po’ invidiato se non la morte in combattimento almeno l’aver partecipato alla guerra di Spagna. Poi, nel dopoguerra, dopo la dissoluzione del Partito d’Azione, sentì, così mi sembra, di poter essere risarcito di quegli anni attraverso la riconquistata libertà di decidere di sé, di fare politica, di guardare il mondo, le donne, la montagna. In famiglia, tutto questo era trasmesso ma non esplicitamente. Il suo carcere, a differenza della morte di Renzo, non è mai diventato un mito famigliare; semmai uno stimolo, un esempio da seguire, proposto senza enfasi. Me lo conferma per contrasto la lettura dell’autobiografia di mia zia Anna, in cui l’arresto e la condanna del fratello assumono invece dimensioni mitiche. Poi, nella vecchiaia, con la saggezza, in Vittorio c’è stato il rimescolamento di tutte queste fasi della vita e, forse, uno spazio diverso dato al carcere. Più normale, chissà? E Vittorio si interrogava su che effetto avesse avuto sulla vita politica del dopoguerra essere il risultato dell’attività di persone a cui, nella maggior parte, erano state tolte con la for...