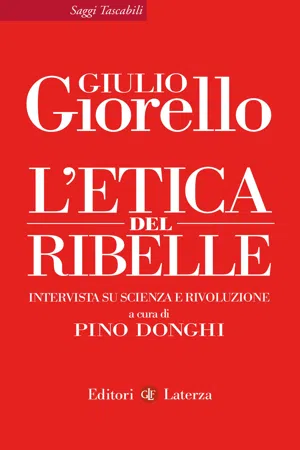
- 168 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Cosa c'è dietro una rivoluzione, sia essa politica, religiosa o scientifica? Quali, se ne esistono, i limiti? Che cosa differenzia il rivoluzionario dal ribelle? La rivoluzione è il ritorno a uno stato preesistente e ideale, come suggerisce l'etimo astronomico revolutio, che in latino indica il tornare di un pianeta alla posizione iniziale, o una marcia verso il nuovo? Che relazione c'è tra conoscenza e rivoluzione?
Giulio Giorello, uno dei più autorevoli filosofi della scienza italiani, riflette sulla rivoluzione come categoria capace di mediare il rapporto tra verità, tempo e conoscenza. Tutto nasce dalla libertà di cambiare: per studiare la conoscenza bisogna studiare le rivoluzioni nella conoscenza.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'etica del ribelle di Giulio Giorello,Pino Donghi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Logica in filosofia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Logica in filosofia1.
Perché la rivoluzione
Giorello Iniziamo con una piccola rivoluzione: sarò io ad avviare la nostra conversazione, prendendo a prestito una battuta di Carlo Emilio Gadda. Cito da una sua Meditazione milanese, che è efficace anche per la precisione linguistica: “Così malauguratamente avviene a certi solenni maestri: di essere battuti dagli empirici. E Copernico quanta roba non ha buttato a mare! E Galileo, l’acre e penetrante empirista Mediceo-Lorenese, quant’altra! E Bacone diede la stura a quell’empirismo che si chiama Impero Britannico”.
Donghi Gadda, dunque, per introdurre il tema della “rivoluzione” tra scienza e politica...
G. Per mettere a fuoco la struttura profonda dell’analogia tra rivoluzioni scientifiche e rivoluzioni politiche o meglio, direi in una prospettiva più generale, per comprendere l’interrelazione tra rivoluzione e conoscenza. È il Gadda che scrive di Copernico e di Galileo, quello che ribadisce l’esigenza di eliminare gli idola, esplicitando la rilettura baconiana del pensiero galileiano. Un Gadda che invita a considerare l’essenza del pensiero scientifico come la necessità di venire a patti con la realtà: il che t’impone, quando non si può fare altrimenti, di buttare a mare tutto quello che pur sembrava funzionare, e che magari d’improvviso comincia a non funzionare più.
D. È il Galileo nella lettura di Brecht, quindi, quello che dice: “Sì, rimetteremo tutto in discussione. E non procederemo con gli stivali delle sette leghe, ma a passo di lumaca. E quello che troviamo oggi, domani lo cancelleremo dalla lavagna e non lo riscriveremo più, a meno che lo ritroviamo un’altra volta. Se qualche scoperta soddisferà le nostre previsioni, la considereremo con speciale diffidenza”.
G. Straordinario il Galileo del teatro di Brecht. Il commediografo tedesco in altri testi non è sempre così grande, talvolta è fin troppo didascalico; però, quello che fa dire a Galileo è grandioso. In poche righe c’è tutta la diffidenza di un Karl Popper per chi va solo in cerca di conferme. È la smentita, invece, quella che fa avanzare la scienza.
D. Mentre cercavi il volume tra gli scaffali della libreria, e apprezzando ciò che Gadda, l’“Ingegner Gadda” (conviene ricordarlo), esprime nei confronti dell’istinto così felicemente empirico dei popoli delle isole atlantiche – quella disposizione che, guarda caso, a far data dal Seicento si manifesta liberamente anche nella prassi politica – sembrava che questa meditazione di Gadda, oltre che per il suo valore, ti divertisse molto: per il linguaggio, forse?
G. Sì. Gadda regala sempre al lettore un sottile divertimento intellettuale, un divertimento dell’intelligenza, che qui addirittura riflette, a sua volta, su due grandi intelligenze, quella di Copernico e quella di Galileo, legate da una storia comune: il distacco dalla “fabbrica dei cieli” aristotelico-tolemaica. È un’innovazione che si sviluppa inizialmente in un campo estremamente tecnico, quello dell’astronomia; poi c’è lo sconfinamento dall’astronomia alla fisica, implicito in Copernico ed esplicito in Galileo. Per non dire della consapevolezza di entrambi, sia pure vissuta in un modo diverso considerati i differenti caratteri, che la nuova concezione astronomica avrebbe cambiato profondamente anche la costellazione delle credenze più generali che sottendono la struttura stessa di una civiltà.
D. Mi pare, questo, un primo punto importante: la coscienza della portata rivoluzionaria.
G. Infatti! Copernico è esplicito nella lettera dedicatoria del De revolutionibus del 1543 a papa Paolo III; e ancor più consapevole ne sarà Galileo, tanto da costruirci la potente retorica del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632. Sono passati quasi cento anni, si è attuata la prima grande fase di quella “rivoluzione copernicana” che oggi, non a caso, è un topos della storia della scienza, e non solo; un cambiamento di prospettiva radicale, che va oltre l’ambito disciplinare in cui all’origine si manifesta. La locuzione “rivoluzione copernicana” è oramai di uso comune; nel 1957 ha fornito il titolo a un bellissimo lavoro dello storico della fisica e filosofo della scienza Thomas Kuhn. Che quella di Copernico fosse una grande rivoluzione sembrava averlo capito già Immanuel Kant nella Prefazione alla seconda edizione (1787) della sua Critica della ragion pura: è da lì che si fa risalire il riferimento alla “rivoluzione filosofico-copernicana” del filosofo di Königsberg. Ma a ben vedere, si tratta più che altro di “un mito”, come scrive lo storico della scienza e delle idee I. Bernard Cohen nel suo memorabile La rivoluzione nella scienza (Longanesi 1988), più precisamente nel capitolo 15, dedicato alla “presunta rivoluzione copernicana di Kant”: un mito costruito da commentatori e divulgatori della filosofia kantiana, a partire dal 1799 e nei primi trent’anni dell’Ottocento, e destinato a radicarsi in non pochi manuali di filosofia...
D. E invece, nella pagina kantiana?
G. In quella Prefazione Kant muove inizialmente dal caso della matematica, con il debito omaggio al “mirabile popolo greco”. Ora, “per lungo tempo la matematica ha continuato a brancolare (soprattutto presso gli egiziani), mentre il rigore della dimostrazione è una conquista che va attribuita a una rivoluzione che consentì di individuare la via sicura di una scienza per tutti i tempi e per una distanza infinita”.
D. Un giudizio alquanto impegnativo...
G. Tralascerei alcune delle abbastanza ovvie limitazioni della presentazione kantiana, come la sottovalutazione delle matematiche che ancora etichettiamo, sbrigativamente, come “pregreche”. Un punto, questo, che nessun avveduto storico oggi sottoscriverebbe. Mi vorrei concentrare, invece, sulla caratterizzazione della scoperta scientifica che Kant offre nelle righe immediatamente successive, con il suo raffronto con le grandi scoperte geografiche – un paragone destinato a diventare un topos: “A noi non è conservata la storia di questa rivoluzione nel modo di pensare – la quale fu molto più importante che la scoperta del passaggio al di là del famoso capo di Buona Speranza – né del fortunato che la produsse”. Resta il fatto che “al primo uomo che dimostrò la proprietà del triangolo isoscele (non importa che si sia chiamato Talete o in qualsivoglia altro modo) si presentò una luce; egli trovò infatti che non doveva seguire le tracce di ciò che vedeva nella figura [...], ma doveva tirare fuori (mediante costruzione) ciò che egli stesso, secondo concetti, aveva approfondito e presentito a priori”. In altri termini, “scoprì che [...] non doveva attribuire alla cosa alcunché, all’infuori di quanto seguiva necessariamente da ciò che egli stesso, conformemente al suo concetto, aveva posto in essa”.
D. Se non sbaglio, Kant ci dice pure che un processo analogo ha portato alla scienza razionale dell’età moderna... Ma qui, almeno, conosciamo i nomi dei rivoluzionari.
G. Certo. Cito ancora quella Prefazione: “Quando Galileo fece rotolare giù da un piano inclinato le sue sfere, il cui peso era stato da lui stesso stabilito, quando Torricelli sottopose l’aria a un peso, che in precedenza egli aveva calcolato come uguale a una colonna d’acqua a lui nota”, tutti questi “indagatori della natura furono colpiti da una luce”.
D. La rivoluzione come illuminazione, dunque. Non diversamente dai matematici, anche i protagonisti della rivoluzione scientifica del Seicento hanno compreso che (parole sempre di Kant) “la ragione [...] deve precedere innanzi con i principi dei suoi giudizi basati su stabili leggi e deve costringere la natura a rispondere alle sue domande”.
G. Il senso di questa costruzione, peraltro, viene spesso frainteso da non pochi spiriti contrari al cosiddetto scientismo: epigoni del pensiero di Heidegger, disinvolti lettori di Adorno e Horkheimer, ostinati avversari delle “tecnoscienze” (almeno in teoria; in pratica non saprebbero rinunciare alle comodità offerte dalla tecnologia: dai trasporti ai media dell’informazione, per non dire dei benefici della biomedicina). Nella trappola è caduto anche papa Francesco, che al paragrafo 106 dell’enciclica Laudato si’ (2015) non esita ad affermare che l’umanità nell’attuale fase di globalizzazione sarebbe vittima di un “paradigma tecnocratico”, ove “risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione”. Sfugge a Bergoglio che logica e sperimentazione stanno alla base dell’atteggiamento critico (che Kant rivendicava in modo essenziale fin dalla prima edizione della Critica, 1781): quell’atteggiamento che innerva il cambiamento della scienza come tecnologia, senza contare che le prove che così vengono esibite e utilizzate sono, sotto un certo profilo, indicazioni di ciò che non si può realizzare, come vari autori – da Charles Sanders Peirce a Karl Popper – hanno poi accuratamente messo in luce. Ma tolti di mezzo fraintendimenti del genere, torniamo a Copernico e ai suoi successori. Nella Prefazione alla seconda edizione, poche pagine dopo, in una nota così Kant modula il tema, pur senza entrare in dettagli storici (come lui stesso dichiara): furono “le leggi centrali dei movimenti dei corpi celesti” a corroborare “ciò che Copernico aveva da principio assunto come semplice ipotesi”, illustrando al tempo stesso “la forza invisibile (dell’attrazione newtoniana), che tiene unita la struttura del mondo”. E aggiunge: “quest’ultima sarebbe per sempre rimasta nascosta, se Copernico non avesse osato – in un modo contrastante ai sensi, eppure vero – di cercare i movimenti osservati non già negli oggetti del cielo, bensì nel loro spettatore”. Questa è, dunque, la rivoluzione “scientifica” che inaugura la modernità. È un processo di lungo periodo, innescato da Copernico e che Kant vede compiersi con la sintesi operata da Isaac Newton.
D. In un colpo solo abbiamo collegato Copernico, Galileo, Newton, Kant. Non è male per iniziare. E senza dimenticare i ringraziamenti all’Ingegner Gadda! Ma torniamo al nostro proposito. Avevamo immaginato una conversazione sulla “conoscenza”, ma subito hai rilanciato il tema della “rivoluzione”, più precisamente, della struttura fine dell’analogia tra rivoluzioni scientifiche e rivoluzioni politiche. Sarà il tessuto connettivo della nostra riflessione. Proviamo ad anticiparne il nucleo centrale: come comprendere la stretta interrelazione tra rivoluzione e conoscenza?
G. La verità è figlia del tempo, e forse la rivoluzione è il termine che media tra tempo e conoscenza. Se vogliamo anticipare un nucleo tematico, direi così. Certo, in questo genere di riflessioni emergono inevitabilmente motivazioni che possono nascere anche da idiosincrasie personali. C’è stato un periodo, ormai passato, in cui la rivoluzione era sulla bocca di tutti: le rivoluzioni politiche, la “rivoluzione culturale” in Cina, o magari nel nostro Paese e altrove, la rivoluzione sessuale... Come capita spesso nel discorso pubblico, la categoria della rivoluzione, almeno nel lessico, è migrata di disciplina in disciplina fino a diventare paradigma delle stesse rivoluzioni tecnologiche, per non dire di quella alimentare, o dei consumi, e così via. Tutto piuttosto interessante sennonché... non se ne poteva più di rivoluzioni! È stata l’insofferenza per questo abuso del termine che mi ha portato, in quel periodo, a proporre una categoria non solo diversa, ma per molti versi antitetica a quella di rivoluzione: quella di ribellione. Al momento di ricordare la figura e l’opera di Ludovico Geymonat avremo modo di riparlarne.
Oltretutto, come spesso capita, il pendolo oscilla e oggi si sprecano i testi che mettono in discussione l’esistenza stessa delle “rivoluzioni”, che non ci sarebbero mai state. Ne cito uno, anche non banale: La sconfitta delle rivoluzioni di André Ropert, con introduzione del nostro Luciano Pellicani (Ideazione 2002). E io che sono un po’ un bastian contrario alla Gadda, ho cominciato ad avere voglia di ripensare la categoria della “rivoluzione” per riproporla nel dibattito.
Idiosincrasie, dicevo; ma quello che non è idiosincratico è il punto di fondo, il nucleo tematico che possiamo anticipare, che è un grande tema della riflessione del mio maestro, Ludovico Geymonat. Un aspetto a cui egli teneva moltissimo: la conoscenza cresce mutandosi e, quindi, per studiare la conoscenza bisogna studiare come cambia la conoscenza. Ovvero: per studiare la conoscenza bisogna studiare le rivoluzioni nella conoscenza.
2.
Rivoluzione e conoscenza
Donghi Facevi riferimento, prima, a come la nuova concezione astronomica di Copernico e di Galileo avrebbe mutato anche in profondità i valori culturali, o meglio la costellazione delle credenze più generali che sottendono alla interpretazione stessa della civiltà.
Giorello Si tratta, per prima cosa, di un cambiamento radicale nel modo di guardare una data fenomenologia. Le rivoluzioni, intendo quelle politiche, esistono e accadono dai tempi dei tempi. Ma l’idea di rivoluzione, così come ancora oggi la pensiamo, anche nel discorso politico, è debitrice tanto della cosiddetta rivoluzione “copernicana” – quella rivoluzione scientifica che si sviluppa nell’arco di tempo che, appunto, da Copernico arriva fino alla sistemazione di Newton passando per Galilei (e per Keplero!) – quanto della “rivoluzione” di Martin Lutero. Ma della Riforma protestante parleremo dopo.
Per ora mi interessa rimanere alla concezione della rivoluzione, magari non originale, forse un po’ ingenua ma non per questo priva di fascino, per com’è stata trattata...
Indice dei contenuti
- 1. Perché la rivoluzione
- 2. Rivoluzione e conoscenza
- 3. La libertà di cambiare
- 4. Una scuola (e una rete) di libertà
- 5. L’etica del ribelle e l’esigenza di sincerità
- 6. Il tempo della storia. Fratture e continuità
- 7. Esercizi di emendazione dell’intelletto