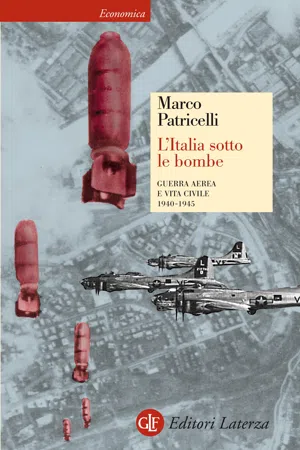
- 384 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Un libro che si legge tutto d'un fiato.Ernesto Galli della LoggiaLa responsabilità di chi volle la guerra, i metodi disumani, le reazioni dei civili massacrati dalle bombe: nel libro di Marco Patricelli, una ricostruzione narrativa viva e coinvolgente.Aurelio Lepre, "Corriere della Sera"«Le bombe cadono giù, le scorgiamo distintamente sgranarsi dalle pance dei quadrimotori. E inizia il finimondo. Esplosioni ovunque. Non si vede niente, fumo dappertutto, polvere e terriccio, la gola brucia, manca il respiro, il cuore batte all'impazzata.»Ricerca documentaria inedita e rigorosa, capacità di racconto: una lettura avvincente di un dramma scatenato dall'alto e vissuto dal basso.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'Italia sotto le bombe di Marco Patricelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia del XXI secolo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia del XXI secoloIII.
Conto alla rovescia
Comincia l’assedio
Sulla cartina il punto marrone interrompeva l’uniformità dell’azzurro del Mar Mediterraneo. Pantelleria sembrava quasi un’anomalia nella geografia italiana, così lontana non solo dalla terraferma, ma persino dalla Sicilia, più sperduto avamposto africano che sentinella della più grande isola. Ma appunto perché prossima alle coste africane e passaggio obbligato per quelle siciliane, non c’era alcun dubbio che non avrebbe potuto passare indenne l’ondata della guerra, e aspettava solo il momento in cui sarebbe arrivata a testarne la resistenza, e il senso che questa resistenza avrebbe potuto avere in un piano strategico più ampio. L’8 maggio l’isola di Pantelleria è attaccata da centoventi B-25 Mitchell e quarantadue P-38 Lightning, col primo risultato di lasciare distrutti al suolo sessanta aerei italiani. L’isola era difesa da squadriglie del 6° e 17° gruppo (1° stormo), del 22° gruppo e del 151° gruppo (53° stormo) equipaggiate con moderni Macchi MC 202 e MC 205 ‘Veltro’, oltre ai soliti Fiat G 50bis. Quel sabato è l’avvisaglia del doppio salto verso l’Italia: prima Pantelleria, poi la Sicilia, quindi la penisola. Domenica 9 valanga di fuoco sulle installazioni di Messina, spazzolata dai Liberator; le Fortezze volanti scortate da P-38 lasciano il segno su Palermo e l’opera viene completata dai B-26 della seconda ondata. Bombe anche sull’aeroporto di Pantelleria a opera di A-20 e altri velivoli medi; nella notte i Wellington ripassano gli aeroporti di Villacidro, Elmas e Decimomannu. Su Pantelleria i B-25 tornano domenica accompagnati dai P-40 che contribuiscono fattivamente all’attacco. Doppia incursione nella notte sulla Sicilia con Wellington (Palermo) e B-17 (Milo e Borizzo). Non c’è tregua, ormai le missioni sono a ciclo continuo. L’11 i Liberator aprono le loro pance su Catania e provocano danni al molo e ad alcune imbarcazioni. Peggior sorte spetta a Marsala, su cui si concentra il fuoco di B-17, B-25 e B-26 che rastrellano centro urbano, tracciato ferroviario, depositi, base di idrovolanti; alcuni P-40 fanno visita al porto di San Michele, e non è una visita di cortesia; nella notte i Wellington scaricano ancora sulla zona portuale di Marsala; altre bombe cadono su Mazara del Vallo e Trapani.
«Catania, Marsala, il territorio di Trapani e l’isola di Pantelleria sono state bombardate da formazioni di quadrimotori: notevoli danni a Catania e Marsala. Colpiti dal tiro delle batterie contraerei [sic], 8 velivoli precipitavano in mare: 2 a sud di Catania, 1 a Mazara del Vallo (Trapani) e 5 a Pantelleria; altri 14 apparecchi risultano abbattuti in duelli aerei: 9 dalla caccia germanica e 5 da nostri cacciatori». E sotto al comunicato n. 1082 del quartier generale delle Forze armate, un corsivo precisa che «le vittime finora accertate, per le incursioni indicate nel bollettino odierno, ascendono a 150 morti e circa 300 feriti in Catania. Quelle fra la popolazione di Palermo, per il bombardamento del giorno 9, sono salite a 227 morti e 451 feriti». Nella notte tra il 12 e il 13 maggio Napoli è oggetto di un’incursione da parte dei Wellington della Northwest African Air Force che saturano i quadranti della stazione e del porto e provocano 5 morti. Alla luce del giorno i B-25 attaccano Augusta e i B-24 della Raf il terminal di Messina, ma il trattamento peggiore è riservato a Cagliari, raggiunta da una flotta di B-17, B-25 e B-26 assemblata da sette Group, per un totale di quasi duecento velivoli, e scortata da 186 caccia di quattro Group, che non risparmiano niente e nessuno: porto, impianti industriali e tessuto urbano. L’inferno su una città i cui abitanti, se possibile, hanno trovato riparo altrove, divampa dalle 13.38 alle 14.45. Nella notte è la volta dei Wellington inglesi (sono 23) dedicarsi per circa quindici minuti allo stesso bersaglio, sul quale destinano anche le terrificanti blockbuster da 4.000 libbre. Il bilancio è di una trentina di morti e una cinquantina di feriti, ma quando gli incendi si esauriscono e il fumo si dirada, due terzi delle abitazioni di Cagliari o non esistono più o sono del tutto inagibili.
Inchiodati nei rifugi
Cosa significasse per la popolazione civile lo stillicidio delle bombe inglesi e americane, la liturgia della ricerca di scampo, la speranza muta nei rifugi, la rabbia al cospetto delle macerie fumanti e del sangue, emerge persino quando la censura della narrazione giornalistica ammorbidisce gli orrori e rende un quadro solo entro certi limiti asettico e ‘accettabile’. Attilio Battistini pubblica il 15 maggio su «Gente Nostra» il resoconto da località (ovviamente) omessa di un’incursione alleata. Il titolo – La mano di gesso, con riferimento a una statua di Cristo che spunta tra i calcinacci dopo l’inferno del bombardamento – è seguito da un rassicurante «Dopo che le sirene hanno urlato il segnale di cessato allarme la vita della città riprende, piano piano, con un ritmo progressivo che scandisce una consegna. – Le cose si ricompongono nel quotidiano operoso aspetto, la gente ritorna al suo posto di lavoro. Sulle ferite e le rovine si stende come un velario di pietà, ma sotto cova e ingigantisce l’odio per il nemico...». Il racconto è scandito dall’orologio: «Ore 17 – Cinquanta centesimi per il francobollo, dieci lire per le sigarette uno e venti per la carta fa in totale undici e settanta, così disse la donna grassa che stava al banco della rivendita e mentre diceva queste parole l’aria fu percossa dal primo urlo della sirena. Io rimasi interdetto perché avevo, per le 17.30, un appuntamento telefonico con il giornale. Rimasi con le sigarette e la carta e il francobollo tra le dita, un poco imbambolato mentre altri fischi di sirena s’inseguivano ad intervalli. La donna con calma olimpica aggiustò qualche cosa sul bancone, ficcò alcune carte in un cassetto ed entrò nel retrobottega, chiamando a voce alta: ‘Nunziatina, Nunziatina, sbrigati...’. Arrivò Nunziatina, una bimbetta allampanata d’un dodici anni con le treccette rigide che sbattevano sugli omeri scarniti, come due bastoncelli, e la donna vedendomi così imbambolato, disse: ‘ormai ci siete, scendete con noi nel rifugio’. Per la scala si sentivano i colpi duri di chi scendeva e così anche noi, la tabaccaia, Nunziatina ed io, ci ritrovammo per le scalette umide del rifugio e ci calammo nell’ombra. Una lampadina di luce rossa stava ammantata di ragnatele e nell’ombra si cominciavano a disegnare le persone.
Ore 17.10 – Saranno state una ventina di persone nella grotta compresi la donna grassa, Nunziatina ed io. E si andavano assestando su certe panche rozze, si sedevano con calma, si accomodavano come gente che non ha fretta, che può attendere in tranquillità, come quelli avvezzi, da anni, a fare anticamera, senza fretta. Un ragazzino disse poche parole alla madre ma non si compresero perché la grotta era sorda, abbastanza sorda. Durante l’incursione regna un profondo silenzio. Sembra un’esagerazione, un’invenzione addirittura, ma in mezzo agli scoppi, ai rombi, alla sinfonia della contraerea e delle bombe, regna il silenzio. Manca la voce dell’uomo. È un concerto di macchine, solo macchine, cui non partecipa la voce dell’uomo. L’uomo, e la donna anche, gridano e si afferrano prima e dopo: quando si avverte il primo sibilo di sirena e appena si smorza l’onda sonora del cessato allarme: ma durante l’incursione l’uomo, e la donna anche, attendono in silenzio il ritorno alla normalità.
Ore 17.25 – Il boato della contraerea e lo scoppio delle bombe arrivano da dentro attutiti, come una risacca lontana. Dato che non c’era nulla da fare, dato che bisognava fare quella sorta d’anticamera, mi misi a osservare la fisionomia dei compagni di rifugio. Di uomini c’eravamo solo io e due vecchietti. Poi tutte donne, giovani e vecchie, qualche ragazzino compresa Nunziatina che si era quasi nascosta nelle pieghe di grasso della madre, la quale teneva gli occhi sulla parete di fronte, le mani abbandonate sul grembo; sembrava assorta in pensieri assai importanti e lontani. Non c’era nessuna espressione di paura in quei volti, irrigiditi, con la pelle tesa sull’osso, gli occhi lucidi, bulinati come quelli delle xilografie. Maschere forti, di rabbia e di disprezzo. Qualcuno cominciava ad appisolarsi, così per abitudine.
Ore 17.50 – Adesso gli scoppi si avvicinano, si sentono più distinti. Qualcuno alza per istinto la testa verso la volta umida ed oscura, poi si gira un poco sulla panca rozza. Una donna mi dice: ‘Sedetevi, tanto c’è tempo, meglio stare seduti’ e mi fa uno spicchio di posto. Di fronte a me c’è una bella ragazza. Ha una grossa borsa di tela. L’apre e vi pesca dentro qualche cosa: un gomitolo di lana e comincia a lavorare rapida con i ferri lucidi che sprizzano scintille percossi dalla luce rossa della lampadina. ‘È per mio fratello in Africa, adesso la finisco questa maglia e poi faccio il pacco’. La vicina guarda quel rapido sferruzzare e si riappisola. Gli scoppi ci stanno proprio sopra, ogni tanto si sente uno schianto, la gente rientra con la testa tra le spalle, un poco, solo un poco. La donna grassa non è più assorta. Gira la testa di qua e di là, i suoi occhi escono dall’adipe del viso, si ingrandiscono, sono percorsi da guizzi, alla fine dice: ‘Avrà pure da finì con ’ste carogne’.
Ore 18.15 – Ecco, questo è il segnale del cessato allarme. La gente s’alza dalle panchine e si stiracchia. Veramente fa un po’ freddo qui dentro. In fila si comincia ad uscire, a salire per le scalette e finalmente si respira aria buona. Il sole è basso sull’arco dell’orizzonte ma indora la città con un tepore benefico. Ci ritroviamo così davanti alla porta della rivendita. La gente fa crocchio. La donna grassa guarda la casa di fronte che si è aperta come una zucca. Guarda senza parlare giocherellando automaticamente con le treccine di Nunziatina, dure e nere come due bastoncelli.
Ore 18.30 – La casa dell’uomo, il focolare geloso, testimone discreto degli amori e delle nascite, s’è spento. S’alza macabro, dalle radici del selciato sconvolto, lo scheletro dell’edificio. Il lavoro, l’affetto, i sogni maturati e cresciuti là dentro, il sentimento di cui sono impastate quelle mura, la religiosità della famiglia, cemento durissimo che amalgama il blocco eroico del popolo italiano, non hanno frenato la lingua arroventata del tritolo d’oltre Oceano. Lo scheletro dell’edificio resta nella città, con le occhiaie svuotate, a maledire in eterno.
Ore 18.50 – Uscendo dai rifugi il cuore si stringe ed una rabbia sorda comincia a salire dalle viscere al cervello. La città che s’era lasciata prima d’andar sottoterra con le sue case, le sue vie, la sua caratteristica, quella caratteristica inconfondibile di ogni città italiana, si ritrova smozzicata e incendiata. La strada gronda acqua. Una conduttura è crepata e nel cratere di una bomba si è formato un laghetto. All’angolo una chiesa è andata in pezzi. Dalle macerie esce quasi timida una mano di gesso, la mano di un Cristo. È più viva quella mano che se fosse di carne; hanno una mossa sconsolata le dita. Povero Cristo! [...] Più in là, al centro della strada, un cassettone antico, butterato dai tarli, lucidato dalle mani di molte generazioni, lascia trapelare dai cassetti aperti sbavature di biancheria. Una donnicciola s’avvicina e si siede vicino ai cassetti. Ha ritrovato il suo mondo.
Ore 19 – Girano le squadre di soccorso. Gli autocarri dei vigili del fuoco passano a raffiche. La gente si avvia verso la propria casa.
Ore 19.15 – Sono passati gli americani, i ‘liberatori’, hanno lasciato dietro di loro una scia di cadaveri, la città avvolta in veli neri di fumo e rossi di fiamma, ma soprattutto hanno lasciato una incancellabile scia d’odio. Era una giornata di sole e ne hanno fatta una giornata di morte.
Ore 19.25 – Malgrado le bombe e gli spezzoni e le pallottole delle mitragliere, la vita riprende, piano, piano, nella città. Come un fiato sottile che si ingrossa a gradi. Il popolo ritorna alla sua casa, aiuta gli uomini delle squadre a spalare. Le vecchiette, le donne, i ragazzi, cercano di spegnere gli incendi, se non hanno un attrezzo rimuovono i rottami con le mani. Si cerca di salvare qualche indumento. Si riaprono le saracinesche dei negozi, la gente circola tra le macerie, per le vie sconquassate. Malgrado tutto la vita deve riprendere.
Ore 19.45 – Passo davanti ad un ospedale. Un’ala brucia, vigili del fuoco, monache, infermieri, cercano di domare le fiamme. Transitano alcune barelle, il popolo muto guarda i cadaveri. Gira, tra quelle salme, una monaca: da una mano le pende un rosario, le sue labbra si muovono in fretta, prega. Con la mano sinistra, scarna, fa dei cenni. Anche dei bambini ci sono in mezzo a quelle salme. La gente guarda i cadaveri e poi alza gli occhi al cielo che comincia ad oscurarsi.
Ore 20 – Si sono accese le prime stelle lucide come bollette di grosse scarpe di soldato. Una fetta di luce gialla piove da una finestra su un mucchio di calcinaccio. Il popolo continua a vivere, continua a sbrigare le sue faccende, malgrado le bombe e gli spezzoni. Quelli che sono caduti sui campi di battaglia, che stanno lassù nel cielo immenso e profondo, che vedono la morte, che vedono gli incendi, che vedono l’orrore della guerra e bimbi straziati, sentiranno che il loro sacrificio è sublimato dall’eroico contegno dei vivi. Malgrado tutto, malgrado le bombe, gli spezzoni, i colpi delle mitragliere alle reni, il popolo resta al suo posto». Forse ci resta perché non sa dove andare e la melassa retorica non riesce ad addolcire i patimenti e le sofferenze.
Dove sono i nostri?
La Regia Aeronautica, pur recuperando un po’ di aerei dal forzato disimpegno africano – cosa che il generale Rino Corso Fougier, sottosegretario all’Aeronautica, aveva sollecitato in aprile per salvare il salvabile –, nel mese di maggio non può schierare più di circa cinquecento caccia efficienti, dei quali duecento di stanza in Sicilia e centocinquanta in Sardegna. Il che spiega la strategia alleata che non dà requie alle piste di decollo sarde e siciliane, tenendo sulla corda gli italiani sulla possibilità di sbarco sull’una o l’altra isola. Perché l’invasione ci sarà: è solo questione di tempo e di luogo, ma ci sarà sicuramente. Fougier ha elaborato per il capo di Stato maggiore generale, Vittorio Ambrosio, una serie dettagliata di informative su «Impiego dell’arma aerea» (9 aprile), «Situazione generale europea dal punto di vista della guerra area» (15 aprile), «Situazione strategica nel Mediterraneo in seguito alla scomparsa del fronte tunisino» (25 maggio). Il quadro che delinea nell’ultima relazione è a tinte fosche perché «anche se le forze da caccia disponibili fossero il decuplo di quelle attuali» il loro utilizzo sarebbe impossibilitato da due fattori: il primo è l’assottigliamento delle scorte di carburante; il secondo l’insufficiente ricambio degli equipaggi, che le scuole di volo, pur accresciute nel numero, non riescono a formare in quantità tale da soddisfare i ritmi richiesti dalla guerra. Quando la popolazione vede i bombardieri alleati e non vede gli intercettori, si chiede con angoscia e con rabbia «ma dov’è la nostra caccia?», non si pone la domanda sul perché le città non sono difese e non possono esserlo efficacemente. Per Fougier, inoltre, è del tutto impensabile poter risolvere il problema alla radice, cioè distruggere le basi di partenza dei raid di bombardamento, perché l’Italia oltre a soffrire dei limiti dell’aeronautica di difesa, praticamente non dispone di un’aeronautica d’attacco: i dati al 31 marzo dicono senza ombre e senza nebbie che in linea ci sono 26 gruppi e una squadra di bombardieri, con 186 velivoli di nuovo tipo, 58 di vecchio e 80 non impiegabili, per un totale di 324 con 270 equipaggi disponibili; i siluranti sono 9 gruppi per 118 velivoli con 120 equipaggi. La caccia è a sua volta articolata in 25 gruppi e 3 squadre, con 300 mezzi di nuovo tipo, 396 di vecchio, con 630 equipaggi disponibili. È altresì impensabile difendere ovunque un paese con la conformazione dell’Italia in ogni punto «scelto dall’avversario per vibrare i suoi colpi con masse che hanno raggiunto in alcune incursioni cifre di centinaia di velivoli tra bombardieri ed unità di scorta». Il Comando supremo già il 27 febbraio 1943 aveva reiterato all’Oberkommando della Wehrmacht una ‘lista della spesa’ con la richiesta di 500 aerei (60% da caccia e 40% da bombardamento) e 10.000 tonnellate di carburante in più rispetto alla quota di rifornimento stabilita. Nel prospetto del 5 maggio il carburante avio saliva a 23.500 tonnellate («oltre alla normale fornitura di 9.000 tonnellate mensili»), mentre i velivoli richiesti erano: 300 Messerschmitt Me 109, 200 Junkers Ju 87 e Ju 88, 50 Messerschmitt Me 110, 12 Dornier Do 217, oltre a poco più di 200 motori Daimler Benz. La Germania era pressata da un lato dalle necessità sempre maggiori del logorante fronte orientale, dall’altro dal rischio di un’invasione o di uno sganciamento dell’Italia che lasciasse sguarnito il fronte mediterraneo, e quindi aveva adottato la tattica di temporeggiare e di concedere a piccole dosi quanto reclamato da Roma, verso la quale aumentava il clima di sfiducia. Al 5 maggio risultava ufficialmente che precedenti richieste erano state soddisfatte per quanto riguarda i caccia con appena ventiquattro Me 109 e per quanto riguarda i motori aeronautici con un solo Daimler Benz. Il 9 quella singolare commistione tra un diplomatico e una spia, un interprete e un disinvolto viveur dei salotti romani che risponde alla figura del tenente colonnello onorario delle SS, Eugen Dollmann, informa Berlino che nel sottobosco italiano la fronda antiregime si sta attivando per farla finita con Mussolini e la sua guerra.
Il 14 maggio le sagome delle Fortezze volanti divengono familiari anche per gli abitanti di Civitavecchia. Gli ordigni scaricati dai B-17 della Northwest African Air Force martoriano la zona portuale e quello che vi sorge attorno, lasciando quasi trecento persone senza vita. È un colpo sanguinoso, che si svolge in simultanea alle sortite in Sardegna di cacciabombardieri P-38 contro gallerie, alloggiamenti, aeroporti, industrie, centri di comando e naturalmente agglomerati urbani a Sassari, Abbasanta, Alghero e Porto Torres. Nella notte i Wellington raggiungono Palermo e vanno via dopo aver seminato incendi e distruzioni, col bilancio di 17 morti. Nella notte tra 14 e 15 lo stesso trattamento è riservato a Trapani, con impatto sicuramente minore. Lunedì 17 il Lazio torna a essere terreno di battuta: i Wellington arrivano sul Lido di Roma, colpiscono la base degli idrovolanti e, visto che ci sono, lanciano sull’Urbe. Ma per fortuna dei romani sono solo volantini di propaganda: gli Alleati vogliono dimostrare che la Città eterna non è inviolabile ed è loro mera facoltà bombardare o meno. Sono sempre i Wellington a entrare in azione nella notte tra il 17 e il 18 nel settore di Alghero e Sassari; sulla Sardegna volano di lì a poche ore i B-25 che assaltano Milis e l’aeroporto di Villacidro, e i B-26 che invece hanno come obiettivo la pista di Elmas, la periferia di Quartu Sant’Elena e il porto di Cagliari. L’aeroporto di Milo è spazzato dal fuoco delle Fortezze volanti che colpiscono anche alcune strutture di Trapani e ingaggiano tenaci combattimenti con gli intercettori che li ...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Prologo. Un’invenzione italiana
- I. Il grande bluff
- II. «L’aviazione inglese pesta forte»
- III. Conto alla rovescia
- IV. Senza respiro
- Ringraziamenti
- Bibliografia
- Immagini