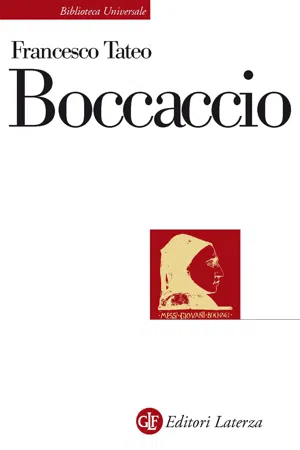
- 306 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Boccaccio
Informazioni su questo libro
Il primo grande narratore della letteratura italiana scopre il miracolo del linguaggio fingendo una difesa morale delle sue licenze; e frattanto nasconde, sotto la leggerezza della favola e il piacere delle motivazioni consolatorie, un'estrema consapevolezza della professione artistica e della gravità poetica. Giocosa contraddizione di uno sperimentatore di generi e di stili, o dissimulato progetto di uno fra i primi teorici moderni della poesia?
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Critica letterariaCapitolo ottavo.
Una tipologia delle Cento novelle
1. Metafora, ironia, equivoco: l’artificio del discorso
L’arguzia è fra le principali forme del gioco affidato alle armi della parola, e può valersi della brevitas, tipica del motto arguto adoperato per lo più in risposta, come può prolungarsi in un discorso articolato, che utilizzi l’eloquenza per attuare la dissimulazione. La brevitas costituisce espressamente il tema della sesta giornata, mentre nella prima, dove la novella non manca di utilizzare talora l’accorgimento stilistico della brevità ma si vale prevalentemente delle belle maniere del discorso, vige soprattutto quella misura che appartiene all’etica della prudenza, della saggezza, e che evita di trasformare l’uso della parola arguta in soperchieria o scherno. Nell’uno e nell’altro caso è sempre un inferiore, o una persona in condizione di inferiorità, che usa l’arguzia nei confronti di un superiore per sottrarsi alla sua soperchieria o riscattare la propria inferiorità dando una lezione di cortesia o di intelligenza. Ed è appunto tale rapporto a mettere in evidenza questo genere di arguzia, perché la situazione impone una sorta di prudenza espressiva, sotto la quale nascondere il senso provocatorio del rimprovero. Si tratta propriamente di una forma di dissimulazione, che ostenta un atteggiamento di cortesia o di rispetto, fino al limite dell’ironia.
La prima storia di tutta la raccolta, la falsa confessione di ser Ciappelletto, che per la sua eccezionale ricchezza di connotazioni si presta a varie letture, può considerarsi il caso limite del discorso di un inferiore, il peccatore inginocchiato, che si sottrae all’infamia divertendosi in fin di vita a raccontare al confessore una serie di ciance come se fossero gravi peccati, per simulare il candore della propria anima e farsi passare per santo. Ma portate a questi livelli iperbolici, la menzogna e l’ipocrisia assumono i connotati ironici della dissimulazione. E dissimulazione è principalmente quella del narratore, Panfilo, il quale con ‘sagacità’ – si potrebbe dire – incornicia la novella blasfema in un argomentare teologico, ricordando l’opportunità di cominciare da Dio e concludendo con l’ineccepibile principio della inconoscibilità del giudizio divino e con l’ipotesi paradossale di un Dio che si compiace di esaudire uomini così «puri di cuore» da rivolgere la preghiera ad un suo nemico credendolo santo:
Così adunque visse e morì ser Cepparello da Prato e santo divenne come avete udito. Il quale negar non voglio esser possibile lui esser beato nella presenza di Dio, per ciò che, come che la sua vita fosse scellerata e malvagia, egli poté in su lo stremo aver sì fatta contrizione, che per avventura Idio ebbe misericordia di lui, e nel suo regno il ricevette; ma, per ciò che questo n’è occulto, secondo quello che ne può apparire ragiono, e dico costui più tosto dovere essere nelle mani del diavolo in perdizione che in Paradiso. E se così è, grandissima si può la benignità di Dio cognoscere verso noi, la quale non al nostro errore ma alla purità della fé riguardando, così faccendo noi nostro mezzano un suo nemico, amico credendolo, ci essaudisce, come se a uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo (i 1, 89).
Dove il gioco verbale è indice d’un sofisma ridicolo, oltre il fatto che, imitando lo stile agiografico, la stessa formula che conclude la narrazione («E così adunque visse e morì...») mette ancor più in evidenza il paradosso del racconto e può leggersi anch’essa come arguta dissimulazione, dal momento che giustifica con argomenti teologici un esempio di superstizione. Talché il commento di Panfilo pare destinato più a sottolineare la superstizione popolare, che non ad esaltare la bontà divina.
Facendo ridere le donne, ma «in parte», e facendo d’altronde apprezzare tutta la novella («la novella di Panfilo fu in parte risa e tutta commendata dalle donne», i 2, 2), lo scrittore allude forse agli eccessi del racconto e ai suoi sottintesi osceni e blasfemi, che le donne si guardano dal sottolineare col riso – come si dirà esplicitamente in altra occasione –, o si riferisce proprio alla beffa della confessione, che appartiene alla sfera del riso e sarebbe solo un aspetto della novella di Panfilo, lasciando che l’apprezzamento vada invece all’arte del narratore? E l’arte del narratore, in questo caso, comprende anche la paradossale motivazione religiosa dell’exemplum, che le donne anche loro dissimulatamente ‘commendano’.
L’arte dissimulatoria del narratore si misura anche nell’aneddoto della seconda novella, che si presenta anch’essa come una difesa della religione, incentrata com’è sui difetti del clero, che ancora una volta offrono l’occasione di formulare un paradosso: là l’ipocrisia finisce santificata, qui la lussuria, l’avarizia, la gola, l’invidia e la superbia prosperanti nella curia papale finiscono con l’avere un effetto contrario a quel che si potrebbe pensare. Abraam giudeo, commiserato da un cristiano per il «difetto di fede» e invitato a convertirsi al cristianesimo, ma sconsigliato dall’andare a verificare a Roma la santità della Chiesa, dà una lezione di acutezza teologica quando riconosce la misericordia e la potenza divine proprio nelle «diaboliche operazioni» della curia, che tuttavia non nuocciono alla religione (i 2). Il paradosso secondo il quale la corruzione romana sarebbe la dimostrazione della presenza di Dio nella Chiesa è sostenuto dal giudeo in un discorso la cui natura paradossale (la contraddizione quale segno del miracolo) ne fa una facezia. Sembra che il Papa e gli alti prelati si dedichino alla distruzione della Chiesa; se la Chiesa non cade, e anzi prospera, deve esserci un intervento miracoloso che è quello appunto dello Spirito Santo. E lo stesso discorso è organizzato come un sillogismo, dal quale discende una conclusione necessaria (i 2, 24-27):
dicoti così, che, se io ben seppi considerare, quivi niuna santità, niuna divozione, niuna buona opera o essemplo di vita o d’altro in alcuno che chierico fosse veder mi parve [...]. E per ciò che io veggio non quello avvenire che essi procacciano [...]. Per la qual cosa, dove io rigido e duro stava [...] ora tutto aperto ti dico che io per niuna cosa lascerei di cristian farmi.
Ribadendo il principio del carattere contingente delle apparenze, pare che Melchisedech giudeo (i 3) continui, con la disinvoltura della facezia, il discorso sulla inconoscibilità del pensiero di Dio e l’errore delle apparenze in fatto di religione. Ma rispondendo con un apologo al Saladino che gli chiedeva quale delle tre religioni, la cristiana, la giudaica, la musulmana, fosse più verace, per metterlo in difficoltà ed espropriarlo dei beni, egli in effetti evita di compromettersi. L’apologo delle «tre anella» lasciate da un padre in eredità ai tre figli, che non avrebbero saputo mai quale delle tre fosse l’unica autentica, sfugge infatti sia alla pericolosità di una dichiarazione sgradita al Saladino, sia alla scortesia di una risposta secca che avrebbe oltre tutto evidenziato troppo l’elusività o l’eversività del concetto secondo cui ogni religione è buona per chi ci crede. L’apologo riesce un sofisma faceto, perché non risponde propriamente alla «quistione» del Saladino («quale delle tre leggi tu reputi la verace», i 3, 8), ma alla questione assoluta di quale ‘sia’ la vera, e giustifica la risposta agnostica con un argomento per sfuggire, ma plausibile sul piano logico.
L’apologo proposto, una novella nella novella, è una forma di argomentazione senza la perentorietà della conclusione. Una novella nella novella è anche quella che viene addotta come exemplum da Bergamino per mordere l’avarizia di Cangrande (i 7) senza dirgli bruscamente quanto fosse poco cortese il modo con cui lo accoglieva, trasferendo nella disavventura di Primasso, andato a verificare la liberalità dell’abate di Cluny, la propria delusione. La forma indiretta dell’exemplum evitava in questo caso il rimprovero diretto e disponeva bene il signore, ma dava la possibilità di calcare la mano sulla villania di chi avrebbe dovuto essere cortese. In effetti la magnificenza di Cangrande, lodata da Dante (Par. xvii 85-86: «le sue magnificenze conosciute / saranno sì») e dai contemporanei, risalta proprio attraverso la resipiscenza («Messer Cane, il quale intendente signore era, senza altra dimostrazione alcuna ottimamente intese ciò che dir volea Bergamino», i 7, 27), accostando la conclusione a quella di altre novelle, come quella del Saladino già citata e quella di re Carlo (x 6), in cui viene confermata la natura cortese del sovrano attraverso l’episodio di una sua episodica debolezza.
Tipologicamente diverse, perché tendenti alla causticità ‘breve’ del rimprovero, ma analoghe per lo slittamento metaforico della dissimulazione e la prudenza dei modi allusivi, sono le pronte risposte della marchesana di Monferrato che fa stare al suo posto il re di Francia (i 5) andato a visitarla in assenza del marchese, rilanciandone l’allusione metaforica, e quella del poeta provenzale Guglielmo Borsiere (i 8), il quale critica la scarsa liberalità del genovese Erminio de’ Grimaldi suggerendo di far dipingere nella sala del suo palazzo la ‘cortesia’ al signore che desiderava gli si indicasse «cosa alcuna che mai più non fosse stata veduta». Eppure in tutti e due i casi la brevitas della risposta è accuratamente preparata da un disteso racconto per essere ancora più efficace. La marchesana, aspettandosi le avances del re, gli aveva allestito – si direbbe con sagacità – un pranzo di sole galline in modo da provocare la sua domanda allusiva sulla mancanza di galli, e usare la medesima metafora delle galline per fargli intendere l’inopportunità di quella visita, e delle sottese intenzioni: «Monsignor no [non nascono galline senza gallo in questo paese], ma le femine, quantunque in vestimenti e in onori alquanto dall’altre variino, tutte perciò son fatte qui come altrove» (i 5, 15). E frattanto evita l’offesa diretta e l’imbarazzo di opporre un rifiuto. Dal canto suo il poeta provenzale dell’altra novella aumenta la sorpresa e la causticità della sua battuta, preparandola con la ripetizione delle parole del suo interlocutore, alle quali egli attribuisce un significato diverso perché fa slittare il senso di «vedere» (i 8, 14):
«Messere, cosa che non fosse mai stata veduta non vi crederei io sapere insegnare, se ciò non fosser già starnuti o cose a quegli somiglianti; ma, se vi piace, io ve ne insegnerò bene una che voi non credo che vedeste giammai».
Messere Erminio disse: «Deh, io ve ne priego, ditemi quale è dessa», non aspettando lui quello dover rispondere che rispuose.
A cui Guglielmo allora prestamente disse: «Fateci dipignere la Cortesia».
Ma il narratore aveva a sua volta preparato la battuta con uno dei pezzi satirici più significativi sulla decadenza del costume cortese.
La direzione della battuta, da inferiore a superiore, fa sì che l’arguzia abbia anche l’aspetto di una trasgressione. Infatti i modi perifrastici talora aggravano, più che alleggerire, la facezia. La novella narrata nella prima giornata da Dioneo, che interrompe la tematica con il primo racconto salace, unico nella prima giornata, ben rientra nella serie trasversale delle novelle attribuite al più bizzarro personaggio della brigata, ma obbedisce al genere della facezia perché la trama costituisce soltanto la situazione licenziosa nella quale si inserisce il discorso subdolo del monaco, scoperto dall’abate con una giovane e riuscito a far cadere l’abate nello stesso peccato per poi ricattarlo avendo spiato nella cella. Il comico del discorso del monaco risiede nel fingere d’imparare (ancora un sofisma al servizio della dissimulazione) che il peccato consista nel ‘modo’ dell’adulterio, non nell’adulterio in sé; e che, anzi, fosse peccato proprio la posizione più normale che egli aveva tenuta (i 4, 21):
Messere, io non sono ancora tanto all’Ordine di san Benedetto stato, che io possa avere ogni particularità di quello apparata; e voi ancora non m’avevate monstrato che’ monaci si debban far dalle femine premiere, come da’ digiuni e dalle vigilie; ma ora che mostrato me l’avete, vi prometto, se questa mi perdonate, di mai più in ciò non peccare, anzi farò sempre come io a voi ho veduto fare.
In modo diverso, e pur con qualche analogia nel meccanismo, la novella sesta offre l’esempio tipico di un crudo rimprovero mal celato sotto un’equivoca interpretazione. È un’accusa di falsa beneficenza («ipocrita carità», come la si qualifica nel successivo commento) quella che l’uomo perseguitato dall’inquisitore e costretto ad ascoltare le sue prediche rivolge ai religiosi, i quali distribuiscono ai poveri un’orribile brodaglia. La facezia consiste, in questo caso, nell’interpretare in senso ‘letterale’ l’espressione evangelica pronunciata dall’inquisitore («Voi riceverete per ogn’un cento»), la quale prefigurerebbe una punizione divina, una pena di contrappasso: «se per ogn’una cento ve ne fieno rendute, di là voi n’avrete tanta che voi dentro tutti vi dovrete affogare», (i 6, 19), e nel far finta di esser preoccupato per la sorte dei frati nell’aldilà, ritardando e dissimulando l’effettivo vituperio.
Un’analogia presentano anche le ultime ben diverse novelle della prima giornata, dove si alternano nell’uso sapiente del discorso la donna capace di dare una ironica ma elegante lezione al re di Cipro e il vecchio ma gentile amante, maestro Alberto da Bologna, capace di dare una eloquente lezione di cortesia alle donne che si gabbano di lui e in particolare a madonna Malgherida dei Ghisolieri. L’eloquenza, eccezionale nell’umile donna, e tale da far risaltare la distanza dal breve exemplum (Novellino li) che ne costituisce probabilmente la fonte, maschera ogni espressione di reale disappunto. L’ingiustizia del re viene infatti ironicamente interpretata come ‘pazienza’ (in effetti la sopportazione dell’ingiuria era un eccesso negativo secondo l’etica aristotelica) e assunta come difficile virtù da apprendere (i 9, 6):
Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che io attenda della ingiuria che m’è stata fatta; ma in sodisfacimento di quella ti prego che tu m’insegni come tu sofferi quelle le quali io intendo che ti son fatte, acciò che, da te apparando, io possa pazientemente la mia comportare: la quale, sallo Idio, se io far lo potessi, volentieri te la donerei, poi così buono portatore ne se’.
Maestro Alberto ricorre anche lui ad un ragionamento capzioso per dimostrare di essere preferibile ai giovani, adducendo l’esempio della maggiore consistenza e dolcezza della parte generalmente scartata di certi frutti modesti. Ma il presupposto è la teoria cortese della natura d’amore, che pone al di sopra delle forze richieste per gli «amorosi esercizi» la «conoscenza» di «quello che sia d...
Indice dei contenuti
- Capitolo primo. La vita
- Capitolo secondo. Stilnovismo epico-lirico
- Capitolo terzo. Prosa e versi di romanzi
- Capitolo quarto. Fra sogno e visione
- Capitolo quinto. Da Napoli a Firenze: i generi ovidiani
- Capitolo sesto. Tra Firenze e Fiesole: il «Decameron»
- Capitolo settimo. L’ideologia narrativa
- Capitolo ottavo. Una tipologia delle Cento novelle
- Capitolo nono. Storia e mito dell’umanità
- Capitolo decimo. I generi autobiografici
- Bibliografia
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Boccaccio di Francesco Tateo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Critica letteraria. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.