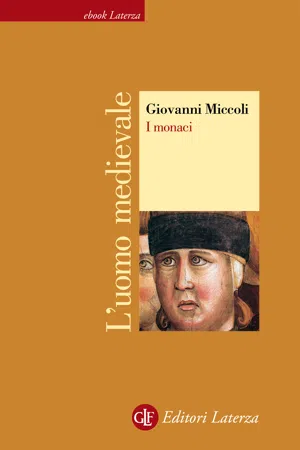I monaci
Monaci e monasteri hanno cessato da tempo di far parte della comune esperienza degli abitanti d’Europa. Non hanno cessato di esistere ma non figurano più tra gli incontri ordinari e ricorrenti del suo paesaggio storico. Solo ne restano qua e là le imponenti vestigia: mascherate nelle città, dove le vecchie chiese abbaziali sono state occupate e deformate da altri officianti e gli immensi conventi sono stati destinati a nuovi usi dalle soppressioni rivoluzionarie; abbandonate e spesso cadenti nelle antiche solitudini delle campagne, pallida e non sempre decifrabile testimonianza di una presenza e di una grandezza di cui per lo più sono andate perdute ragioni e memoria.
Lo sdegno del visconte di Montalembert che più di cent’anni fa ricordava di aver visto per la prima volta un abito di monaco sulle scene di un teatro – «dans une de ces ignobiles parodies qui tiennent trop souvent lieu aux peuples modernes des pompes et des solennités de la religion» – non avrebbe certo più luogo di essere. Ma la satira profanatrice restava pur sempre indizio della vitalità di un ricordo, attestava pur sempre una capacità di evocare immagini e sentimenti che oggi appaiono irrimediabilmente sbiaditi e lontani. I monasteri e i priorati – cluniacensi, cisterciensi, certosini, camaldolesi, vallombrosani –, che nel XII secolo, all’apogeo dell’espansione monastica, popolavano a migliaia le contrade d’Europa, si sono ridotti a poche centinaia in tutto il mondo. E i loro diminuiti abitatori restano una presenza silenziosa e rara, spesso inavvertita per lo stesso popolo cristiano. Mentre sono pressoché scomparsi quelle miriadi di solitari – i «romiti» incessantemente ricordati per secoli da leggende agiografiche e da cronache – che al margine del mondo monastico istituzionalizzato, perduto il ricordo delle comuni radici, si seppellivano nelle solitudini alpestri e nelle foreste per riapparire periodicamente tra gli uomini ad evocare con le loro figure selvagge l’incombere della morte e l’urgenza della conversione.
Non è stata una catastrofe improvvisa ma un lento declino, iniziatosi già all’indomani dei secoli d’oro del monachesimo. I grandi colpi portati dall’esterno – la riforma luterana, con la conseguente scomparsa della presenza monastica in vaste regioni dell’Europa centrale e settentrionale, le capillari soppressioni che precedettero, accompagnarono e seguirono le violenze della «grande rivoluzione» – hanno accelerato e reso in apparenza artificiale un processo che veniva da lontano e nel quale le profonde trasformazioni della società si erano venute combinando con alcuni radicali mutamenti nel modo di vivere e di pensare la presenza cristiana nella storia; ma anche con le esigenze della politica ecclesiastica di Roma, che seppe puntare, nelle nuove circostanze, su altri e più duttili strumenti di intervento. Tale vicenda, complessa e tortuosa, non distrusse il monachesimo ma ne ridimensionò drasticamente il ruolo nella vita della Chiesa, segnando un suo diverso approccio con la società e con la storia.
Mutamento sociale e mutamento religioso dunque costituiscono la trama in cui venne consumandosi la centralità di un’esperienza che aveva caratterizzato per secoli, nella varietà esuberante delle sue articolazioni, il volto dell’Europa: un’Europa che si voleva in tal modo cristiana, che si riconosceva cristiana in primo luogo grazie a quell’esperienza ed agli istituti cui aveva dato vita. Il primo nodo storico di fondo sta appunto qui, in questo decisivo ed esclusivo privilegiamento del chiostro per garantire la continuità di un’autentica presenza cristiana nella storia. Nell’autoconsapevolezza di sé che emerge gradualmente nella cultura monastica tardo-antica e medievale e che appare sempre più confortata da un largo consenso politico e sociale, gli unici veri cristiani sono i monaci. Fu una maturazione lenta e complessa di esperienze, di tentativi, di elaborazioni culturali e ideologiche, di proposte istituzionali. Tale insieme di materiali, variamente ripensato e riadattato alle difficili realtà politiche e sociali dell’Europa post-carolingia, costituì la base ed il punto di riferimento per la possente ripresa monastica che caratterizzò in Occidente i secoli centrali del Medioevo. Tra X e XII secolo il processo di riduzione del cristianesimo autentico alla vita monastica giunge alla sua più completa ed in qualche modo definitiva espressione. Com’è potuta avvenire un’operazione così riduttiva in una società che pur si fregiava del titolo di respublica christiana? E chi erano questi monaci, che di tale operazione furono protagonisti ed insieme beneficiari, quale fu la loro vita, quale cristianesimo, vorrei dire quale tipo di umanità cristianizzata incarnarono e rappresentarono? E infine quali furono i molteplici complessi ingredienti di questo singolare composto, solo parzialmente unitario, rappresentato dal monachesimo nei secoli che videro la sua massima espansione?
Non sono risposte facili. La memoria di quell’età passa quasi esclusivamente attraverso le voci di monaci – o di preti che i monaci avevano profondamente influenzato –, le azioni e le opere degli altri protagonisti della storia giungono a noi prevalentemente tramite l’ottica e i criteri di giudizio formati dalla cultura monastica. Non si tratta di una deformazione di poco conto: l’autoconsapevolezza di sé del monachesimo offre gli schemi per rappresentare se stesso e diventa la pietra di paragone per giudicare il mondo: una sorta di lievitazione spiritualizzante sottrae il monastero al metro comune delle opere e delle azioni umane. Tale processo intellettuale ed emotivo non è frutto soltanto di una vitale esperienza religiosa e mistica: riducendo alla propria immagine ed ai propri schemi religiosi e culturali tutte le altre realtà, per renderle in qualche modo funzionali alla giustificazione e all’esaltazione della scelta e dell’esperienza monastiche, esso scopre le sotterranee radici ideologiche, politiche e sociali che presiedono anch’esse alla sua genesi, che offrono anch’esse sollecitazione e materia alla sua affermazione storica.
Tale modo di essere del monachesimo ha inciso singolarmente anche sulla moderna storiografia. Ciò che rappresenta il punto d’arrivo di una spiritualità, di una cultura e di un’ideologia, che vanno ricostruite e capite nelle loro radici e nelle loro componenti, diventa troppo spesso l’indiscusso punto di partenza di ricostruzioni storiche che si riducono ad una loro trionfalistica prosopopea o alla statica rievocazione contemplativa di un dover essere. Nonostante l’inesausto scavo compiuto da storici ed eruditi, il lungo percorso dell’umanità monastica solo in questi ultimi decenni ha potuto ottenere una più adeguata e reale storicizzazione. Sta in essa, per molta parte, la chiave per comprendere lo stesso successivo ridimensionamento e declino del monachesimo; ma forse anche il senso e le condizioni del perdurare della sua pur marginale e nascosta presenza in contesti religiosi e sociali così profondamente mutati.
I materiali tardo-antichi ed alto-medievali
Il modo di vita dei cenobiti ha la sua origine al tempo della predicazione apostolica. Tale infatti si presentava a Gerusalemme tutta la moltitudine dei credenti, che negli Atti degli apostoli viene descritta così: «La moltitudine dei credenti aveva un cuore ed un’anima sola; nessuno diceva suo ciò che possedeva ma tutte le cose erano tra loro in comune. Essi vendevano le loro terre ed i loro beni e ne dividevano il ricavato fra tutti secondo il bisogno di ciascuno». E ancora: «Nessuno era povero tra loro. Infatti i possessori di terre o di case le vendevano e ne ponevano il ricavato ai piedi degli apostoli, ed esso veniva poi distribuito secondo il bisogno di ciascuno». Tale, dico, era allora tutta la Chiesa, quali ora sono quei pochi che non è facile trovare negli stessi cenobi.
Ma, dopo la morte degli apostoli, la moltitudine dei credenti cominciò a raffreddare il suo fervore, quella soprattutto che affluiva alla fede di Cristo da popoli stranieri e diversi. A costoro gli apostoli, tenendo conto della rozzezza della loro fede e delle loro radicate abitudini pagane, chiedevano soltanto di astenersi «dalle offerte degli idoli, dalla fornicazione, dalla carne soffocata e dal sangue». Ma tale libertà, concessa ai gentili per la debolezza della loro fede nascente, cominciò a poco a poco a contaminare anche la perfezione della Chiesa di Gerusalemme: e mentre ogni giorno cresceva il numero dei nuovi venuti, [...] non solo nella folla dei nuovi proseliti ma negli stessi capi della Chiesa l’austerità antica andò rilassandosi. Alcuni infatti, stimando lecite anche a se stessi le concessioni fatte alla debolezza dei gentili, ritennero che non avrebbero sofferto alcun danno conservando le proprie sostanze ed i propri beni e confessando insieme la propria fede nel Cristo.
Ma coloro in cui ancora viveva il fervore apostolico, memori di quell’antica perfezione, abbandonarono le città e la compagnia di quanti ritenevano lecita per sé e per la Chiesa di Dio la negligenza di una vita più rilassata, e si stabilirono nei suburbi e in luoghi più appartati, cominciando a praticare privatamente e per proprio conto le regole che essi ricordavano stabilite dagli apostoli per l’intero corpo della Chiesa. Prese così corso l’osservanza di cui parliamo ad opera dei discepoli che si erano sottratti al contagio degli altri. A poco a poco, separati dalla turba dei credenti, per il fatto che si astenevano dal matrimonio e si tenevano lontani dai loro parenti e dalla vita di questo mondo, furono chiamati monachi o monazontes per l’austerità della loro vita solitaria e senza famiglia. Le comunità che essi formavano valsero loro in seguito il no...