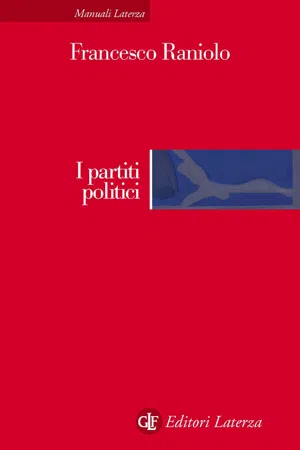1. Ambivalenze, definizioni e funzioni
1.1. Le dicotomie partigiane
Quando ci si appresta a riflettere sui partiti salta agli occhi, prima o poi, una caratteristica che li contraddistingue molto più di quanto accada per altre forme organizzative della politica: l’ambivalenza. Nel senso che la loro identità e azione riflettono orientamenti contrastanti, non sempre conciliabili, contraddittori. Nei termini della psicoanalisi potremmo dire che veicolano simultaneamente «atteggiamenti e sentimenti opposti». Ciò dipende, molto probabilmente, dalla loro ragione sociale, dal fatto stesso di essere i gruppi politici per eccellenza. Del resto, è già la politica ad essere fondamentalmente ambigua, la sua natura è bene espressa dall’immagine di Giano, il dio bifronte (Duverger 1964, trad. it. 1971; Sartori 1992; Bobbio 1999). Ovunque, la politica è, allo stesso tempo, strumento sia di dominio e sopraffazione che di regolazione e ordine. Implica costantemente disintegrazione e integrazione, mette in gioco consenso e, pur come extrema ratio, forza. Essa ci «appare ora come ciò che unisce, ora come ciò che separa, ora come il modello e mezzo dell’unione, ora come fondamento e metodo della discordia, ora come essenza della pace, ora come spirito della guerra» (Sternberger 1978, trad. it. 2001, p. 11). Questa duplicità investe tutti gli oggetti politici e quindi pure i partiti, anche quando il riferimento è alla politica democratica. Ma proprio a questo punto incappiamo su un’altra questione cruciale: la possibilità che i partiti possano degenerare nella loro azione e in questo modo finire per pervertire il funzionamento della democrazia. Se è vero che essi sono gli attori centrali della vita democratica al punto che questa è inimmaginabile senza di loro – anzi, in un certo senso, questa si può considerare un sottoprodotto della competizione tra partiti (Schumpeter 1954, trad. it. 2001) – è anche vero che la qualità di una democrazia dipende da quel che fanno o non fanno, dai loro orientamenti e ideologie, dal tipo di relazioni che intrecciano tra di loro e con le altre istituzioni. Anzi, come insegna la storia del XX secolo, la stessa morte della democrazia non è estranea alla loro azione.
Sul piano analitico, però, è opportuno andare oltre ciò che a livello degli atteggiamenti e dei comportamenti abbiamo chiamato ambivalenze, per individuare alcune «coppie concettuali» più generali a carattere oppositivo utili a dar conto della logica di azione dei partiti4. Abbiamo ricavato tali contrapposizioni o dicotomie partigiane dalla letteratura sui partiti politici e, in un certo senso, possono essere considerate come i poli di altrettanti continua: parte vs. tutto; conflitto vs. integrazione; società vs. Stato; rappresentanza vs. governo e, per finire, identità vs. competizione5.
Tra la parte e il tutto. Partito deriva dal latino partire che vuol dire dividere, da cui il termine partizione. Nel suo significato etimologico partito sta, dunque, per «parte», per qualcosa che è distinta dal tutto, per una frazione rispetto a un intero. L’azione elementare del dividere in politica però porta con sé un’ulteriore implicazione relativa alla dialettica tra «parte» e «tutto». Come avverte Giovanni Sartori (1976, p. 25), la razionalità dei partiti politici moderni si basa su tre premesse: «1. i partiti non sono fazioni; 2. un partito è parte-di-un-tutto; 3. i partiti sono canali di espressione». Il sottinteso in questa ricostruzione è l’affermazione, alla fine del XVIII secolo, dell’idea che l’universo politico è policromatico. «Quando sosteniamo che il dissenso e la diversità sono buone per il corpo sociale e per la città politica, il sottinteso è che la città politica è fatta, e anzi è bene che sia fatta, di parti. E quelle parti che chiamiamo partiti si sono affermate, storicamente, in forza di quel sottinteso» (ivi, p. 22). Lasciando per ora da parte il terzo punto sul quale avremo modo di ritornare più avanti, merita qui richiamare due potenziali effetti perversi che discendono dalla dialettica parte-tutto.
Un sistema politico in preda al «fazionismo» è un universo in cui le parti hanno finito per prevalere sul tutto, è incline alla radicalizzazione e alla centrifugazione. Il sistema perde la sua capacità di regolazione e di integrazione, si apre la strada allo stato di natura di hobbesiana memoria. La vita civile, per dirla con Guglielmo Ferrero, viene fagocitata da un sistema di terrori; in questo scenario a dominare è Behemoth, il mostro biblico che simboleggia la discordia, la sedizione e la guerra civile. D’altra parte, se il pluralismo e la dialettica tra le parti vengono risucchiati dal buco nero di un Leviatano totalitario, siamo ricondotti ad un universo monistico in cui scompare la guerra civile, ma con essa anche la libertà. Al pluralismo dei partiti si sostituisce con forza il monopartitismo, lo Stato dei partiti si trasforma nello Stato a partito unico o, che è lo stesso, nel partito-Stato. Certo, non tutti i sistemi monopartitici sono uguali, si differenziano tra di loro per l’intensità della repressione e dell’inquadramento ideologico, da qui la distinzione tra sistemi a «partito unico» e a «partito egemonico» (Sartori 1976). Tuttavia, merita un’enfasi il fatto che la crescita del fazionismo e della radicalizzazione sono segnali (le cause prossime) inequivocabili della crisi con (eventuale) crollo della democrazia; per contro, il monismo costituisce uno dei possibili esiti di tale crisi organica della democrazia: l’affermazione di una qualche variante di autoritarismo (Morlino 2003).
Tra conflitto e integrazione. I partiti nei loro rapporti reciproci e nella dialettica con il sistema politico fungono da «canali per integrare individui e gruppi nell’ordine politico esistente, o da strumenti per modificare o sostituire tale ordine» (Kirchheimer 1966, trad. it. 1979, p. 188). Funzionano come meccanismi sia di integrazione sia di disintegrazione, come fattori di regolazione e di conflitto. Questa ambivalenza è stata colta da Pizzorno (1996, p. 983), quando ricorda che essi, per un verso, «organizzano la partecipazione», il che implica una incessante attività di «socializzazione e di filtraggio» delle «informi domande che urgono dal basso»; per l’altro, che attraverso l’elaborazione ideologica favoriscono la costruzione «delle identità con le quali pretendono di farsi riconoscere» (ibid.) e all’insegna delle quali lottano per la conquista e la conservazione del potere. In questo modo offrono pacchetti coerenti di risposte (manifesti e programmi) alle domande sociali. Nella misura in cui, nell’ambito dei vincoli posti dalle norme e dalle procedure vigenti, hanno successo nella canalizzazione e nella traduzione di queste richieste, spesso contraddittorie, che pressano dal basso, essi assicurano la legittimazione del sistema politico. Le stesse elezioni costituiscono una «occasione» in cui il cittadino votando manifesta «la propria solidarietà con persone che la pensano come lui» (Pizzorno 2012, p. 204). Tuttavia, «nessun regime, e meno di tutti quello democratico che permette l’articolazione e l’organizzazione di tutte le posizioni politiche, è privo di una qualche forma di opposizione sleale» (Linz 1978, trad. it. 1981, p. 56) che mette in discussione la stessa legittimità delle autorità e delle istituzioni.
Si tratta allora di capire quali sono, in un dato regime, il peso, la configurazione e le cause che spiegano la presenza di queste forze antisistemiche. Secondo Hans Daalder (1966, p. 65), per svariate ragioni storiche e strutturali, i sistemi politici europei nel corso delle prime democratizzazioni hanno registrato la comparsa di partiti antisistema e di formazioni sleali. In genere, tali opposizioni sleali o antisistema in una democrazia consolidata sono minoritarie e acquistano rilevanza solo in fasi piuttosto critiche del suo funzionamento. Quando ciò accade la sua stessa sopravvivenza è messa in questione (cap. 5). Il quadro si complica se, accanto alle opposizioni leali (o pro-sistema) e sleali (anti-sistema), collochiamo i casi ibridi, ancor più difficili da individuare, costituiti dalle opposizioni semi-leali. Né dobbiamo dimenticare che, nel corso del tempo, ci possono essere spostamenti significativi degli atteggiamenti dei gruppi e dei partiti verso il regime politico. Partiti prima antisistema possono passare ad una fase di semi-accettazione e, quindi, ad una piena integrazione che li può condurre anche ad occupare posizioni di governo. Ma è possibile anche il tragitto inverso per cui il partito subisce una radicalizzazione che lo spinge verso posizioni di maggiore incompatibilità sistemica.
Tra società e Stato. Come avvertiva Norberto Bobbio (1985, p. 26): «I partiti hanno un piede nella società civile e un piede nelle istituzioni [...] di fatto non appartengono interamente né alla società civile né allo Stato. Infatti, uno dei modi più frequenti di definire i partiti politici è quello di mostrare che essi assolvono la funzione di selezionare, quindi aggregare e infine trasmettere, le domande che provengono dalla società civile e sono destinate a diventare oggetto di decisione politica». Non a caso – ricorda ancora Bobbio richiamando il contributo di Paolo Farneti (1973) – è stato proposto di arricchire la dicotomia classica del pensiero liberale società civile e Stato, collocando tra le due sfere la «società politica» della quale i partiti politici rappresentano i soggetti più rilevanti. Più di recente, Thomas Poguntke (2006, p. 106), nel ribadire che «i partiti sono degli intermediari che stabiliscono il collegamento fra la società e le istituzioni del governo democratico», ha messo in rilievo, con toni simili a quelli di Bobbio, che «per svolgere tale funzione di collegamento devono essere ancorati in entrambi i campi, cioè nelle istituzioni statali come i parlamenti, i governi e le burocrazie, e nella società»6 (ibid.). Potremmo aggiungere che questo ruolo di intermediazione è più rilevante in presenza di partiti di origine esterna o sociale (cap. 3).
Un diverso modo di esplorare i meccanismi di mediazione e di collegamento operanti nella sfera politica, e non solo democratica, è quello proposto dalla Lawson (1980; ma si veda anche Lawson e Merkl 1988; Römmel, Farrell e Ignazi 2005; Dalton, Farrell e McAllister 2011). Il punto di partenza della studiosa americana è dato dalla nozione di collegamento (linkage), simile ma non del tutto riconducibile a quella di mediazione cui abbiamo fatto riferimento, con la quale si riferisce ad «una connessione, di norma con una connotazione di interazione» (Lawson e Merkl 1988, p. 14) tra livelli o unità territoriali distinte – tra le quali esistono reciproche convenienze a mantenere la relazione. I partiti quindi fungerebbero da «anelli di collegamento», da agenzie specializzate nel mantenere le connessioni tra la società e il sistema politico o, se si preferisce, tra i cittadini-elettori e le istituzioni. Quando tale funzione di connessione è svolta in maniera efficace, il che implica che essa proceda a due vie, il sistema politico è stabile e la sua persistenza legittima; tuttavia, non si può escludere che i collegamenti possano essere disfunzionali e insoddisfacenti o che nel tempo possano deteriorarsi. In tal caso emergono delle agenzie di collegamento alternative – movimenti, gruppi di interesse, formazioni di protesta o antipolitiche, finanche le burocrazie o la magistratura – che cercano di prendere il posto dei partiti.
Tra rappresentanza e governo. Questa coppia di termini è piuttosto familiare nel lessico politico, ciò tuttavia non la rende di per sé evidente. Entrambi i termini che la compongono sono polisemici, indicano al contempo distinti principi di legittimazione politica (ascendente e discendente), altrettante strutture istituzionali specializzate (organi di teatro e apparati esecutivi, per usare l’espressione di Massimo Severo Giannini), così come diverse logiche operative e decisionali (espressione delle differenze e del pluralismo e riduzione della complessità ed efficienza). Quanto ai partiti essi si trovano al centro di questo campo semantico, sono investiti contraddittoriamente dalle richieste di dare voce alla diversità e di semplificare le scelte, di «trasmettere domande» e di «esercitare la delega» (Pizzorno 1980). Inoltre, mostrano delle differenze significative rispetto allo svolgimento di queste due funzioni che derivano dalla loro formazione (partiti di origine interna o esterna), dalla base sociale di riferimento (partiti di élite o di massa), dall’ideologia (partiti conservatori o progressisti), dal ruolo (partiti di governo o di opposizione), dal contesto storico-geografico (partiti americani o europei; partiti odierni o tradizionali): dove tutti i tipi di partito indicati per primi, nelle coppie riportate tra parentesi, sono caratterizzati dal momento del governo, mentre i secondi da quello della rappresentanza.
Da un punto di vista generale il dilemma rappresentanza-governo può essere considerato quale principio strutturale che presiede all’organizzazione dei rapporti tra gli organi supremi di un dato regime (forma di governo). Un principio di organizzazione che storicamente ha registrato un radicale ribaltamento: per le istituzioni proto-rappresentative della società medievale il «popolo era una parte da rappresentare di fronte, al cospetto, rispetto, al potere. Nell’ottica moderna, il popolo è [invece] un insieme, un tutto rappresentato dal potere» (Fisichella 1983, pp. 31-32) e, più esattamente, dai leader politici che si contendono i voti degli elettori e che, una volta approdati al Parlamento, danno vita al governo. La rappresentanza democratica mette al centro della ribalta politica la partecipazione elettorale dei cittadini assicurata dai partiti, così come una nuova funzione di controllo che i primi esercitano (o dovrebbero esercitare) tramite i secondi. Nelle società di antico regime rappresentanza e parlamenti fungono da limite esterno, da meccanismi di raffreddamento e di controllo delle decisioni del sovrano che, ad esempio, non può imporre nuove tasse o muovere guerra senza il consenso dei rappresentanti dei ceti sociali e dei territori.
Nel corso del XVIII e del XIX secolo tale stato di cose muta radicalmente, intanto perché nelle liberal-democrazie al Parlamento sarebbero state riconosciute altre importanti funzioni oltre a quella di controllo, a partire da quella di eleggere il premier a quella espressiva dell’opinione pubblica di cui parlava Walter Bagehot, e poi perché via via che si sarebbe istituzionalizzato il rapporto di fiducia tra Parlamento ed esecutivo il compito di controllare il governo sarebbe passato all’opposizione – mentre la maggioranza parlamentare sarebbe stata (tendenzialmente) assorbita nell’esecutivo. Sartori (1976) ha chiarito come questa evoluzione delle forme di governo fosse impensabile senza il consolidamento organizzativo e istituzionale dei partiti. Ma ben più importante con queste trasformazioni istituzionali la «struttura di comando dello Stato» (Pizzorno 2012) venne suddivisa in due parti, la prima dipendente dalle elezioni (rappresentanza politica), la seconda reclutata sulla base di specifiche competenze collegate alle esigenze funzionali di una amministrazione di prestazione (apparati di governo). Di fatto, la rappresentanza politica ha assunto due forme idealtipiche, la cui rilevanza è condizionata dallo sviluppo dei tipi di partito (cfr. infra, Conclusioni): la rappresentanza individuale (storicamente detta anche liberale), tutte quelle volte in cui il rapporto di identificazione e di lealtà passa tra singoli politici o leader e gli elettori, con il partito-macchina che assolve una funzione strumentale, e la rappresentanza collettiva (più strettamente partitica), in cui il rapporto politico connette gli elettori al partito-comunità con un ruolo secondario dei candidati. Ad ogni modo, nella misura in cui essi riescono a risolvere i complessi giochi di coordinamento inter-istituzionali (interni alla forma di governo) ed extra-istituzionali (riguardanti la forma di Stato, ovvero i rapporti tra istituzioni e società) assicurano alle democrazie rappresentative a un tempo efficacia e legittimità, stabilità e flessibilità favorendone l’adattamento al mutare delle circostanze.
1.2. Verso una definizione
Nel passare in rassegna le dicotomie dei partiti abbiamo toccato svariati aspetti relativi alla loro ragione d’essere, cioè al ruolo, alle caratteristiche organizzative e funzionali, al rapporto con la democrazia. È tempo adesso di provare a fare una maggiore chiarezza concettuale e analitica. Ci...