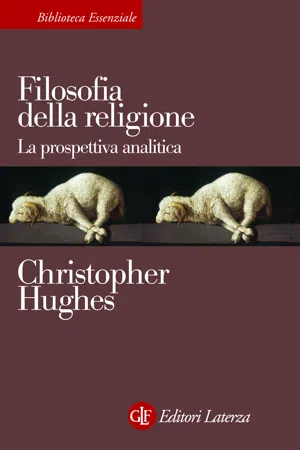
- 188 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La riflessione sui concetti fondamentali del pensiero religioso, tradizionale coronamento della metafisica e dell'etica, è tornata oggi al centro della discussione filosofica. Una introduzione chiara e rigorosa, nella prospettiva analitica contemporanea.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Filosofia della religione di Christopher Hughes in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Philosophical Essays. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophyCategoria
Philosophical Essays1.
Introduzione
1.1. Che cos’è la filosofia della religione?
La filosofia della religione nasce da un certo tipo di riflessione sulla religione. Il filosofo della religione ha, quale materia prima delle sue riflessioni, concetti religiosi come «Dio», «onnipotenza», «peccato», e affermazioni religiose1 come «Dio esiste», «Dio non esiste», «Dio è uno e trino»2. Il suo primo compito è quello di giungere a una comprensione approfondita di tali concetti. La filosofia della religione cerca cioè di capire che cosa significhi dire che un essere è onnipotente, o onnisciente, o uno e trino; che due persone divine sono consustanziali; che un atto è peccaminoso. E cerca di capire anche che cosa significhi dire che un essere è Dio.
Qualcuno potrebbe domandarsi se ciò che ritengo essere il primo compito del filosofo della religione non sia invece il compito di un lessicografo. Se vogliamo sapere che cosa significhi dire di un essere che è (ad esempio) onnipotente, non basta consultare un vocabolario? Un vocabolario ci dirà che l’onnipotenza è il poter fare tutto. D’accordo: ma cosa vuol dire poter fare tutto? Implica la possibilità di creare un cerchio quadrato, o il poter cambiare il passato, o il poter peccare? Se non abbiamo una risposta per queste domande, in un certo senso non sappiamo cosa significa né la possibilità di far tutto, né l’essere onnipotente. Tali risposte non le possiamo trovare in un vocabolario. Analogamente, è vero che un vocabolario ci dirà che la consustanzialità è l’avere la stessa natura o sostanza, ma la risposta alla domanda: «Cosa vuol dire avere la stessa natura o sostanza?» è di dominio del filosofo della religione e non del lessicografo.
Il filosofo della religione inoltre cerca una migliore comprensione del significato delle affermazioni nelle quali compaiono i concetti religiosi. Come vedremo, questo comporterà spesso la ricerca di una migliore comprensione di concetti non prettamente religiosi. Ad esempio, per intendere cosa significa affermare che Dio non è la causa del male, bisogna intendere il concetto di causa e il concetto di male.
Il filosofo della religione dovrà occuparsi delle proprietà logiche, oltre che del significato, delle affermazioni religiose. In via d’esempio, dovrà accertare se è logicamente coerente (non-autocontraddittorio) affermare che tre persone diverse sono lo stesso Dio. Dovrà accertare se «Dio è onnipotente» e «Dio è onnisciente» sono affermazioni logicamente compatibili o no3. Perché supporre che non lo sono? Se un essere è onnisciente, sa infallibilmente ciò che farò; e se qualcuno sa infallibilmente ciò che farò, non è chiaro in che modo io ho il potere di fare altrimenti. Parimenti, se un essere è onnisciente, sa infallibilmente ciò che egli stesso farà, e quindi non è chiaro in che modo egli ha il potere di fare altrimenti. Ma un essere che non ha il potere di fare altrimenti non è, per ciò stesso, onnipotente.
Nella misura in cui la filosofia della religione consiste nel tentativo di capire meglio la natura di concetti religiosi, il significato e le proprietà logiche di affermazioni religiose, essa è «analisi concettuale» o «analisi logica».
Ma l’analisi non esaurisce la filosofia della religione. Dove A sta per un’affermazione religiosa – per esempio, «Dio esiste», o «L’ultimo giorno i morti risorgeranno» – i filosofi della religione hanno spesso cercato di rispondere alle seguenti domande:
In quali circostanze possibili A è vera? In quali circostanze possibili A è falsa?
A è vera? A è falsa?
Sappiamo che A è vera (o falsa)?
Disponiamo di buone ragioni per credere che A sia vera (o falsa)?
Ma non sussiste alcun motivo per supporre che la risposta a queste domande passi per la comprensione (quand’anche completa) della natura dei concetti rilevanti, e/o del significato delle affermazioni rilevanti.
1.2. Filosofia della religione e teologia
Per vari motivi, la filosofia della religione e la teologia non si devono identificare.
Un motivo: nel difendere o motivare un’affermazione, il teologo può presupporre la verità di una proposizione dottrinale (ad esempio, «Dio ci ama»). Si può concordare o meno con il teologo su questo punto di partenza, ma le norme alle quali la teologia è soggetta consentono al teologo di presupporre la verità di una proposizione dottrinale.
Le cose stanno diversamente con la filosofia della religione. Se lo scopo è quello di difendere o motivare una certa affermazione, il filosofo della religione non può presupporre la verità di una proposizione quale «Dio ci ama». Certamente, può supporre per ipotesi che Dio ci ami e trarne una certa conseguenza C. Ma in tal caso, la sua conclusione sarà ipotetica: avrà la forma «Se Dio ci ama, allora C». Se il filosofo della religione vuol difendere o motivare C tramite la proposizione «Dio ci ama», deve difendere o motivare questa ultima proposizione.
In altri termini, il filosofo della religione deve partire da premesse «teologicamente neutrali» – premesse accettabili tanto da cristiani quanto da buddisti o musulmani, tanto da atei quanto da teisti.
Tuttavia non dobbiamo sottovalutare la (considerevole) sovrapposizione tra la filosofia della religione e la teologia.
Primo: il tentativo di capire meglio la natura dei concetti religiosi e il significato delle affermazioni religiose è parte tanto della teologia quanto della filosofia della religione.
Secondo: una parte importante di entrambe è la cosiddetta teologia naturale – il tentativo di mostrare sola ratione che vi è un Dio e che quel Dio ha alcuni attributi.
Terzo: sovente i teologi offrono argomenti che dipendono esclusivamente da premesse conoscibili sola ratione, anche quando stanno facendo teologia speculativa o dogmatica. Ad esempio, sant’Agostino e san Tommaso non di rado cercano di dimostrare che un modo eterodosso di intendere la dottrina dell’Incarnazione è errato in quanto logicamente incoerente, o incompatibile con la dottrina della Trinità.
Questo tipo di ragionamento appartiene sia alla filosofia della religione sia alla teologia (filosofica), anche se il contesto nel quale quel ragionamento figura potrebbe non essere (esclusivamente) filosofico.
1.3. Sinossi
La filosofia della religione si sovrappone a svariati rami della filosofia, comprese la metafisica, l’epistemologia, la logica filosofica, la filosofia della mente, e l’etica. Per questo motivo, in un volume agile come questo, sarebbe vana impresa mirare alla completezza. Ho quindi dovuto scegliere tra una trattazione meno approfondita di un numero più ampio di temi, e una trattazione più approfondita di un numero più limitato di temi. Ho optato per la seconda soluzione, nella speranza di poter almeno scalfire la superficie di alcune questioni di primaria importanza.
Buona parte di questo libro s’incentra sulla teologia (e la «ateologia») naturale.
Nel secondo capitolo, esporrò e valuterò i tre più celebri argomenti a sostegno dell’esistenza di Dio; nel terzo capitolo, esporrò e valuterò vari tentativi di dimostrare l’inesistenza di Dio (o di un certo tipo di Dio). Le dramatis personae in questi due capitoli saranno il teista – precisamente colui che ritiene che si possa dimostrare sola ratione l’esistenza di Dio; l’ateo – precisamente, colui che ritiene che si possa dimostrare sola ratione l’inesistenza di Dio; e l’agnostico – precisamente colui secondo il quale nessun tentativo di dimostrare sola ratione o l’esistenza o l’inesistenza di Dio è stato coronato da successo.
Potremmo essere portati a pensare che nel cercare di dimostrare l’esistenza di Dio, il teologo naturale inizi dando una definizione di «Dio» – specifichi cioè le condizioni (analiticamente, per definitionem) necessarie e sufficienti per essere Dio4 – e che successivamente egli cerchi di dimostrare che qualcosa (o qualcuno) soddisfa tale definizione di «Dio».
I teologi naturali di norma non hanno proposto questo tipo di argomento per l’esistenza di Dio. Questa forse è almeno in parte dovuta al fatto che è molto difficile specificare le condizioni analiticamente necessarie e sufficienti per essere Dio. A quanto risulta, se un individuo è onnipotente, onnisciente, perfettamente buono, increato creatore di ogni cosa diversa da lui, quell’individuo è senz’altro Dio. Ma anche se l’essere onnipotente, onnisciente, perfettamente buono, increato creatore di ogni cosa diversa da lui è una condizione analiticamente sufficiente per essere Dio, non è detto che sia anche analiticamente necessaria per essere Dio: non è di per sé incoerente supporre che un individuo sia Dio, pur non essendo perfettamente buono, purché quell’individuo sia l’onnipotente e onnisciente increato creatore di ogni cosa diversa da lui. Analogamente, a quanto risulta, se un individuo è (non un dio ma) Dio, è senz’altro il creatore increato di ogni cosa diversa da lui. Ma anche se l’essere il creatore increato di ogni cosa diversa da lui è una condizione analiticamente necessaria per essere Dio, non è detto che sia analiticamente sufficiente per essere Dio. Dopotutto, un solipsista potrebbe, senza alcuna incoerenza, credere di essere increato e di aver (vacuamente) creato ogni cosa tranne se stesso, senza credere di essere Dio.
Sono incline a ritenere che il termine «Dio» non abbia una definizione precisa e, quindi, che in certi casi non sia né vero né falso che una data condizione sia analiticamente necessaria (o analiticamente sufficiente) per essere Dio. È falso che l’essere tre persone in una natura sia una condizione analiticamente necessaria per essere Dio (altrimenti un ebreo non potrebbe, pena l’incoerenza, supporre che Dio è una persona in una natura). Ma forse non è vero né falso che l’essere perfettamente buono sia una condizione necessaria per essere Dio.
Comunque stiano le cose, i teologi naturali nel tentare di dimostrare l’esistenza di Dio, non partono di norma da una definizione di «Dio». Offrono invece un argomento con la seguente struttura: siccome (i) qualcosa (o qualcuno) ha una certa proprietà, e (ii) il possesso di quella proprietà è sufficiente per essere Dio5, (iii) qualcosa (o qualcuno) è Dio (equivalentemente: Dio esiste). A questo riguardo, basta tornare con la mente ai più famosi argomenti proposti per dimostrare l’esistenza di Dio: nell’argomento cosmologico, la proprietà impiegata nella prova è quella di essere una causa speciale; nell’argomento teleologico, è quella di essere l’artefice del mondo; nell’argomento ontologico è quella di essere insuperabilmente perf...
Indice dei contenuti
- 1. Introduzione
- 2. L’esistenza di Dio:la teologia naturale
- 3. L’esistenza di Dio: la ateologia naturale
- 4. Trinità e legge divina
- Cos’altro leggere
- Bibliografia
- Ringraziamenti
- L’autore