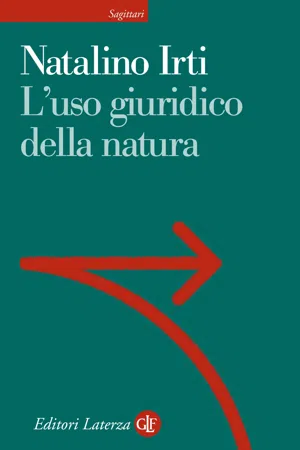1. Natura e ‘artificialità’ del diritto*
* Il testo nasce da una conversazione svolta il 18 settembre 2011, nel Festival della Filosofia promosso dai Comuni di Modena, Carpi, Sassuolo. Donde certo tono didascalico e sobrietà di richiami bibliografici.
1
Le due parole, diritto e natura, che figurano nel tema della mia conversazione, suscitano immagini diverse e lontane.
Diritto indica le leggi stabilite dall’uomo: diritto ‘positivo’ è, per l’appunto, l’insieme delle norme dettate da uomini ad altri uomini al fine di regolare la vita comune. La posizione di una norma è atto di volontà, il quale si rivolge ad altre volontà, e ingiunge rispetto e obbedienza. Se consideriamo una legge approvata dal Parlamento, subito sorge l’immagine di volontà che comandano ad altre volontà. Perciò le norme giuridiche si chiamano anche ‘imperativi’.
Se diritto è l’àmbito del posto, di ciò che la volontà umana è capace di costruire e demolire, di porre e de-porre, la natura è invece l’àmbito del trovato. Monti, fiumi e pianure – insomma, tutte le cose che stanno intorno a noi, ma non dipendono da noi, dalla nostra volontà costruttrice – è natura. Il diritto è un prodotto dell’uomo; la natura si produce da se stessa e per se stessa. Noi la troviamo nella sua provenienza dal passato, e la lasciamo nella sua destinazione al futuro.
Il diritto – si direbbe con Giambattista Vico – appartiene al ‘mondo civile’, che «certamente è stato fatto dagli uomini, onde se ne possono, perché se ne debbono, ritruovare i principî dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana». La natura appartiene al mondo naturale, «del quale, perché Iddio egli il fece, esso solo ne ha la scienza»1. Ma se mondo umano e mondo naturale stanno così, l’uno di fronte o di contro all’altro, perché il congiungersi nel nostro tema di diritto e natura?
Cominciamo con osservare che la parola legge ricorre, ed è dominante, in ambedue i mondi. Si parla di leggi giuridiche e leggi naturali, cioè di proposizioni che enunciano regolarità di eventi. Come le leggi naturali registrano l’uniforme e costante ripetersi di fenomeni (onde l’uno viene necessariamente dopo l’altro), così le leggi giuridiche descriverebbero, anch’esse, la rigida sequenza di due fatti: se uccidi, allora subirai una data pena; se cagioni un danno, allora sarai obbligato a risarcirlo; e via seguitando. Nelle une e nelle altre agisce l’idea di un dover essere, di qualcosa che, in determinate e precise circostanze, deve accadere. La legge lega gli eventi della natura; la legge lega le azioni degli uomini.
Non possiamo limitarci a questa notazione di carattere logico, e dire soltanto che leggi giuridiche e leggi naturali rispondono al medesimo schema ‘se A, allora B’. La comunanza della parola ‘legge’ richiede una spiegazione più profonda. L’identità della parola rinvia, o può rinviare, ad un principio superiore, che stia al di là delle due specie di leggi, e domini il diritto e la natura. Poiché le leggi servono a instaurare o manifestare l’ordine, che sia ordine degli uomini o ordine delle cose, è spontaneo volgersi a un universale principio di ordine, a cui siano assoggettati il mondo civile e il mondo naturale. Allora il dualismo, e l’antitesi, si convertirebbero in unità; e le due specie di leggi, le giuridiche e le naturali, si collocherebbero all’interno di un Tutto, di un’unica e superiore legge cosmica.
2
Questa unità del Tutto, unità del kósmos che abbraccia e genera l’ordine del diritto e l’ordine della natura, fu pensata dalla Grecia antica con irripetibile sublimità di tono e di parola. Díke regge l’ordine universale. Díke, parola intraducibile, esprime misura, limite, garanzia della legge cosmica contro ogni tentativo di separazione, distacco, inosservanza. Díke, figlia di Zeus e Temi, regola il corso delle stagioni e il corso delle vicende umane; e Díke evoca Antigone, nella tragedia sofoclea, contro il decreto di Creonte: Díke da cui provengono «le leggi non scritte e incrollabili degli dèi. Infatti, queste non sono di oggi o di ieri, ma sempre vive, e nessuno sa da quando apparvero»2. Non leggi di natura, ma leggi poste dalla divinità. Bene annota un grande studioso di Sofocle: «Qui non c’è diritto contro diritto, idea contro idea, bensì il divino come ciò che tutto comprende, con il quale la fanciulla si sa in armonia, di contro l’umano in quanto limitato, cieco, estraniato da se stesso, deformato e falsificato in se stesso»3.
Non filosofo né storico della filosofia, oso sottoporre alla nostra rapita attenzione tre frammenti di Eraclito, dell’altero e ‘oscuro’ Eraclito. Dice l’uno: «Quest’ordine universale, che è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dèi o tra gli uomini, ma sempre era è e sarà fuoco sempre vivente, che si accende e si spegne secondo giusta misura»; il secondo: «Elios, infatti, non oltrepasserà le sue misure; ché, altrimenti, le Erinni, al servizio di Díke, lo troverebbero»; l’ultimo: «È necessario che coloro che parlano adoperando la mente si basino su ciò che è comune a tutti, come la città sulla legge, ed in modo ancora più saldo. Tutte le leggi umane, infatti, traggono alimento dall’unica legge divina: giacché essa domina tanto quanto vuole e basta per tutte le cose e ne avanza per di più»4.
In quest’ordine cosmico, non mai nato né mai creato, si collocano leggi umane e leggi naturali, e il diritto vi trova la propria verità e immutabilità. Il cosmo è in se stesso una verità visibile. Sono stati raccolti e studiati numerosi «luoghi d’autori, in cui i concetti di verità e di diritto appaiono fianco a fianco»5. Díke e alétheia, giustizia e verità, s’incontrano nel medesimo cammino. Certo ogni città greca ha il proprio diritto, ma questo nómos non è qualcosa di accidentale e arbitrario, di mutevole e caduco. Il nómos era «l’espressione di una coscienza di eternità»6, in cui si ritrovavano e coincidevano volontà degli antenati e volontà degli dèi.
Nella più antica grecità, nómos e phýsis, nómos e Díke, non sono separati e divisi, ma tutti manifestano la profonda unità dell’universo, obbediente, così nel corso degli astri come nella storia degli uomini, alla medesima legge. Fisica, etica e diritto sono sottomessi a leggi comuni e universali. Nessuno si interroga circa il fondamento e la validità di queste leggi: «Le leggi, le morali e le giuridiche, sono quelle che sono, una volta per sempre, l’individuo non deve far altro che obbedire»7. «Là dove autorità e tradizione esercitano un incontestato dominio, le sole norme che appaiano naturali sono quelle in vigore, o, per parlare più esattamente, il loro rapporto con la natura non costituisce in modo alcuno oggetto di dubbio, e nemmeno di discussione»8.
È significativo che Ernst Cassirer, esule dalla Germania nazista, ricostruendo nel 1941 lo sviluppo del pensiero greco intorno a Lógos, Díke e Kósmos, non si trattenga dall’esprimere l’ansia per l’avvenire, sul quale «grava una durissima minaccia quando non sia possibile stringere di nuovo il legame fra verità e diritto, fra lógos e díke, nello stesso modo in cui i Greci lo hanno stretto per primi nella storia dell’umanità»9.
3
L’unità, pensata dai Greci, è unità del Kósmos governato da Díke, dove ordine del diritto e ordine dell’essere obbediscono al medesimo e superiore principio: né naturalismo delle cose né volontarismo delle leggi umane, ma un Tutto che le comprende e guida. In qualsiasi tempo la filosofia tenterà di ricondurre ad unità diritto e natura, sempre si mostrerà necessario un principio unificante, capace di dominare il mondo degli uomini e il mondo delle cose, i quali, nel loro isolamento e allontanamento, vanno, per così dire, trascesi.
La rottura dell’antica unità avviene con la Sofistica del V secolo a.C.: un capitolo decisivo e insuperabile nella storia del diritto, tale che uno studioso italiano, Marcello Gigante, nello splendido libro Nomos Basileus10, si è spinto a scrivere: «il fondamento teorico della dottrina generale del diritto nel XX secolo riassume il momento speculativo della Sofistica greca del V secolo». Poiché la dottrina generale del diritto nel XX secolo – e, aggiungo, nel XXI – è dottrina del diritto positivo, cioè di norme fatte dagli uomini, separate o contrapposte alla natura e divelte da un ordine cosmico, la Sofistica greca si rivela di essenziale importanza. Il giurista di oggi – o, almeno, il giurista di indirizzo normativistico – ragiona, nei principî e nel metodo, come i lontani antenati del V secolo a.C.
Allora si determinò l’antitesi di nómos e phýsis, di convenzione e natura, di opinione e verità. Non essendo più strette nell’ordine cosmico, leggi umane e leggi naturali si separano e allontanano: alle prime può sempre muoversi l’accusa di discostarsi dalle seconde, di violarle e trasgredirle. Quella antitesi fa emergere due profili: che nómos, appunto perché è fatto dagli uomini mercé convenzioni, è artificiale e innaturale; che – come sentenzia Protagora – «di tutte le cose misura è l’uomo: di quelle che sono, per ciò che sono, di quelle che non sono, per ciò che non sono». L’uomo sta soltanto su se stesso e trae tutto da se stesso: «Riguardo agli dèi – è ancora parola di Protagora – non ho la possibilità di accertare né che sono, né che non sono, opponendosi a ciò molte cose: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana»11.
4
Caduto l’ordine cosmico, la soggettività irrompe nel mondo, stabilisce i nómoi, interpreta la natura, genera discordanze e conflitti. L’irruzione della soggettività, del singolo con la sua identità, centro di conoscenza e di azione, misura dell’essere e del non essere, ha un’importanza filosofica e storica da non temere confronti con altri eventi della storia umana. «Così l’uomo subentra alla natura come centro di speculazione. Sotto vari aspetti, un umanismo, nel senso più largo della parola, subentra al naturalismo della filosofia anteriore»12.
Uomo e natura, opinione e verità, sono divisi e contrapposti, ed ecco nascere l’idea di un diritto naturale, ossia di un diritto ricavato da phýsis, e messo di fronte o di contro al diritto positivo. Poiché non c’è più un principio sovrastante, si traggono dalla natura le ragioni di dissenso nei confronti del diritto positivo. Il quale può essere avversato, e tale si presenterà nel corso dei secoli, o sul proprio terreno della volontà umana, opponendo volontà a volontà, o invocando di contro ad esso un altro principio, diverso dalla volontà e superiore alle lotte dei mortali. Quando diciamo una legge positiva ‘in-giusta’, assumiamo un criterio capace di qualificare una legge come ‘in-giusta’: ora, questo criterio può esser dato dalla umana volontà di mutamento, volontà di altra legge positiva (e ne nasce l’antitesi fra jus conditum e jus condendum); o da una fonte diversa dalla umana volontà, e così dalla natura in cui troveremmo il principio superiore e giudicante. Giudicare una legge non si può se non in forza di un criterio: nessuna legge è ‘in-giusta’ in sé; tutte sono giudicabili mercé il raffronto con un’altra legge, o che sia desiderata e promossa dalla volontà umana o dettata da una potenza diversa (come, per l’appunto, dalla natura).
Ma la natura, la phýsis innalzata contro il nómos, va interpretat...