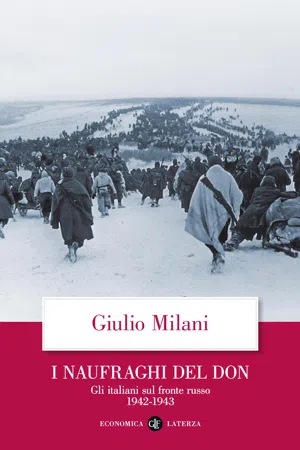«Ghe rivarem a baita?»
1. Impressioni di settembre
Tra il 20 agosto e il primo settembre del 1942, l’Armir si oppose nella cosiddetta prima battaglia difensiva del Don alla controffensiva della 63a armata sovietica: l’esercito russo portò avanti l’operazione, in concomitanza con l’azione della 21a armata contro il XVII corpo tedesco agli ordini del generale Friedrich Paulus, nella più ampia cornice della battaglia del Volga per la difesa di Stalingrado.
La prima battaglia difensiva del Don fu combattuta principalmente dalle divisioni Sforzesca e Pasubio, quando ancora le truppe alpine e i rincalzi del XXXV corpo d’armata stavano ultimando l’insediamento nel settore a loro assegnato: un versante di centottanta chilometri in linea d’aria, che diventavano, seguendo il corso del fiume, duecentosettanta chilometri di fronte sinuoso, con ondulazioni comprese tra i cinquanta e i duecentocinquanta metri sopra il livello del mare, per una media di trentaquattro chilometri di ampiezza affidati a ogni divisione; in termini effettivi, una linea difensiva lunga sei chilometri, e spesso quasi del tutto priva di altezza e di profondità, per ognuno dei sei battaglioni di fanteria di cui si componevano le divisioni italiane.
Lo sfondamento russo dimostrò tutta la fragilità di uno schieramento di forze così esteso e concepito, e anticipò – senza che l’alto comando tedesco provvedesse in alcun modo –, il disastro che si sarebbe prodotto con l’avvio dell’operazione Urano, a metà novembre, e dell’operazione Piccolo Saturno il mese dopo: se solo l’attacco della fanteria russa contro la Sforzesca fosse stato supportato dalle divisioni corazzate, come sarebbe avvenuto nel corso della seconda battaglia difensiva del Don, la ritirata sarebbe iniziata sin da allora.
La divisione era infatti giunta un mese prima dall’Italia, dopo una breve riorganizzazione successiva al duro impiego sul fronte albanese, e aveva l’ala destra scoperta da una testa di ponte collocata sulle alture della sponda occidentale del fiume – generalmente in netto predominio altimetrico sulla riva sinistra, tenuta dai russi –, una zona boscosa dalla parti di Bobrowskj, nel settore di pertinenza della 79a divisione tedesca: quest’ultima aveva avvicendato la Celere dopo la battaglia di Serafimovič, che il 14 agosto aveva coronato l’avanzata estiva. A quel punto, il XXXV corpo d’armata aveva conservato, del vecchio Csir, la sola divisione Pasubio, poiché la Torino era passata agli ordini del XXIX corpo d’armata tedesco e la Celere a disposizione del comando della 6a armata di Paulus. Al posto di queste divisioni di veterani, la Sforzesca era costituita per lo più da reclute del ’22 e del ’23: Nicastro fece parte di una colonna di rinforzi, quando all’alba del 20 agosto il 54° reggimento Umbria venne attaccato in forze alle proprie spalle e subì gravissime perdite nel giro di poche ore; il conseguente sbandamento fu tale che un relata refero di Radio scarpa soprannominò cikaj, “scappa”, i giovanissimi fanti del II e del I battaglione sorpresi nel sonno – alcuni perfino in pigiama –, prevalentemente per la circostanza che lo sbarco delle truppe sovietiche era avvenuto in un settore che i tedeschi avevano prima lasciato sguarnito, senza avvertire il Comando della Sforzesca, e poi non avevano soccorso con la rapidità e il coordinamento indispensabili in quel frangente. La compagnia di Nuto Revelli – la 46a del battaglione Tirano, 5° reggimento alpini –, incontrò le autoambulanze con i feriti e gli sbandati appesi a grappoli, mentre convergeva con altre compagnie del 6° alpini – di cui facevano parte quelle del battaglione Val Chiese e del Vestone di Mario Rigoni Stern –, per chiudere la falla al prezzo di perdite molto pesanti.
La controffensiva russa era stata alimentata, negli undici giorni di battaglia, portando da dieci a ventisette i battaglioni d’impiego, e fu arginata con la carica della cavalleria a Izbušenskij, il 24 agosto, e l’intervento della Tridentina, richiamata d’urgenza dalla marcia verso il Caucaso, il primo settembre. Il piano raggiunse in ogni caso il suo obiettivo tattico: nel settore italiano, i russi ampliarono la testa di ponte di Verčne Mamon sulla riva destra del fiume, allo scopo di porre il vertice dell’ansa fuori dalla portata di tiro delle artiglierie di medio calibro, e nel contempo conservarono quella di Ogalev-Abrosimovo – il cosiddetto cappello frigio, per via della sua conformazione –, come pedane di lancio delle armate 6a e 1a guardie nell’operazione Piccolo Saturno; al confine tra l’ala destra della Sforzesca e l’estremità sinistra del settore tenuto dalla 6a armata germanica, invece, rafforzarono la testa di ponte a est della foce del Chopër, tra Kletskaja e Kremenskaja: alla fine di settembre, quel che restava del Csir si sarebbe in parte spostato più a nord nel settore del medio e alto Don, lasciando la pericolosa area di boschi e paludi tra Serafimovič e Kletskaja, la cui difesa era già costata millesettecento morti alla 3a divisione Celere nell’avanzata di luglio, alle divisioni della 3a armata rumena, che si erano appena avvicendate ai tedeschi in quel settore del fronte. Le truppe russe, il 19 novembre, passarono proprio da questo varco, aperto già in agosto sulla Sforzesca, per correre ad accerchiare le forze germaniche che assediavano Stalingrado: era l’inizio dell’operazione Urano, una delle più gigantesche manovre di accerchiamento militare di tutti i tempi e punto di svolta dell’intero conflitto.
2. Il fronte sul Don
Al termine del ciclo di operazioni estive era stato concordato, all’interno del gruppo armate B, lo schieramento definitivo dell’Armir, che sarebbe stata dislocata tra la 2a armata ungherese a nord-ovest e la 3a rumena a sud-est, disponendo alcune divisioni tedesche a stecche di balena per rinforzare l’esile copertura di quel complesso difensivo.
Vennero intrapresi lo scavo di trincee e l’erezione di casematte e alloggiamenti riscaldati, con l’idea di riprendere in primavera l’offensiva verso oriente. La compagnia di Dino Baravelli, la 108a della Julia, battaglione L’Aquila, a settembre aveva preso posizione lungo un trinceramento tedesco appena abbozzato, e si era messa all’opera per migliorare l’esistente e costruire nuovi bunker, capaci di ospitare ognuno una ventina di soldati. Incassati nella terra o nel tenero calcare della sponda rialzata del Don, i rifugi venivano realizzati impiegando travi di betulla, intelaiature di isbe e costruzioni distrutte e il resto del legname che proveniva dalle estese boscaglie dei dintorni disposto a terra come pavimentazione; sopra il tetto si prevedeva invece uno strame di copertura per mimetizzare il costruito.
Dentro, gli alpini stavano bene. Il rifugio era il caldo della casa, il contrario della guerra: come le isbe delle retrovie, e soprattutto quelle della ritirata; con la differenza che l’isba era fragile, con le sue pareti di canne e di piccole assi intonacate, il tetto in paglia, e aveva il fulcro nel grande forno a legna centrale dove gli abitanti ricavavano anche lo spazio per il giaciglio dei bambini e degli anziani: calda com’era, rappresentava quanto di meglio esistesse per superare l’inverno russo. Ogni squadra, nel proprio bunker, si arrangiava invece bruciando la legna nei bidoni, con tutte le scomodità di una vita da sequestrati al mondo dei civili; ma quando la pattuglia rientrava dalla missione ritrovava il caldo e il tempo della casa, gli scherzi da commilitoni e le risate.
Amerigo Martelli, artigliere della 41a compagnia della Julia, da settembre alla fine di novembre non aveva sparato una fucilata. Lungo il fiume, finché il gelo non lo ghiacciò, erano a disposizione piccole imbarcazioni sulle quali le pattuglie dell’uno e dell’altro schieramento si davano il turno per salirvi in ricognizione, neanche fossero d’accordo. Russi e italiani si incontravano e scambiavano battute, in qualche caso perfino da bere e da fumare. Per come filava liscia, e per il poco che c’era da fare, a qualcuno sembrava una specie di villeggiatura. Finché durò, fu anche bello. Amerigo, poi, faceva il portaferiti e non era mai di pattuglia. Ma chi prendeva parte alle missioni di osservazione raccontava di passare intere ore insieme ai russi. Qualcuno aveva imparato la lingua e si offriva spesso volontario, soprattutto di guardia, la notte, quando fraternizzare riusciva più facile. Chi era il nemico, d’altra parte? Nessuno sparava, in quel settore. Nelle trincee, gli artiglieri di Martelli passavano il tempo a rinforzare i bunker e a scavare, soprattutto, il fosso anticarro indispensabile nell’eventualità di un attacco corazzato – ipotesi che impensieriva tutti –, oppure giocavano a carte o si scambiavano le visite da un rifugio all’altro: per questi alpini, allora, il nemico era soprattutto il freddo e la distanza da casa.
Ogni batteria, sul Don, governava un settore di tre chilometri, e lì scavava i bunker. Al fronte, Angelo Neri fu impiegato per stendere il filo telefonico dalla batteria cannoni agli alpini sull’argine del Don. Ogni volta, i mortai russi interrompevano la linea, sicché la notte dovevano cercare il guasto e riaccomodarlo. Era un lavoro pericoloso. Quando capitava sotto il fuoco nemico, Angelo se lo sentiva sempre addosso: «Arriva, arriva!», gridava. Ma il suo vecio, che aveva fatto la guerra di Grecia e riusciva a riconoscere la provenienza e la traiettoria dei colpi grazie al fischio di emissione, gli spiegava che stavano sparando oltre: solo quando il proiettile perdeva la velocità e sentivi questo plap, plap, plap rallentato, allora significava che il colpo stava arrivando così vicino che poteva essere anche il tuo, e il vecio gridava: «Stai giù, Neri!».
Come si riconoscevano, infatti, la traiettoria e il tipo del proiettile? Che rumore faceva quando era in avvicinamento? Queste erano le domande che animavano quotidianamente le discussioni, e che i più giovani facevamo agli anziani. Ogni arma, infatti, aveva la sua acustica. Il mortaio, per esempio, sparava un colpo secco. Un tiro su tre andava a bersaglio: il primo poteva arrivare dieci metri oltre, il secondo cinque metri prima, ma il terzo colpo era il tuo. I veci, in questo, dimostravano tutta la loro importanza. Ti davano informazioni, ti incoraggiavano. Poi c’era Radio scarpa: le notizie volavano da un soldato all’altro prima ancora, alle volte, che ne venissero a conoscenza i superiori. Si veniva a sapere di tutto, dalla voce di uno scontro alla cattiveria che potevano aver fatto i tedeschi contro dei civili, un’impiccagione, una fucilazione illegittima o legittima. Certo, non sempre le informazioni erano affidabili, ma in certi casi lo risultavano fino al dettaglio.
Oltre a questo, si costruivano o si rinforzavano i bunker e si montava di guardia. Di notte, però, non si poteva restare all’esterno per più di quindici minuti. Gli alpini di Neri avevano in dotazione soltanto la mantellina, le fasce alle gambe, e gli scarponi di cuoio con due paia di calze. Il cappotto non lo videro nemmeno in cartolina. Una volta, il tenente Bevilacqua venne a fare un’ispezione. In queste circostanze Neri avrebbe dovuto avvertire il picchetto e gli altri che si trovavano dentro il bunker, a qualche metro di distanza, tirando una corda collegata a un batacchio che batteva dentro il bossolo d’un proiettile di grosso calibro, a mo’ di campana. Era un sistema ingegnoso per non abbandonare la postazione di scolta. Sfortuna volle che in quell’occasione qualcosa avesse interrotto la fluidità del tiraggio, un nodo o un garbuglio, per cui la campana non suonava. Il tenente, fermo nella neve, stava congelando. Chiamava Angelo per nome e gridava il suo, ma Neri non poteva dargli il passo. C’erano ordini precisi. Sicché lo teneva sotto il tiro del fucile, all’altolà, e non poteva lasciare la postazione né poteva farlo avanzare senza la presenza degli uomini del picchetto che conoscevano la parola d’ordine per l’ispezione. Fu un pasticcio. Alla fine, quelli vennero su per conto proprio, quando si accorsero che era passato il quarto d’ora oltre il quale la sentinella si sarebbe congelata.
Nelle tane, invece, capitava anche di trovare il tempo per leggere le lettere da casa. Angelo aveva una madrina di guerra delle sue parti, una certa Lina Chiari di San Benedetto in Alpe, in provincia di Forlì, che in seguito avrebbe sposato un inglese, quando il fronte passò da quelle parti: le lettere di Lina gli arrivavano con regolarità, dopo sei giorni al massimo, mentre quelle dei suoi genitori portavano ritardi anche di due settimane o non gli giungevano affatto. Con la madrina di guerra, d’altra parte, Angelo scambiava impressioni abbastanza generiche, anche perché il timore per la censura stimolava la sintesi. Magari accennava qualche discorso sui civili russi, sulle donne, il cibo, sulla vita in Russia in generale, cose che potevano interessare due giovani. Per esempio, un aspetto che lo aveva colpito moltissimo erano questi immensi campi di girasole e di patate. I tuberi russi, soprattutto, erano speciali. Cuocendoli sulle stufe, diventavano buoni e croccanti come brigidini. Durante la marcia di avvicinamento li svuotavano e li riempivano d’olio di girasole, e poi, con una stringa o un pezzetto di stoffa per stoppino, ci facevano lumini: ne irradiava una luce soffusa, che non correva il rischio di far prendere fuoco alla tenda o di renderla troppo visibile all’esterno: potevi leggere e scrivere tranquillamente.
In mezzo al fiume, davanti all...