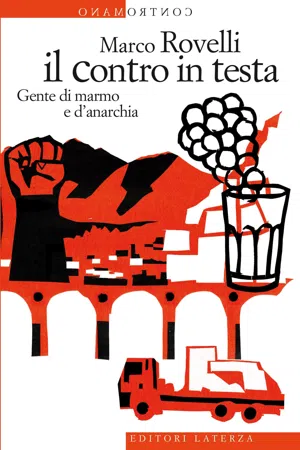Il sale della terra
All’osteria mi insegnarono il brindisi alla carrarina. Perché questa è un’osteria della campagna massese, sì, ma sta appena sotto le colline del Candia, e il Candia richiama anche i carrarini. Uno di loro mi ha preso per un braccio una sera che si cantava, “Vieni qui che ti offro un bicchiere”, e tu mica puoi dirgli che ce l’hai già sul tavolo e ne hai bevuto anche tanto, è buona educazione accettare. Alza il bicchiere, anzi il bicierin, il “goccio di vino” che si può scolare tutto d’un fiato. Brinda, e quel brindisi somiglia molto a un rito. Si leva il bicierin in alto, lo si fa digradare verso terra, poi lo si porta a sinistra e infine a destra: un segno della croce, insomma, e l’importante è che l’occhio non perda mai di vista il vino. Si salmodia nel gesto apotropaico: “ciar i è ciar, muss’lin a ni né, te ’n t’l vo, te nemanc, al bev me” (chiaro è chiaro, moscerini non ce n’è, te non lo vuoi, te neanche, lo bevo io). Va da sé che si pronuncia l’ultimo verso levando il bicierin alla bocca per assimilare il Verbo.
“Sai qual è la frase migliore per definire il carrarino? Il contro in testa”.
Silvano veniva di tanto in tanto all’osteria, e mi diceva della differenza ontologica tra massese e carrarese.
“Il massese è molle. È rimasto sempre un contadino, servile. Il carrarino no, il carrarino non si piega, è fiero, schiena dritta. Ha il contro in testa il carrarino”.
“E che significa?”.
“Per spaccare il marmo devi capire qual è la linea giusta, il suo verso. Se la segui, tagliarlo è facile. Se invece provi a tagliarlo diciamo al contrario, se vai contro il verso, non ci riesci: non c’è verso, proprio. E quello si chiama contro.
Ecco, i carrarini hanno il contro in testa, sono duri, resistono, e non c’è verso di scalfirli. Non c’è il verso, proprio”.
Il marmo è come la vita, morbido al verso e duro al contro.
“Solo che avere il contro in testa non è facile. È un bel fardello da portare. Che se ti trovi in periodi di piena va bene, sei un ribelle, ti unisci con gli altri e allora guai a chi vi tocca. Se Carrara è terra di anarchici ci sarà un motivo, no? Ma in tempi di secca, quando nessuno ha speranze di trasformare questo mondo, allora avere il contro in testa non è bello, vai contro il tuo vicino, il tuo compagno, il tuo amico. Tutti a parlar male dell’altro, a farsi guerra l’un con l’altro. Non è bello”.
Silvano alzò il bicchiere e se lo scolò d’un sorso. Niente brindisi. “È un mondaccio questo. E mi sto stufando di questa terra”.
***
Silvano l’ho incontrato di nuovo dopo alcuni anni, tra le bandiere nere e rosse alla fine del corteo del primo maggio anarchico a Carrara. Un corteo di canti, una ritualità antica, corone di fiori rossi alle lapidi. Tante. Troppe, visto che dietro ognuna di quelle lapidi c’è una vittima da ricordare. Le vittime dei moti del 1894 alla caserma Dogali, Giordano Bruno in piazza del Duomo, Alberto Meschi storico sindacalista d’inizio Novecento, e per finire i morti alle cave e Francisco Ferrer educatore anarchico, le due lapidi che stanno nella piazza dove di solito arriva il corteo. La piazza ufficialmente si chiama piazza Alberica – dal duca Alberico I dei Cybo Malaspina, il sovrano che la volle nel Seicento –, ma per gli anarchici continua a essere piazza Gino Lucetti, l’anarchico che attentò a Mussolini e per un soffio lo mancò, in un tragico impeto di sfortuna: la bomba rimbalzò sul tetto della macchina del Testa di Morto, esplodendo solo toccando terra e ferendo sei persone plaudenti. Lucetti venne imprigionato a Napoli, liberato dagli americani nel 1943, ma dopo poco morì nell’affondamento di un motoveliero, colpito da fuoco amico.
A Lucetti venne dedicato il battaglione partigiano libertario sui monti apuani, a lui venne dedicata la piazza, che nel 1960 tornò all’antica denominazione per gli stradari ufficiali. Non per gli anarchici, però, che nei loro manifesti di convocazione della giornata continuano a scrivere “piazza Gino Lucetti”.
Eravamo in piazza Lucetti alla fine del corteo, al banco sotto le logge dove si distribuivano fave e formaggio e vino, mentre dietro un coro improvvisato accordava le voci sul Canto dei malfattori.
“Quanto tempo”, mi ha detto, “come stai? Ci sei anche te, bravo, sono contento. Io era un po’ di tempo che non venivo”.
“Sì, in effetti non ti avevo mai visto qui”.
“To’, prendi”.
Mi allunga il bicchiere di plastica, mi versa il vino.
“Non ero più venuto negli ultimi anni, non ci credevo più. Prima ne ho fatti di cortei, eh. Ma poi lo vedi, non si riesce a far niente. Siamo rimasti in pochi, e i padroni spadroneggiano. Lo sai, io lavoro in cava, è uno schifo ormai. Anche tra lavoratori, è tutto un fregarsi a vicenda. Ormai però me ne sono fatto una ragione”.
“E quindi vieni per celebrare il rito”.
“Vuoi dire che questa è una processione?”. Ride: “Eh sì, è anche quello, è una cosa religiosa in qualche modo. Qui c’è tanta fede”.
“Insomma vieni per tenere accesa la fiaccola dell’anarchia, hai finalmente accettato di fare il testimone”.
“No, quello no. Non è solo testimonianza. Vedrai che questa fiaccola nei prossimi anni torna utile. Perché qui sta per scoppiare tutto, la gente non ce la fa più. Il fuoco cova, caro mio. Cova dappertutto. Senza riguardo per le frontiere, vedrai”.
Un altro bicchiere, e ancora una volta il brindisi alla carrarina.
“A Massa non ce l’avete mica un brindisi così, però”.
***
Massa, Carrara. È solo una collina a dividerle, e compartiscono la medesima catena montuosa, ad essa abbarbicate, in due concavità contigue. (Carrara è più abbarbicata, e questo segna la differenza fondamentale.) Nonostante lo storico campanilismo, la solita pantomima rivalitaria, io credo che assai più forte sia la comunanza tra i due borghi selvaggi. A partire dalle Alpi Apuane che li tengono a bada. Apuania, allora, come accadeva durante l’era fascista, converrà chiamare quest’area unitaria, fatta di due città che si sentono tanto più distanti quanto più forti sono le omologie.
La rivalità tra le città sorelle o cugine (potremmo argomentare all’infinito quale metafora conviene di più, le metafore del resto sono fatte per questo) si nutre di una separatezza geografica ben esile, ovvero le colline del Candia. L’antica mulattiera venne sostituita nel 1807 da una moderna strada postale progettata dagli ingegneri di Napoleone, la strada della Foce. Altre cose innovative fecero i francesi (oltre a lasciare in eredità la parola “franchi” per dire soldi: un termine ormai in via di estinzione), come la distruzione della chiesa di San Pietro in piazza Aranci, davanti al Palazzo Ducale: secondo mito vuole, Elisa Baciocchi in Bonaparte desiderava vedere il mare dalle sue finestre, e la chiesa ostruiva la vista. Fuori dal mito, in realtà lo scopo della principessa – che credeva di poter fare a meno dell’appoggio dei preti – era quello di avere una piazza ampia, “alla francese”, non ingombrata da quella chiesa sbilenca e cadente, che peraltro non ostruiva la vista sul mare. Cionondimeno in molti hanno dato credito alla fola, senza dubbio messa in giro dai preti. Ché a Massa i preti hanno sempre avuto il loro bel peso. Proprietari terrieri, e di molte anime in placida conseguenza di ciò.
A percorrere la strada della Foce – una strada in collina con i boschi che di tanto in tanto bruciano, tra piccole cave e case sparse – mi sono sforzato di vedere il fantasma che ha segnato l’immaginario di questa terra: quello delle plebi in sommossa durante i moti del 1894, alla cui lapide sulla caserma Dogali si mette la corona di fiori il primo maggio.
Mi è sempre piaciuta questa storia. Sui manuali dei licei c’è scritto moti di Lunigiana, perché ancora nell’Ottocento la Lunigiana comprendeva Massa e Carrara (mentre oggi si intende unicamente l’entroterra, da Aulla a Pontremoli, che con le due città di costa non ha molto a che spartire). Furono, in realtà, moti di Carrara e, in sottordine, di Massa. In ogni caso, di apuani di montagna.
Era sulla strada della Foce che una delle bande degli insorti aveva eretto la prima rudimentale barricata, fermando due carri trainati da buoi, carichi di blocchi di marmo, e mettendoli di traverso. Era il 13 gennaio, e l’insurrezione carrarina avrebbe contagiato l’Italia, i dimostranti ne erano certi. Del resto in Sicilia il fuoco era già stato appiccato, dai Fasci Siciliani, e in parecchie altre città a dimostrare erano grandi folle. La banda che veniva da Ortonovo aveva con sé una bandiera nera, orlata di rosso, con scritto in caratteri d’oro: Fascio Operaio. Era la rivoluzione.
“Domani i soldi italiani non hanno più valore perché deve entrare un nuovo governo”, si diceva in giro. Riportano le relazioni di polizia che un tale Alessandro Merlini disse a un tale Andrea Spagnuoli, il quale stava andando a trovare la fidanzata: “questa sera non si fa l’amore perché dobbiamo andare a Carrara a fare la dimostrazione”. Quella dimostrazione a cui l’amore andava sacrificato doveva essere la scintilla della rivoluzione.
La scintilla fu dunque sulla Foce: e non so quale tenace apuano spirito abiti quel luogo, se è vero che proprio sul valico della Foce sarebbe iniziata la Resistenza, l’8 settembre del ’43, quando gli alpini del Battaglione Val di Fassa si unirono ai cittadini che finalmente potevano reagire e dettero battaglia ai tedeschi.
Ma l’insurrezione del 13 gennaio si risolse in un massacro. Non riuscì l’effetto sorpresa, le bande non presero il controllo della città, e quando arrivò l’esercito la manifestazione delle genti di montagna venne repressa nel sangue: fucilate sui quattrocento che avanzavano, dieci morti sul terreno.
A Massa venne instaurato il Tribunale di Guerra, che in tre mesi comminò 454 condanne per oltre 2500 anni di carcere. Più del 60 per cento dei condannati erano cavatori.
Galileo Palla, anarchico lunigianese trapiantato a Massa, che sulla montagna massese aveva predicato il verbo anarchico, ed era definito nei documenti di polizia “il primo della lista degli anarchici più pericolosi della Provincia di Massa Carrara”, ebbe a dire che “in Carrara anche le pietre sono anarchiche”: ebbene, questo anarchismo non poteva non spargersi come polvere di marmo su tutto il territorio circostante.
Lo stesso Palla aveva scritto due anni prima agli anarchici di Massa, in un momento di crisi politica (pareva ch’essi volessero appoggiare l’elezione di un deputato): “Sappiate imitare Carrara, consorella di Massa”. Due città sorelle, dunque. È questo il punto, prima e al di là dell...