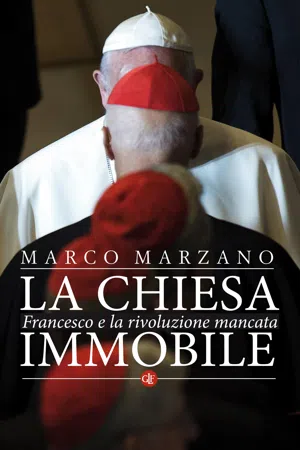I.
Francesco il riformatore mancato
L’elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio di Pietro è stata percepita come una novità di immensa portata. Hanno contribuito a questa percezione, in primo luogo, l’enorme sorpresa delle dimissioni del suo predecessore, il fatto di provenire «quasi dalla fine del mondo» e cioè dal Sudamerica latino e non, come molti immaginavano nei giorni del conclave, dal ricco Nordamerica, e poi soprattutto alcune sue qualità personali e talune scelte inedite e spiazzanti: da quella, coraggiosa e ambiziosa, di adottare – per la prima volta nella storia del papato – il nome del santo di Assisi, ovvero del più grande simbolo cattolico del rinnovamento ecclesiale e della povertà davvero predicata, a quella di annunciarsi come vescovo di Roma prima ancora che come pontefice universale, di salutare i fedeli con un semplice «buonasera», di invitare il popolo a pregare con lui e per lui. Francesco ha fatto da subito mostra di uno «stile» decisamente differente da quello dei suoi predecessori: ha scelto di abitare a Santa Marta (rinunciando, per qualche verso, all’uso della «reggia pontificia»), di continuare a portare da sé, come faceva quando era vescovo di Buenos Aires, la sua vecchia borsa, di indossare mocassini piuttosto usati anziché scarpe più preziose, di predicare con un linguaggio semplice e accessibile, e di buttare all’aria molti discorsi preparati preferendo improvvisare e parlare a braccio.
In questi anni, papa Bergoglio ha sorpreso tutti molte volte: ad esempio, quando ha rilasciato clamorose conferenze stampa sugli aerei che lo riportavano a casa (la più celebre è quella in cui ha pronunziato quel «chi sono io per giudicare un omosessuale?» che ha fatto immediatamente il giro del mondo) o quando ha intessuto dialoghi appassionati con conclamati miscredenti, quali il fondatore del quotidiano «la Repubblica» Eugenio Scalfari, o ancora quando si è recato a Lampedusa per denunciare la disumanità della mancata accoglienza dei migranti sulle nostre coste o in carcere a lavare i piedi a una detenuta musulmana. La Roma «bene» e papalina rimase sconcertata quando, a poco più di tre mesi dalla sua elezione a pontefice, disertò il concerto organizzato per lui nella grande sala delle udienze del Vaticano e in tanti sono rimasti colpiti dal fatto che si metta in fila con il vassoio in mano nella mensa di Santa Marta o che abbia pagato il conto dell’albergo dove aveva soggiornato nei giorni del conclave che lo elesse papa.
Insomma, dal punto di vista del messaggio spirituale, e soprattutto dei mezzi (del linguaggio) con i quali lo ha comunicato, papa Francesco rappresenta certamente una novità assai rilevante nello scenario religioso e politico globale. Si può applicare lo stesso generoso giudizio sull’attività di Bergoglio come riformatore della sua organizzazione, come iniziatore di quella grande trasformazione della Chiesa di cui tanti riformatori cattolici e una parte dell’opinione pubblica attendono con trepidazione l’inizio?
La grande riforma della Chiesa cattolica
La Chiesa cattolica potrebbe rispondere alle grandi domande di cambiamento che provengono dal suo interno e dall’esterno, dai fedeli cattolici e dalla società civile mondiale, realizzando delle grandi riforme, cioè mettendo mano ad una modificazione profonda di alcune sue caratteristiche strutturali. Questa eventualità è, data la sua articolazione organizzativa e la sua natura di monarchia elettiva, fortemente dipendente dalla volontà del suo leader, il papa, che può prendere l’iniziativa di avviare le riforme praticamente in tutti i campi della vita ecclesiale. Il quesito allora diviene per noi il seguente: cosa avrebbe dovuto o dovrebbe fare di preciso Francesco per soddisfare le istanze riformatrici, per cambiare la fisionomia della Chiesa cattolica? È una domanda non banale, perché ci impone di uscire dalla superficialità di tante enfatizzazioni giornalistiche e dalla genericità degli esercizi apologetici che vedono enormi cambiamenti dietro ogni sospiro di papa Bergoglio.
Vorrei precisare, prima di entrare nel merito del tema, che qui le parole «riforma» e «riformatore» sono preferite a quelle, largamente abusate nel discorso pubblico a proposito di papa Bergoglio, di «rivoluzione» e «rivoluzionario». Da questo punto di vista, è piuttosto curioso che uno degli uomini più potenti del pianeta, il capo della più longeva e conservatrice istituzione del mondo, venga definito un «rivoluzionario». L’aggettivo evoca infatti immediatamente i volti di Saint-Just, Danton, Lenin, Trockij, Bakunin, Che Guevara, Mao Zedong, Rosa Luxemburg: insomma, di una schiera di sovversivi che hanno dedicato buona parte della loro esistenza a minacciare l’ordine costituito, a far saltare per aria i regimi della loro epoca, a cercare di proiettare l’umanità in un mondo nuovo, rompendo radicalmente e definitivamente con il passato, con la tradizione, con le abitudini e gli schemi più consolidati.
Non si era mai visto un «rivoluzionario» quasi ottantenne, pacificamente eletto al vertice di una potentissima e ricchissima (di risorse finanziarie, immobiliari ed umane) istituzione millenaria da una pletora di gerarchi anziani come lui al termine di un’onorata carriera trascorsa interamente al fedelissimo servizio della medesima organizzazione. Anche se, in cerca di rivoluzionari da assimilare a papa Francesco, ci allontanassimo dal campo stretto della politica e ci dirigessimo verso quello della spiritualità cristiana, ci imbatteremmo probabilmente nelle fisionomie di Francesco d’Assisi, di Lutero e soprattutto di Gesù, in ogni caso di outsider capaci di compiere, partendo dalle periferie degli imperi, scelte clamorose e destinate a cambiare il corso della storia umana.
Quando giunse a Parigi, eletto all’Assemblea Costituente, Robespierre era un oscuro avvocato di provincia; quando iniziò a diffondere le sue tesi nella cittadina di Wittenberg, Martin Lutero era un monaco agostiniano sconosciuto, un professore di provincia senza incarichi di particolare rilievo. Non mi pare che vi siano mai stati rivoluzionari tra i papi. Forse l’unico che abbia davvero prodotto una clamorosa «azione rivoluzionaria» è stato Celestino V (e, per qualche verso, il suo emulo Benedetto XVI) in ragione del gesto supremo della volontaria rinuncia al potere.
Insomma, per meritarsi fino in fondo l’impegnativa etichetta, Bergoglio dovrebbe mettere in atto almeno un gesto di rottura davvero clamoroso, un’azione distruttiva, appunto «rivoluzionaria», di qualche aspetto del vecchio ordine cattolico. Dal momento che questo non è ancora avvenuto (e non sembra nemmeno tanto probabile che succeda, vista l’età dell’aspirante sovversivo e il tempo – cinque anni – trascorso dalla sua elezione a pontefice), proporrei di concentrarci sull’aggettivo, decisamente più appropriato in questo caso, di «riformatore». Il riformatore, a differenza del rivoluzionario, non intende annientare il vecchio ordine per sostituirlo con uno nuovo, ma desidera piuttosto apportare all’organizzazione che dirige quei cambiamenti indispensabili perché essa possa procedere più spedita ed efficiente, più adeguata ai tempi o depurata di alcuni vizi strutturali. Indubbiamente i riformatori possono, in qualche caso, fare una brutta fine, fallire ed essere spodestati, ma in altri possono invece avere la meglio e riuscire a trasformare in profondità l’organizzazione che guidano. Prendiamo i riformatori comunisti: alcuni di loro, primi fra tutti Dubček e Gorbačëv, hanno perso la loro battaglia storica, sono stati sonoramente sconfitti, dalle armi o dal montare del dissenso popolare; altri, si pensi alla leadership cinese, a Deng Xiaoping e ai suoi successori, invece ce l’hanno fatta e hanno trionfalmente riformato il sistema economico e sociale del loro paese. Tra i papi recenti, il più riformatore, forse l’unico davvero tale, è stato Giovanni XXIII, il quale, a tre mesi dalla sua elezione al soglio di Pietro, decretò l’indizione di un grande concilio ecumenico, che ha prodotto le novità più grandi nella vita della Chiesa di quest’ultimo mezzo secolo.
Papa Francesco è davvero un riformatore? E se sì, cosa intende riformare? E cosa invece vuole mantenere intatto della struttura della Chiesa? Per rispondere a questa domanda, dovremmo prima di tutto chiarire cosa sia una riforma, di seguito stabilire quali siano quelle all’ordine del giorno nella Chiesa cattolica, e infine esaminare quali azioni Bergoglio abbia compiuto per realizzarle o almeno avviarle.
Una riforma è un cambiamento intenzionale della forma strutturale di un’organizzazione. Può riguardare una amplissima quantità di oggetti simbolici, tra i quali: i riti e i rituali organizzativi, le forme gerarchiche, i criteri di selezione e le modalità di impiego del personale, l’articolazione e le competenze interne, la divisione del lavoro tra i diversi compartimenti dell’organizzazione, la formazione dei funzionari, l’ideologia organizzativa.
Le riforme sono in genere promosse e avviate dal vertice, dal top management. Esse rappresentano il più radicale anche se non l’unico strumento impiegato per cambiare l’organizzazione, dal momento che ve ne sono altri quali, ad esempio, l’avvicendamento del personale, soprattutto ai livelli più alti, l’attenzione selettiva per certi progetti o per certe pratiche piuttosto che per altri, una diversa redistribuzione delle risorse.
Il varo di una riforma mette sempre a rischio, anzi generalmente sconvolge, gli equilibri di potere, le routine e le pratiche di un’organizzazione e per questo può essere sostenuto con entusiasmo da taluni, ma anche osteggiato, aggirato nell’ombra, non implementato e boicottato da altri. Per giustificare una riforma vengono quasi sempre invocate argomentazioni razionali legate alla necessità di rilanciare l’organizzazione, di aumentarne l’efficienza, di ridurne i costi o di migliorarne la produttività e tuttavia, soprattutto nelle organizzazioni non di profitto, quelle con una forte dimensione ideale e valoriale, non manca mai, tra gli argomenti dei riformatori, un riferimento agli ideali originali dell’organizzazione che la riforma permetterebbe di realizzare meglio, eliminando le incrostazioni, gli opportunismi, le pigrizie e, in generale, le storture sedimentatesi nel tempo. Per questo motivo, le riforme sono immancabilmente espressione di una speranza: quella che l’organizzazione si depuri dei difetti accumulati nel tempo o quella che sia in grado di sopravvivere in una forma rinnovata e più adatta a nuove circostanze storiche, o ancora quella che le difficoltà attuali possano essere superate con un rinnovamento profondo, organico e strutturale. Le speranze nutrono e sostengono gli sforzi dei riformatori, danno senso al loro presente proiettandolo in un futuro immaginato e idealizzato. La speranza, ma si potrebbe anche chiamarla fede, combina in sé previsione e desiderio e rappresenta il miglior antidoto alla disperazione e all’apatia: la prima si produce quando si crede che le proprie speranze non diventeranno mai realtà; la seconda quando, senza che cessi l’estraneità al presente, si smette persino di desiderare un futuro diverso.
Per quasi cinque secoli, la stessa parola «riforma» ha rappresentato un tabù nella Chiesa, non è mai stata pronunciata ed è stata di fatto identificata con l’eresia protestante e per questo bandita del tutto dal linguaggio cattolico. Nei documenti del Concilio Vaticano I, il termine compare una sola volta e in un’accezione non positiva; anche in quelli del Vaticano II si è preferito impiegare concetti meno impegnativi, quali «aggiornamento» o «rinnovamento».
Ad ogni modo, riformare la Chiesa vuol dire soprattutto modificare e cambiare le sue strutture. Senza un cambiamento strutturale, ogni riforma rischia di limitarsi alla superficie, di riguardare la retorica, di apparire come un mero artificio linguistico. Come ha scritto Myriam Wijlens: «Una comunità che desidera vivere in accordo con la dottrina che possiede trae beneficio da strutture che sostengono, promuovono e proteggono la dottrina secondo cui essa vuole vivere. La riforma e le riforme della Chiesa che non considerino le strutture potrebbero non essere durature e non vedersi corona...