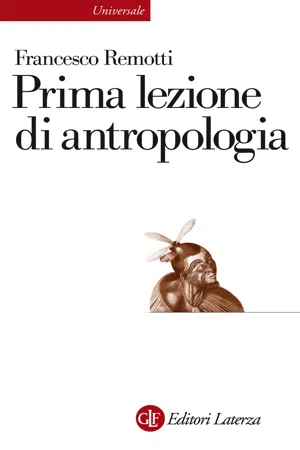
- 182 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Prima lezione di antropologia
Informazioni su questo libro
In modo diretto, concreto e sorprendente, Francesco Remotti conduce il lettore nel complesso e ricco mondo dell'antropologia attraverso i grandi continenti, dall'Africa all'America e all'Oceania, descrivendo usanze, riti e forme di umanità.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Prima lezione di antropologia di Francesco Remotti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Antropologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
AntropologiaIV. La modernità nel mucchio
15. Mode antropo-poietiche: un’introduzione alla modernità
Le mode antropo-poietiche sono molte e svariate. Le donne caduveo dipingono i loro arabeschi sui volti per renderli umani; ma un tempo esisteva tra loro anche la tecnica del tatuaggio (Lévi-Strauss 1960: 178). Non sappiamo per quale motivo i Caduveo abbiano abbandonato il tatuaggio – una tecnica che fissa in modo indelebile i segni – a tutto vantaggio di una tecnica di pittura i cui prodotti sono invece molto effimeri. Tenendo conto di questo e di altri criteri, può essere significativo dare uno sguardo generale alla molteplicità di interventi estetici sul corpo. Prima di cominciare questa carrellata, la quale vuole avere soprattutto un carattere orientativo, è opportuno notare come abbellire, ornare e quindi foggiare il corpo molto spesso ci appaiano attività del tutto superflue e su cui quindi non sarebbe il caso di soffermarsi più che tanto. Ma una spia della loro importanza è data dal fatto che sono attività esplicitamente previste tra i significati del verbo latino colere, da cui proviene il nostro termine “cultura”. Colere non è soltanto “insediarsi” in un certo luogo, “abitare” un territorio, e quindi anche “coltivarlo”; colere è anche “ornare” il corpo, curarlo per renderlo bello, così come significa rivolgere un “culto” a una qualche divinità. Sarebbe avveduto mantenere tra i significati di cui si carica l’uso antropologico di “cultura” la componente che qui abbiamo convenuto chiamare “moda antropo-poietica”, come una delle attività che maggiormente qualifica la cultura umana (oltre a quella abitativa o ecologica e a quella cultuale e religiosa). A conferma di ciò, è pure importante ricordare che la presenza di oggetti ornamentali, insieme ai coloranti quali ocra e manganese, e quindi l’esigenza di interventi estetici sul corpo, sono attestati in epoche assai lontane, come per esempio, per quanto riguarda il Paleolitico europeo, verso la fine del Mousteriano, e quindi verso il 35.000 a.C. (Leroi-Gourhan 1977, I: 222). L’ornamento, per quanto superficiale, effimero e addirittura superfluo possa sembrare, si propone dunque come una componente sostanziale e permanente della cultura.
Sotto questo profilo, si può dire che qui non c’è una divaricazione qualitativa tra sostanza e apparenza, tra ciò che uno è e ciò che uno appare: una differenza di strati che separi una più vera e autentica umanità e una mera sembianza, ciò che davvero conta e ciò che invece sarebbe del tutto superfluo. Le mode hanno a che fare con l’apparenza (l’apparenza del corpo, nel nostro caso); ma le abbiamo definite antropo-poietiche perché il presupposto è che ciò che si fa sull’apparenza decide in buona misura la sostanza. Detto in altri termini, sostanza e apparenza sono assai meno lontane tra loro di quanto normalmente si pensi. E questo succede, perché per un verso la sostanza è già lì nell’apparenza, e per l’altro verso l’apparenza si carica di significati importanti e decisivi, tali da divenire essa stessa sostanza. In una prospettiva antropo-poietica, la sostanza culturale coincide in buona misura con i modi (o le mode) dell’apparenza e viceversa, anche se – beninteso – il fare umanità non si limita affatto alle mode relative al corpo. Del resto, già nella filosofia di Friedrich Nietzsche l’apparenza diviene sostanza:
Che cos’è ora, per me, “apparenza”! In verità, non l’opposto di una qualche sostanza… una maschera inanimata che si potrebbe applicare ad una X sconosciuta e pur anche togliere! Apparenza è per me ciò stesso che realizza e vive… Fin dal principio l’apparenza ha finito quasi sempre per diventar la sostanza, e come sostanza si è resa operante (Nietzsche 1965: 75, 79).
Potremmo aggiungere: “operante” in senso antropo-poietico, nel senso di fare, o di contribuire a fare, umanità.
Nelle mode antropo-poietiche relative al corpo le società umane fanno veramente di tutto: aggiungono, tolgono, tagliano, inseriscono, dilatano, allungano, accorciano; ogni mezzo tecnico e anche ogni materiale è buono per modellare, cambiare, trasformare il corpo. A quanto pare, le società umane si rifiutano di accettare il corpo così com’è; non sopportano di lasciare il corpo nella sua condizione contingente, di abbandonarlo a un semplice sviluppo naturale. Se questo succede, o se si vuole che questo succeda – come, per esempio, tra i cinici dell’antica Grecia, tra i monaci siri del IV-VI secolo d.C. o tra i “rinuncianti” dell’India –, è perché si tratta di una esplicita contestazione della “cultura” dominante a cui si oppone (o ci si illude di opporre) un atteggiamento puramente “naturale”. E comunque, pure in questi casi, è difficile, anzi praticamente impossibile, che non si verifichi un qualche intervento culturale sul corpo. Anche nelle società in cui il corpo è lasciato praticamente nudo, una qualche operazione di aggiunta o di eliminazione viene di solito eseguita.
Proponiamo allora a questo punto una serie di mode antropo-poietiche, ossia di interventi estetici sul corpo compiuti soprattutto per modificare la sua parvenza (Borel 1992). Già da questa tipologia alquanto sommaria ci rendiamo conto dell’impegno che gli esseri umani pongono per trasformare se stessi, agendo ora sull’esterno ora sull’interno del corpo, lasciando segni ora effimeri, ora duraturi e indelebili, con operazioni che si ripetono o che invece vengono eseguite una volta per tutte. Sono quattordici le categorie di mode o di interventi che qui vengono illustrate, con l’avvertenza che un atteggiamento più analitico farebbe aumentare senza difficoltà il loro numero, così come un atteggiamento più sintetico lo ridurrebbe di molto.
Categoria I – Costruire oggetti esterni, farli indossare e poi togliere dal corpo. Abbigliamento (abiti, calzature, copricapi), monili, maschere. Al corpo possono essere fatti indossare abiti, i quali non hanno soltanto una funzione protettiva e adattativa, ma anche comunicativa e simbolica. Tra gli Inuit – per i quali la funzione protettiva dell’abbigliamento è preponderante – le donne provvedono a confezionare con cura gli abiti maschili e femminili, secondo modelli differenziati per l’uomo e per la donna. Tra i Nande, gli abiti tradizionali degli uomini sono di origine vegetale, essendo fatti con la scorza dell’albero mukimba (un albero di foresta), mentre quelli femminili sono di origine animale, essendo confezionati con pelli di capra. Questi abbinamenti sono sì arbitrari o convenzionali, ma niente affatto casuali: nella cultura nande vi sono infatti molti nessi simbolici che collegano gli uomini agli alberi (soprattutto agli alberi della foresta, alti ed eretti, contro cui combattono) e le donne alle capre (contro cui vengono scambiate nella compensazione matrimoniale). Sul corpo, sia esso nudo o vestito, si depongono molto spesso monili od oggetti di vario genere. Gli astucci penici portati dagli uomini della Nuova Guinea e della Melanesia sono di notevoli dimensioni (non si può certo dire che abbiano davvero la funzione di nascondere) e vengono indossati dopo i rituali di iniziazione. Le maschere appartengono anch’esse a questa prima categoria di interventi, che consiste comunque nel “sovrapporre” al corpo un qualche oggetto esterno. Qui l’intervento costruttivo, di tipo artigianale, non viene eseguito sul corpo, ma su oggetti del tutto esterni, i quali però – una volta indossati – ne modificano radicalmente l’aspetto. In altri termini, non si tratta solo di costruire un prodotto artigianale, in quanto le operazioni fondamentali sono anche quelle del mettere e togliere una sorta di «artificio amovibile» (Borel 1992: 49), la cui presenza/assenza muta decisamente la configurazione esterna del corpo, il suo apparire (un corpo in costume da bagno non è lo stesso che in abito da sera).
Categoria II – Togliere dal corpo sporcizia, grasso, odori mediante lavaggi, raschiamenti. Toilette. Gli interventi di questa seconda categoria implicano un contatto diretto con il corpo, con la sua epidermide e con i suoi orifizi al fine di eliminare escreti e secreti. La pulizia del corpo a noi sembra un’attività del tutto “naturale”, rispondente a criteri ed esigenze dettate dalla natura e dal buon funzionamento dell’organismo; ma per convincersi del suo significato “culturale” è sufficiente pensare quanto lungo, e persino penoso, sia il suo apprendimento a cominciare dall’infanzia. L’igiene è parte integrante del nostro tipo di educazione; ma l’igiene – come ha dimostrato Mary Douglas (1975) – non è affatto soltanto una questione di progresso scientifico (acquisizione di nozioni circa l’esistenza di batteri, per esempio): essa è l’espressione di una visione “cosmologica”, in cui ordine del mondo, della società e del corpo si combinano e si richiamano a vicenda. Il verbo greco kosmeo significa “dispongo”, “metto in ordine”, ma anche “orno”, “abbellisco”; corrispondentemente il termine kosmos indica “ordine”, “ordine politico”, “ordine del mondo”, “universo”, “ornamento”, “abbellimento”: la stessa radice è alla base dell’espressione dei concetti di ordine dell’universo, di ordinamento della società e di ornamento del corpo individuale. Decidere come comportarsi nelle faccende dell’igiene personale significa modellare in un certo modo il corpo e, nel contempo, le relazioni sociali in cui è inserito. Sembrano cose di poco conto, ma la “cosmesi” (vedi la categoria successiva) è anch’essa collegata alla “cosmologia”.
Categoria III – Spalmare, dipingere sulla superficie esterna della pelle. Abbronzatura, cosmesi, pitture corporali. Questa terza categoria implica un intervento diretto sulla superficie cutanea, su cui si spalmano sostanze di vario genere o in modo uniforme oppure secondo particolari disegni e modelli. L’abbronzatura, tanto apprezzata nella nostra società, comporta una modificazione nella pigmentazione della pelle a cui concorrono i raggi ultravioletti del sole o di lampade, e creme apposite. Inoltre, la cosmesi – soprattutto femminile – implica un lavoro accurato e sapiente di pittura del corpo e specialmente del volto: «davanti al suo specchio la donna si fa pittrice…» (Borel 1992: 59), così come grandi pittrici – lo abbiamo visto – erano le donne caduveo con i loro disegni geometrici dipinti sul volto. Questo tipo di interventi produce effetti trasformativi di una certa durata, in quanto si lavora sul corpo stesso, non su oggetti esterni che vengono sovrapposti all’occorrenza sul corpo; ma, mentre gli oggetti esterni (categoria I) hanno una loro autonomia che consente una prolungata riutilizzabilità, gli interventi della categoria III (come, del resto, quelli della categoria II) sono decisamente più effimeri ed esigono perciò di essere ripetuti.
Categoria IV – Modellare elementi organici esterni, che crescono dal corpo: peli, capelli, unghie (annessi della pelle). In questa quarta categoria possiamo collocare gli interventi che, pur operando sempre sulla parte esterna del corpo, non si limitano a spalmare sostanze sull’epidermide, ma comportano modifiche temporanee e reversibili di elementi che crescono normalmente sull’organismo: taglio e cura della barba, depilazioni parziali o integrali, temporanee o definitive, acconciature dei capelli, trattamenti delle unghie sono esempi di questo tipo di interventi. Le mode trasformative sono molte, sia a proposito di barba, sia a proposito di capelli, i quali vengono in effetti acconciati nelle fogge più strane. Vi sono società – come certi Indiani dell’America – che provvedono a una depilazione integrale; altri invece – come i Sikh, una setta religiosa dell’India – non tagliano per niente la barba, che poi annodano sotto un turbante; altri ancora – come i mandarini cinesi – si lasciano crescere indefinitamente le unghie, a tal punto da non poter utilizzare le mani (Borel 1992: 54).
Queste prime quattro categorie di interventi sono caratterizzate dalle dimensioni dell’esteriorità e della reversibilità, le quali del resto si implicano a vicenda: quanto più un intervento è esterno, tanto più è reversibile. Agendo nello spazio esterno al corpo (potremmo dire “attorno al corpo”, nel caso della categoria I), oppure sulla sua superficie più esterna (categorie II e III) o ancora sulle parti meno vitali degli annessi della pelle che crescono sul corpo (categoria IV), questi interventi non comportano in genere molta sofferenza. Le categorie che tra poco prenderemo in considerazione (a partire soprattutto dalla categoria VI) sono invece contrassegnate da un’irreversibilità più o meno netta, da una maggiore penetrazione all’interno del corpo e quindi anche da un aumento del dolore. Ma vi è ancora una categoria per così dire intermedia.
Categoria V – Azione dall’esterno tesa a modificare cute, connettivo sottocutaneo e tessuto muscolare. Massaggi, elettrostimolazione, atletica, sport, body building. Si tratta di una categoria di interventi molto praticati nella nostra società, mirati a modellare la struttura muscolare e con essa anche l’epidermide. Le modificazioni possono essere anche vistose (come nel caso del body building) e alquanto durature, ma non raggiungono l’irreversibilità che è caratteristica esclusiva delle categorie che vengono dopo. La continuità e la ripetizione degli esercizi risultano perciò indispensabili.
Soprattutto per le categorie che seguono vale – in maniera forse imprevista e drammatica per chi abitualmente lo usa nei paesi europei – il detto del Meridione italiano «Chi bella vuole apparire, ogni male deve soffrire», che corrisponde del resto al vecchio adagio «Bisogna soffrire per essere belli» (Borel 1992: 34). Perché il dolore a fini estetici? Quale risposta è più plausibile: il dolore come prezzo che purtroppo non si può fare a meno di pagare, allorché la ricerca della bellezza si spinge al di là dei confini delineati da queste prime categorie; oppure si tratta di una ricerca del dolore, insieme all’esigenza della trasformazione estetica? Nelle società in cui è possibile riscontrare gli interventi che prenderemo ora in considerazione (e sono molte), tutto avviene come se le modifiche e gli abbellimenti delle categorie precedenti non fossero sufficienti, come se l’esigenza di trasformare si facesse più imperiosa e richiedesse una penetrazione maggiore e più duratura nel corpo umano.
Categoria VI – Azione dall’esterno tesa a modificare la struttura ossea. Crani schiacciati, piedi ridotti, toraci assottigliati, colli allungati. La sesta categoria del nostro schema è infatti data da interventi che, pur agendo dall’esterno (per lo più mediante compressione), comportano una modifica spesso irreversibile di alcune parti della struttura ossea dell’organismo umano: fasciature e assicelle con cui, in certe zone dell’Africa, dell’America o dell’Oceania, si provvede ad appiattire o allungare il cranio dei bambini; allungamento del collo (che però in realtà è un abbassamento di costole e clavicole [Borel 1992: 95]) mediante progressiva aggiunta di anelli nel Sud-Est asiatico; riduzione dei piedi femminili in Cina; uso dei corsetti per assottigliare la cassa toracica delle donne europee nei secoli della modernità, sono tutti casi molto esemplificativi e ben documentati.
Categoria VII – Interventi interni alla cavità orale e modifica irreversibile di strutture ossee. Limatura, scheggiatura, scultura, avulsione dei denti. In questa categoria possiamo raggruppare gli interventi che provocano modifiche irreversibili di parti anatomiche ossee, mediante utensili e tecniche che penetrano maggiormente all’interno dell’organismo umano, quali possono essere la scheggiatura, la limatura a punta dei denti, o la loro avulsione. Molto diffuse in Africa, oltre che in America (Maya e Aztechi), le tecniche di modellazione dei denti si combinano spesso con l’idea del linguaggio. Secondo i Tiv della Nigeria, «avere i denti scheggiati aiuta a imparare le lingue», oltre che essere un segno di bellezza (Bohannan 1988: 82).
Categoria VIII – Perforazione e inserimento nel corpo di oggetti esterni. Piattelli labiali, perforazione del lobo e del setto nasale, piercing. Un’ottava categoria può essere dedicata agli interventi che, oltre a provocare modifiche irreversibili, spesso mediante perforazione, prevedono l’inserimento di oggetti esterni: piattelli labiali, perforazione del lobo auricolare e perforazione del setto nasale con relativo inserimento di oggetti ornamentali, pratiche di piercing assai diffuse anche nella nostra società. L’inserimento di denti finti e dentiere, o di lenti a contatto a scopo estetico, può essere fatto rientrare in questa categoria, anche se non comporta sempre le modifiche irreversibili evocate prima. I Suya del Brasile centrale (gruppo Gê) sostengono che l’uso di piattelli labiali e di dischi auricolari, così come un particolare stile di canto sono loro caratteristiche distintive, che li rendono «mê, ovvero interamente umani» (Seeger 1975: 213). Come si vede, anche per i Suya occorre perforare labbra e orecchie, inserendovi oggetti particolari, per acquisire una “piena umanità”.
Categoria IX – Penetrazione sottocutanea di sostanze coloranti ed elaborazione di disegni. Tatuaggi. Il tatuaggio merita una categoria a parte, in quanto, se da un lato è una modifica irreversibile ottenuta mediante un intervento penetrante (categorie VI e VII), dall’altro esso riprende il tema delle pitture corporali (categoria III). Infatti, il tatuaggio (la parola inglese tatoo deriva dalla radice tahitiana tatau, “infliggere ferite”) non si limita a modificare certe parti dell’organismo o a inserirvi oggetti particolari: esso è la rappresentazione di disegni o di figure, ottenuta con strumenti a punta che fanno penetrare sotto la pelle una certa quantità di sostanze coloranti. Il tatuaggio è conosciuto ormai universalmente e da diverso tempo è praticato pure nella nostra società, anche se, da un punto di vista etnografico, i casi più interessanti appartengono all’Estremo Oriente (Giappone) e alla Polinesia (nelle isole Marchesi, gli uomini aristocratici avevano tutto il corpo coperto di tatuaggi). Tra i Maori, il tatuaggio era in gran parte riservato agli uomini nobili e liberi, ed era collegato a un lungo processo di acquisizione di un grado più completo di umanità: un uomo senza tatuaggio è nudo, simile a un’asse liscia (Gathercole 1988: 172). Se il primo tatuaggio veniva praticato in occasione della pubertà, dovevano passare parecchi anni prima che il moko (questo è il nome del tatuaggio maori) venisse completato. Simbolo dell’unicità e irripetibilità dell’individuo, il moko era pure segno di una raggiunta completezza: «senza un moko completo» gli uomini maori «non sono persone complete» (Gathercole 1988: 175).
Categoria X – Tagli profondi, inserimento di sostanze, cicatrici che riproducono disegni. Scarificazioni. Se il tatuaggio può essere considerato – quanto ai suoi effetti – come una pittura corporale indelebile, le scarificazioni s...
Indice dei contenuti
- I. Una molteplicità di antropologie
- II. L’incompletezza antropologica
- III. Fare umanità
- IV. La modernità nel mucchio
- Riferimenti bibliografici