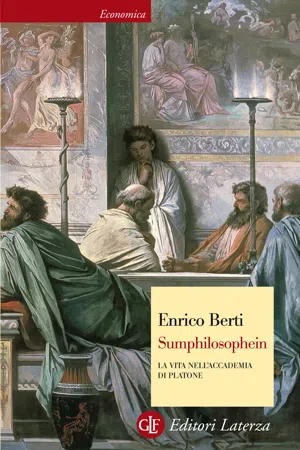IV. Il principio di tutto
1. Le cause prime
Poiché le Idee sono cause delle altre cose, [Platone] pensò che gli elementi (stoikheia) di quelle fossero elementi degli enti. Pertanto [ritenne] che il grande e il piccolo fossero princìpi (arkhai) come materia e l’Uno come sostanza; da quelli infatti per partecipazione dell’Uno [ritenne] che fossero le Idee, cioè i numeri1.
Con queste parole, a prima vista sorprendenti, Aristotele, dopo avere esposto la dottrina delle Idee di Platone, gli attribuisce l’affermazione che le Idee stesse abbiano degli elementi, ovvero dei princìpi – in questo passo i due termini sono equivalenti –, che questi princìpi siano due, cioè l’Uno e il “grande-piccolo” – i quali corrisponderebbero a due tipi di cause distinti dallo stesso Aristotele, la materia e la forma (“sostanza” qui equivale ad essenza, cioè a forma) –, e che le Idee siano, cioè sussistano, per partecipazione del grande-piccolo all’Uno. Di seguito all’espressione “le Idee”, nell’ultima riga citata, i manoscritti portano direttamente l’espressione “i numeri”, che alcuni editori espungono come annotazione fatta a margine, mentre altri la conservano come apposizione di “le Idee”, e altri ancora la sostituiscono a “le Idee”. In ogni caso le Idee di cui qui si tratta sono quelle che Platone identificava, o riconduceva, ai numeri ideali, perché i due princìpi-elementi in questione, cioè l’Uno e il grande-piccolo, sono, come vedremo, i princìpi dei numeri.
La sorpresa, almeno iniziale, prodotta da queste parole è dovuta all’attribuzione a Platone di una dottrina dei princìpi, di cui nei dialoghi platonici non sembra esservi traccia, almeno nella forma precisa in cui essa è riportata qui. Ma tale sorpresa può essere dissipata, o ridotta, se si tiene presente che l’intero libro A della Metafisica, in cui le parole sono riportate, non è altro che un confronto che Aristotele fa tra la propria dottrina delle cause prime, cioè dei princìpi – per Aristotele le due espressioni sono equivalenti – e le dottrine dei princìpi formulate dai suoi predecessori, confronto diretto a cercare una conferma della stessa dottrina aristotelica. Questa risponde all’esigenza di realizzare una forma di “sapienza” (sophia), cioè di una scienza la quale sia “prima” rispetto a tutte le altre, e che perciò Aristotele chiamerà “filosofia prima”, il cui carattere filosofico deriva non dal fatto di chiamarsi “filosofia”, termine che per Aristotele era sinonimo di “scienza”, cioè di sapere in generale, ma dal fatto di essere “prima”. Quest’ultimo carattere, secondo Aristotele, dipende dall’oggetto di essa, cioè appunto le cause prime, o princìpi. Ogni scienza, infatti, è per Aristotele ricerca di cause, cioè di spiegazioni, perciò la scienza prima sarà quella che ricerca le cause prime, cioè le cause che non dipendono da altre, le spiegazioni che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni2.
Questo tipo di scienza, secondo Aristotele, era stato inaugurato da Talete, da lui chiamato infatti “iniziatore di questo tipo di filosofia” (tês toiautês arkhegos philosophias)3, e perciò considerato in seguito iniziatore della filosofia in generale, mentre Aristotele voleva dire solo che Talete era l’iniziatore di quel particolare tipo di scienza che è la filosofia prima, cioè la ricerca dei princìpi, perché egli era stato il primo che aveva indicato un principio, l’acqua. Tutta la rassegna che costituisce il libro A della Metafisica è un confronto tra la dottrina aristotelica dei princìpi, che li distribuisce in quattro tipi di cause – materiale, formale, efficiente e finale –, e le dottrine dei princìpi formulate da quanti se ne erano occupati in precedenza, l’ultimo dei quali era – secondo Aristotele – lo stesso Platone. Non c’è da stupirsi quindi se egli attribuisce una dottrina dei princìpi anche a Platone, perché proprio questo è lo scopo dell’intero libro A, cioè di vedere quali sono le dottrine dei princìpi formulate in precedenza. Certo, di Platone viene introdotta anzitutto la dottrina delle Idee, ma solo perché queste erano, per Platone, le cause delle cose. Le Idee tuttavia non erano, o ad Aristotele non sembrava che fossero, le cause prime poste da Platone, perché le Idee a loro volta dipendevano da altre cause, questa volta prime, cioè princìpi, precisamente dall’Uno e dal grande-piccolo.
Il primo problema, cioè perché Aristotele attribuisce a Platone una dottrina dei princìpi, può dunque considerarsi risolto. Naturalmente ce n’è un secondo, cioè dove Platone avrebbe parlato di tali princìpi, dato che nei dialoghi da lui scritti sembra non parlarne. Ma prima di affrontarlo vediamo l’esposizione completa che Aristotele fa di tale dottrina. Egli la pone subito a confronto con la dottrina dei Pitagorici, osservando che nel considerare l’Uno come principio, e quindi come sostanza, e non come predicato di altro – quale invece lo considererà, come vedremo, Aristotele stesso –, Platone parlava in modo simile ai Pitagorici, come pure somigliava a loro nel considerare i numeri “causa della sostanza” (cioè, in linguaggio aristotelico, causa formale) delle altre cose, mentre nel porre al posto dell’illimitato (apeiron) una diade, vale a dire nel considerare l’illimitato come composto del grande e del piccolo, Platone si mostrava del tutto originale. Ora, se prendiamo in esame la dottrina che lo stesso Aristotele nel precedente capitolo dello stesso libro attribuiva ai Pitagorici, vediamo che egli li considerava in qualche modo scopritori della causa formale, perché avevano affidato ai numeri questa funzione, e che attribuiva loro come princìpi dei numeri, e quindi di tutte le cose, il limite (peras) e l’illimitato (apeiron), dove però il limite poteva essere anche identificato con l’Uno. Dunque l’Uno e l’illimitato erano, secondo i Pitagorici, i princìpi dei numeri. Platone, ponendo a sua volta come princìpi delle Idee, ma delle Idee identificate o ricondotte ai numeri ideali, l’Uno e il grande-piccolo, aveva preso dai Pitagorici la convinzione che un principio dei numeri fosse l’Uno, inteso come causa formale, e aveva modificato l’altro principio ammesso dai Pitagorici, cioè l’illimitato, concependolo come una diade, formata appunto dal grande e dal piccolo.
La ragione per cui Platone avrebbe messo una diade, cioè il grande-piccolo, al posto dell’illimitato è spiegata poco dopo da Aristotele: Platone lo avrebbe fatto, distinguendosi in questo dai Pitagorici, per poter “generare”, cioè far derivare, da essa in modo naturale “come da una sorta di matrice” (ekmageion) i numeri, “eccettuati i primi” (exô tôn prôtôn)4. Si tratta, ovviamente, di una dottrina difficile da capire, e ancor più da spiegare, ma proviamoci, prescindendo per il momento dal problema se essa sia o no dottrina autentica di Platone. Anzitutto si noti come il problema affrontato da Platone sia quello di come “generare”, cioè far derivare, i numeri dai princìpi. Per Platone dunque i numeri non si formano per addizione di un’unità all’unità successiva, come nella matematica intuitiva (e come penserà poi lo stesso Aristotele), ma per generazione da una sorta di matrice, e questa matrice, per poter generare i numeri in modo “naturale”, deve essere una diade. Tutto ciò suggerisce che i numeri si formino non per addizione, ma per divisione, perché una matrice di tipo diadico fa pensare a qualcosa che divide. Questa impressione è confermata dal fatto che fanno eccezione a questo tipo di generazione i numeri “primi”, cioè quelli che si dividono solo per uno e per se stessi, cioè praticamente non si dividono, nonché dal fatto che altrove Aristotele chiama la diade “duplicatrice” (duopoios)5.
Perché Platone avrebbe concepito questa diade come formata dal grande e dal piccolo? Perché ogni numero è un rapporto tra due grandezze, le quali devono essere disuguali l’una rispetto all’altra, cioè devono essere appunto una grande e una piccola. Quando le due grandezze sono uguali, il loro rapporto è uguale a 1, che per i Greci non era un numero, ma il principio dei numeri. Quando invece esse sono disuguali, cioè una è il doppio, o il triplo, o il quadruplo, dell’altra, “si generano” appunto i numeri, cioè il 2, il 3, il 4, e così via. Affinché tuttavia si generino dei numeri determinati, cioè interi (i Greci non conoscevano le frazioni), è necessario che il rapporto tra il grande e il piccolo sia determinato, cioè sia appunto il doppio, o il triplo, o il quadruplo. Questa determinazione nasce, secondo la dottrina in questione, dalla partecipazione del grande-piccolo all’Uno, cioè l’Uno esercita, per così dire, un’azione determinante, fa sì che il rapporto indeterminato tra un “grande” qualsiasi e un “piccolo” qualsiasi divenga un rapporto determinato come, ad esempio, doppio, triplo o quadruplo. Per questo la diade del grande-piccolo, prima di generare i numeri è un rapporto indeterminato, cioè – come Aristotele dice altrove – una “Diade indefinita” (aoristos duas), e quando viene determinata dall’Uno, genera un numero. Quindi la Diade indefinita, nell’ottica aristotelica, è un principio materiale, perché indeterminato, mentre l’Uno è un principio formale, perché determina. Poiché essi sono i princìpi di tutto, li scriviamo con l’iniziale maiuscola, al fine di distinguerli da qualsiasi altra unità o qualsiasi altra dualità.
Aristotele completa finalmente l’esposizione della dottrina platonica dei princìpi paragonando l’Uno e la Diade indefinita prima rispettivamente all’artigiano e al legno, come cause di un tavolo, dove il primo fornisce la forma e il secondo fornisce la materia, e poi al maschio e alla femmina, i quali secondo Aristotele nella generazione degli animali forniscono appunto rispettivamente la forma e la materia. Infine dice che Platone attribuiva a questi due princìpi la funzione di cause rispettivamente del bene e del male, come già avevano cercato di fare alcuni filosofi precedenti, cioè Empedocle e Anassagora6. Non è difficile riconoscere in queste coppie, maschio-femmina, bene-male, le opposizioni originarie sostenute in Grecia dai Pitagorici, ma rintracciabili in molte culture primitive, ad esempio nel dualismo iranico tra Ormuzd, dio del bene, e Arimane, dio del male, e in quello egiziano tra Osiride e Iside, ovvero il Sole e la Luna. La peculiarità della dottrina platonica è che questi erano i princìpi dei numeri ideali, quindi delle Idee, quindi di tutte le cose, rispettivamente come principio formale e principio materiale.
Veniamo allora al problema principale, sul quale si sono impegnate generazioni di commentatori e di studiosi: questa dottrina dei princìpi è di Platone? E, se è di Platone, dove si trova? Nei dialoghi, o altrove, per esempio nelle “cosiddette dottrine non scritte” (en tois legomen...