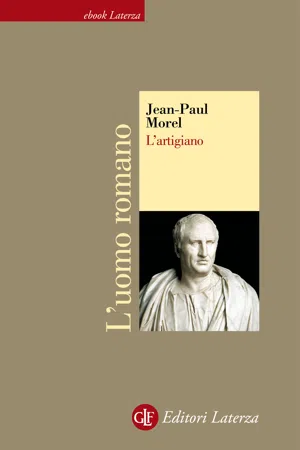L’artigiano
Si può essere artigiani e al tempo stesso veri e propri Romani? Viene spontaneo porsi una simile domanda, considerando il disprezzo ostentato dall’«intellighenzia» romana per tutto ciò che abbia a che fare con l’attività artigianale e con ogni forma di lavoro salariato. Secondo Cicerone, «la bottega artigianale non si concilia affatto con la condizione di uomo libero» (nec quicquam ingenuum habere potest officina) e «tutti gli artigiani praticano un basso mestiere» (opifices omnes in sordida arte versantur). Per Seneca, i compiti dell’artigiano sono «vili» e «volgari»: «non hanno niente a che fare con le vere qualità dell’uomo» (ad virtutem non pertinent).
Non vi è alcuna incertezza in questi giudizi: ogni attività artigianale o manifatturiera è interdetta all’uomo dabbene: l’artigiano è relegato nella condizione di sotto-uomo o, nella migliore delle ipotesi, di cittadino di seconda categoria. Lo stesso può dirsi dell’artista o del tecnico e, più in generale, di chiunque lavori per un salario. In queste valutazioni riconosciamo un’intera corrente di pensiero che, attraverso paesi e secoli, ha confinato nei sotterranei della storia quelli che con il loro lavoro facevano funzionare la baracca.
Allo stesso tempo, però, ogni osservatore del mondo romano – purché lucido e in buona fede – non può che rimanere impressionato dall’enorme quantità di manufatti che venivano prodotti, scambiati, consumati; l’archeologia ne mette instancabilmente in luce i reperti non deperibili, la punta dell’iceberg. Il nostro osservatore può ritrovare qua e là rappresentazioni figurate o iscrizioni che illuminano in modo frammentario ma rivelatore un intero universo di specialisti e bottegai; egli si accorge che lo stato centrale, o il potere municipale, sorvegliano i prezzi e sottopongono ad una legislazione specifica alcune produzioni, oppure che le legioni e certi santuari possiedono le loro proprie botteghe artigianali; questo stesso osservatore può constatare il moltiplicarsi dei beni e dei servizi nelle innumerevoli città di un Impero che fu quasi universale, e la loro fitta circolazione nelle arterie di questo corpo gigantesco. In breve, l’archeologo, lo storico, o il semplice curioso, devono riconoscere che l’artigiano, con i suoi prodotti e le sue prestazioni, occupa nel mondo romano un posto che non avrebbero potuto sospettare se si fossero limitati a leggere gli autori antichi, a sfogliare il Corpus delle iscrizioni latine, o a percorrere la maggior parte dei musei. Interrogarsi sul modo in cui possiamo avvicinarci a questa figura, sugli ostacoli di ogni genere che ne nascondono la personalità e l’attività, significa già, in parte, riuscire a formarsi un’idea almeno parziale del suo status, della sua posizione nella società, dei sentimenti che prova e che ispira.
Se è relativamente facile conoscere e studiare i prodotti artigianali del mondo romano, è invece molto difficile farsi un’idea sufficientemente precisa della persona e del comportamento dell’artigiano, tanto essi vengono abitualmente dissimulati dal formidabile camuffamento dell’honestas, che fissa ciò che può essere evocato senza imbarazzo come ciò che si può confessare senza abbassarsi. Solo l’esistenza di una lex Metilia de fullonibus (220 a.C.), che regolava l’attività dei follatori, induce Plinio – come lui stesso afferma – a non provare «alcuna contrarietà» nel nominare questo collegio di lavoratori. L’artigianato romano compare nelle nostre fonti soltanto quando la legge o il diritto se ne interessano; oppure quando produce qualche innovazione tecnica che risveglia la curiosità dei naturalisti o degli enciclopedisti; o, infine, l’interesse per l’artigiano si accende quando un individuo deve la sua notorietà infamante a una fortuna mal acquisita perché raggiunta grazie all’esercizio di un mestiere, oppure quando un personaggio altolocato trova nella compagnia degli artigiani un piacere inevitabilmente perverso. Remmio Palemone, un liberto che nell’età di Tiberio e Claudio accumulò enormi guadagni grazie ai suoi ateliers d’abbigliamento, non poteva che meritare gli sferzanti rimproveri di Svetonio: si trattava di un essere perduto nel vizio, infamis omnibus vitiis, di insopportabili arrogantia e luxuria: addirittura, secondo Varrone, un «porco». Non fu a proposito delle esazioni di Verre in Sicilia che Cicerone pronunciò il famoso detto o tempora o mores, ma alla fine di un passo dove egli descrive il propretore che sorveglia i suoi laboratori di oreficeria, vestito, come un volgare artigiano, «di una tunica scura e di un mantello greco»: occupazione e abbigliamento ugualmente indegni di un romano.
Le nostre informazioni sugli artigiani romani sono contenute essenzialmente in tre generi di documenti: i testi nei quali essi costituiscono l’argomento principale, le iscrizioni che hanno lasciato, i prodotti che hanno fabbricato. A seconda del tipo di documento che utilizzeremo, l’artigiano ci apparirà come un essere meschino e sfacciato; oppure egli definirà se stesso un maestro nella sua arte e un notabile nella sua città; o, ancora, avremo di lui un’immagine più oggettiva, ma terribilmente sbiadita. Pur contraddittori, questi tre approcci sono però nello stesso tempo inseparabili: essi contribuiscono infatti a definire la situazione ambigua dell’artigiano nella società romana.
Anche definire l’artigiano romano risulta particolarmente arduo. Il problema ha origine dal fatto che il termine ars si applica, come i suoi derivati, indistintamente alle conoscenze più perfezionate come alle pratiche più elementari, comprendendo così al suo interno ciò che oggi distinguiamo sotto i nomi di «artigianato», «tecnica» o «arte». Infatti, per i Romani la principale linea di demarcazione non è situata tra attività intellettuali e attività manuali, ma tra occupazioni rivolte esclusivamente al piacere dello spirito e quelle rivolte a fini pratici (animi libera oblectatio/utilitas), e dunque tra arti «liberali», ossia degne d’un uomo libero, come la matematica, la retorica o la filosofia, e tutte le altre: dai mestieri manuali alla medicina, all’architettura. Più di un Romano avrebbe potuto fare sue le opinioni di Platone e Aristotele, secondo i quali gli artigiani erano personaggi volgari e ignobili, indegni di essere considerati come cittadini. Persino i più competenti fra i tecnici non sfuggono a questa condanna, visto che involgariscono le arti liberali applicandole alla pratica.
Ecco dunque il vasto ambito nel quale dovrà muoversi la nostra ricerca: tanto grande è l’estensione della confraternita di coloro che dobbiamo considerare «artigiani», che siano miserabili o enormemente ricchi. Se si considera inoltre che l’indagine dovrà prendere in esame più d’un millennio di storia e un’area geografica che, all’apogeo dell’Impero, si estendeva su milioni di kmq, si potrà immaginare come l’eterogeneità delle condizioni, dei modi di vita e dei comportamenti frazioni all’infinito l’artigiano romano che noi qui ricerchiamo, e vanifichi sin da principio ogni possibile tentativo di indicare un «idealtipo» che non coincida con quello desumibile dai giudizi semplicistici degli autori antichi.
Tentiamo di penetrare più a fondo nella complessità delle condizioni. I concetti e i vocaboli moderni intorno ai quali si svolgono tante polemiche sull’artigianato antico – quelli di artigiano e operaio, di manifattura e industria, di borghesia e proletariato – non sono necessariamente meno efficaci, in questo campo, di un vocabolario latino spesso ambiguo.
Un termine come vestiarius può designare, secondo i casi, un artigiano dell’abbigliamento o un mercante di vestiti, come anche un servo incaricato della sorveglianza del vestiario o di badare al guardaroba in una casa padronale. E così di seguito, all’infinito. La distinzione tra l’artigiano e il domestico è del resto abbastanza artificiosa in una società dove un buon numero di prodotti artigianali è confezionato nelle domus e nelle villae. Analogamente, l’artigiano si può confondere spesso con il mercante, nell’universo di bottegai dove si svolge una parte importante della vita artigianale dell’antichità: avviene di frequente che il ciabattino o il calderaio che lavorano rintanati nelle loro botteghe possano anche vendere ciò che hanno fabbricato con le proprie mani; di qui la relativa indipendenza, se non altro, di questa categoria di artigiani, che vive in contatto permanente con la vita della città e con l’animazione delle strade.
Molti lavoratori non hanno però questa possibilità o questa fortuna. Sorge quindi un’ulteriore incertezza, davanti alla quale il nostro vocabolario si dimostra spesso impreciso, o addirittura ingannevole. Sappiamo che gli «artigiani» romani non godevano sempre di quell’«autonomia» e di quell’«iniziativa», almeno relativa, c...