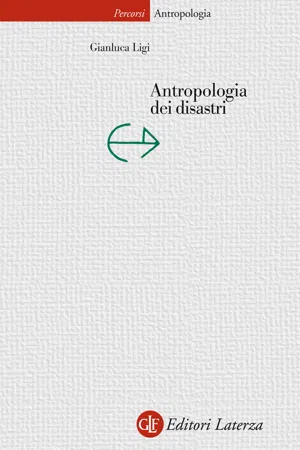1. Concetti di disastro
Da un certo punto di vista, un disastro diventa un disastro
solo quando vengono coinvolti uomini o ambienti creati dagli uomini.
Una valanga in una valle disabitata o un terremoto in Artide sono
eventi geofisici, non sono disastri.
Karl A. Western, The Epidemiology of Natural and Man-made Disasters
1. Problemi di ricerca e definizioni
Un buon punto di partenza per comprendere il senso di una disciplina scientifica è individuarne i problemi di ricerca, ovvero le domande a cui tenta di rispondere, e chiedersi perché le rintenga importanti e quali metodi utilizzi per trovarvi risposta. Ogni ricercatore dovrebbe sempre identificare con chiarezza i propri problemi di ricerca e ogni ricerca nel suo progettarsi e ridefinirsi continuo è un lavoro incessante attorno a questi problemi. Si può estendere all’antropologia quanto Francesco Ferrarotti ha scritto per la sociologia: entrambe – anche se con modalità talvolta profondamente diverse – si occupano «di fatti sociali espressi in termini scientificamente rilevanti, ovvero di fatti che si pongono come problemi» (1999, p. 7). In questo primo capitolo tracceremo dunque una mappa dei principali problemi teorici e di ricerca che caratterizzano l’antropologia dei disastri. Da principio, analizzando alcuni casi concreti, formuleremo questi problemi in modo molto generale, per poi passare, nei capitoli successivi, a definirli e circoscriverli sempre più in dettaglio, delineando al tempo stesso un quadro degli approcci elaborati per risolverli.
È necessario innanzitutto un chiarimento terminologico. Nelle scienze etno-antropologiche vi è l’abitudine assai diffusa di definire dei settori disciplinari utilizzando etichette per così dire «al genitivo»: antropologia del corpo, antropologia dell’arte, antropologia del rito, della città, dello sviluppo, dell’educazione, e così via. Queste denominazioni non si riferiscono però al tentativo di fare antropologia di qualcosa, ma – più correttamente – all’intento di analizzare qualcosa in prospettiva antropologica: cioè di porre l’attenzione sulle modalità particolari, storicamente determinate, con cui gruppi etnici e sociali differenti, talvolta in conflitto fra loro, in differenti angoli di mondo, hanno culturalmente costruito e plasmato i loro concetti di corpo, di arte, di rito, di città, di sviluppo, di educazione ecc. L’antropologia come scienza sociale si fonda per l’appunto sul principio epistemologico di base che per studiare e comprendere una data particolarità culturale sia indispensabile ricorrere allo studio di altre particolarità culturali ponendole in connessione fra loro (Remotti 1990). La denominazione antropologia dei disastri indica quindi quel filone recente ma già piuttosto consistente di ricerche in cui si applicano le teorie e i metodi tipici dell’antropologia socio-culturale allo studio dei disastri, nel senso di eventi naturali estremi (terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tornado) e in quello di catastrofi tecnologiche (esplosioni di impianti nucleari, contaminazioni batteriologiche e virali, gravi forme di inquinamento ambientale)1. Ma che significa esattamente? Da alcuni anni molte altre discipline, sia nell’ambito medico e delle scienze naturali (biostatistica, biochimica, epidemiologia, geofisica, ingegneria antisismica ecc.) sia in quello delle scienze sociali (sociologia delle organizzazioni, psicologia delle emergenze di massa ecc.), stanno sviluppando approcci specifici per affrontare il problema delle catastrofi. In che modo allora il sapere e le metodologie tipiche delle scienze etno-antropologiche possono apportare un contributo ulteriore, originale, e forse addirittura più efficace? Cosa ha a che fare una scienza tradizionalmente dedita allo studio di bizzarri costumi nativi, dolorosi rituali di iniziazione, fantasiose e incredibili mitologie, con i terremoti, le radiazioni nucleari, le nubi tossiche e i tornado? Questi interrogativi pongono chiaramente un problema generale e molto complesso che, come vedremo, è al cuore stesso dell’antropologia dei disastri: la questione cioè di cosa si debba intendere esattamente con la parola disastro e a quali tipi di eventi o circostanze fisiche, ecologiche e sociali la si debba più correttamente applicare.
In genere non si ritiene che l’antropologia possa occuparsi di disastri perché si tende a sottovalutare l’importanza degli aspetti socio-culturali di un disastro rispetto a quelli più marcatamente tecnici e fisici. Lo scopo di questo libro è invece mostrare come, al contrario, proprio gli aspetti socio-culturali siano le dimensioni preminenti di un evento naturale estremo, o di un disastro tecnologico, in ogni sua fase (prima, durante e dopo l’impatto). Si potranno fare passi avanti verso la comprensione e la prevenzione dei disastri, e la mitigazione dei danni post-impatto, non soltanto migliorando l’analisi e la modellistica di tipo tecnico-fisico e ingegneristico, ma soprattutto concettualizzando in modo più sofisticato l’importanza delle componenti sociali di un disastro e la loro variabilità trans-culturale. Un disastro non è qualcosa che semplicemente accade, ma è una situazione estremamente critica che si produce quando un agente potenzialmente distruttivo – di origine naturale o tecnologica – impatta su una popolazione che viene colta in condizioni di vulnerabilità fisicamente e socialmente prodotta. La circostanza disastrosa si presenta quando le sfere ambientale, sociale e tecnologica interagiscono fra loro in una specifica modalità, innescando un processo di connessione causale fra eventi che si verificano a catena. Se non viene scoperto e bloccato in tempo, questo processo raggiunge rapidamente, o talvolta anche nell’arco di mesi o anni, un punto culminante che dà luogo alla catastrofe. Come vedremo, le particolari condizioni di vulnerabilità di una società sono l’elemento chiave per comprendere un disastro e dipendono direttamente dalle concezioni del rischio prevalenti in quella società rispetto a determinati eventi pericolosi. Sono queste concezioni e valutazioni che orientano più o meno efficacemente le scelte politiche, economiche e sociali su cui poi si basano le opere concrete di intervento per prevenire i disastri.
Purtroppo però la questione non è così semplice: perché il rischio come realtà oggettiva non esiste. Il rischio non è una caratteristica fisica della realtà, un oggetto naturale, un dato di fatto misurabile in senso assoluto, ma è una categoria cognitiva, un costrutto della nostra comprensione mediante il quale rappresentiamo correlazioni fra eventi concreti così da poterli governare con tecniche particolari e per particolari obiettivi. In altri termini il rischio è una categoria del pensiero che rende rappresentabile e manipolabile in termini statistici, sociologici, epidemiologici una data serie di eventi e fenomeni concreti2. La natura non oggettiva del rischio è un concetto decisamente complesso e profondo al quale dedicheremo ampio spazio nei capitoli successivi; da esso ricaveremo l’idea che l’antropologia dei disastri si configura essenzialmente come una antropologia delle concezioni locali di rischio3. L’antropologa Deborah Lupton scrive:
i fenomeni che selezioniamo e identifichiamo come «rischi» hanno uno statuto ontologico importante nella interpretazione di noi stessi e dei nostri mondi sociali e materiali. Le società – e all’interno di esse le istituzioni, i gruppi e gli individui – hanno bisogno di questo processo di selezione in quanto elemento del loro continuo funzionare. La selezione dei rischi e le attività associate alla loro gestione sono centrali per il loro ordine, la loro capacità di funzionare e l’identità sia degli individui sia delle culture.
Secondo la stessa antropologa i principali problemi di ricerca sono:
valutare secondo quali modalità il concetto di rischio operi nelle società occidentali giunte alla fine del ventesimo secolo, ed esaminarne le implicazioni rispetto ai modi in cui interpretiamo noi stessi, gli altri, le organizzazioni, le istituzioni, i governi e il mondo non umano (Lupton 2003, p. 20).
L’antropologia, fin dai suoi esordi, ha fatto largo uso della metafora architettonica, paragonando le società a edifici e focalizzando l’attenzione sulla nozione di «struttura» e di «equilibrio». Attualmente l’analisi dei processi mediante i quali gli esseri umani «costruiscono» le loro culture svolge un ruolo centrale nella ricerca. Si può dire che la metafora architettonica sia scivolata dai prodotti, le società come edifici e strutture, ai processi, le società come cantieri, nei quali si esercita l’opera costruttiva o poietica degli esseri umani, che incessantemente e quotidianamente costruiscono significati, istituzioni sociali, visioni del mondo, modelli di comportamento, concezioni di genere, relazioni di potere, e così via4. Che ne è di questa intensa opera di costruzione culturale di fronte a un disastro? In un disastro, con il crollo improvviso e devastante del contesto quotidiano, sembra andare in frantumi l’ordine stesso con cui una cultura dà senso al mondo e ai rapporti sociali. I disastri non sono forse il segno più evidente dell’irreparabile sconfitta di questo atteggiamento poietico? Non sono forse la prova più schiacciante dell’intrinseca precarietà delle società umane e della fragilità dei loro costrutti culturali? Come viene culturalmente concettualizzata l’idea stessa della distruzione, dell’eventualità di una rottura repentina e irreversibile di ogni equilibrio, dello sgretolarsi di ogni struttura?
Per affrontare questioni di tale portata è indispensabile partire dalla definizione di disastro. Il fatto che questo problema non sia stato ancora del tutto risolto la dice lunga sulla complessità del tema. I disastri possono essere più facilmente riconosciuti che definiti. Un conto è sentire il disastro, saperlo riconoscere quando vi si è coinvolti, ben altro conto è invece darne una definizione scientifica esauriente, efficace e non ambigua. La parola disastro esibisce pertanto le caratteristiche di una tipica «sponge word» (Quarantelli 1978), una parola spugnosa o, per meglio dire, porosa: assorbe molto, cogliendo un’esperienza della realtà estremamente complessa e drammatica, ma quando si tenta di spremerla e strizzarla per concettualizzarne in termini generali il significato restituisce assai poco. Cionondimeno, costruire una o più nozioni scientificamente adeguate di disastro è un’operazione analitica indispensabile, in particolare per chi si occupa di antropologia.
Se le scienze naturali utilizzano in buona parte strumenti di ricerca piuttosto concreti – come ad esempio i microscopi a scansione (biologia), o gli acceleratori di particelle (fisica) –, l’antropologia, in quanto scienza sociale, è provvista di strumenti che sono essenzialmente di tipo concettuale, e cioè esprimibili mediante parole. Occorre dunque prestare la massima attenzione a come si definiscono i termini da utilizzare in una ricerca antropologica. L’antropologo lavora con le parole: egli è impegnato in un costante tentativo di costruzione di senso – un «trying to make sense» (Winch 1987) – e si sforza (e secondo alcuni si illude) di connettere fra loro mondi sociali radicalmente differenti interpretando e traducendo concetti nativi, che sono a loro volta interpretazioni della realtà. La traduzione antropologica è inoltre un’operazione intersoggettiva in cui i significati che si traducono (interpretano-comprendono) vengono generati nell’incontro etnografico fra l’antropologo e i propri informatori. Come ha scritto Clifford Geertz (1988), il pensiero umano è essenzialmente un fatto sociale, per cui il pensare non consiste in «avvenimenti nella testa» (sebbene l’attività cerebrale sia indispensabile perché il pensare abbia luogo), ma in un traffico di simboli significativi, e il suo habitat naturale è il cortile di casa, il mercato e la piazza principale della città. Conseguentemente la comprensione antropologica è un’impresa pratica: un tentativo di to make sense, cioè di fare senso, fabbricarlo, costruirlo immergendosi nelle medesime pratiche quotidiane in cui sono impegnate le persone del gruppo sociale che stiamo studiando.
In questo capitolo vedremo quindi come il termine disastro assuma significati differenti in differenti tradizioni di studio; esamineremo quale fra queste definizioni sia la più opportuna per l’indagine antropologica e che importanza abbia l’interpretazione di eventuali nozioni native di disastro in rapporto alle nostre. Definizioni diverse dovrebbero essere elaborate in modo tale da potersi integrare fra loro, e avere così la capacità di porre in luce aspetti diversi (di tipo sociologico, geologico o psicologico) di un fenomeno che per sua natura è poliedrico e multifattoriale, e non si lascia comprimere e incasellare facilmente in un rigido schema analitico. Come si è detto, la questione è piuttosto rilevante, giacché da essa dipendono, sul piano teorico, la validità di un modello interpretativo degli eventi estremi e, sul piano pratico, la conseguente capacità di intervento efficace nella previsione delle catastrofi e nelle emergenze di massa. Dice bene il geologo Mario Tozzi (2005, p. 10):
In Oriente, per esempio, si è ormai pienamente compreso che fenomeni come le eruzioni o i terremoti rientrano in un ordine naturale di eventi esattamente come la pioggia o il vento (Kashima è da tempo immemore l’unico dio giapponese che riesce a tenere sotto controllo Namazu, il pesce-gatto che dimenandosi nel sottosuolo fa vibrare la superficie terrestre). In generale ci ostiniamo a chiamare catastrofi naturali disastri in realtà provocati esclusivamente dalle azioni o dalla semplice presenza dell’uomo. [...] Le calamità naturali non esistono, esistono solo il naturale divenire di un pianeta attivo e dinamico e la nostra incapacità di tenerne conto.
Questa considerazione critica sulla innaturalità di molti disastri naturali (e vedremo anche sulla non casualità – o non fatalità – di molti disastri tecnologici) riprende ed estende il concetto di Western – per il quale un disastro diventa tale solo quando vengono coinvolti esseri umani o ambienti creati dagli esseri umani – e costituisce il punto di partenza dell’antropologia dei disastri. Ma non basta riconoscere che un disastro presenta degli aspetti socio-culturali, né è sufficiente ritenere che un qualsiasi evento critico si debba classificare come disastro se e solo se coinvolge una comunità umana. Il punto è stabilire esattamente come le componenti socio-culturali dell’evento disastroso debbano essere concettualizzate nei nostri modelli interpretativi.
I pericoli più pericolosi sono quelli che non riconosciamo come pericoli, i rischi gravi che non sappiamo di correre. Questo genere di pericoli si può annidare in uno schema interpretativo errato o incompleto; in un modello teorico le cui variabili risultano insufficienti o non efficacemente correlate; in errori di valutazione nell’attribuire importanza a certi aspetti piuttosto che ad altri, nell’indirizzare le ricerche in una direzione piuttosto che in un’altra. Alla base delle difficoltà scientifiche di comprendere tutte le cause di un evento naturale estremo o di una catastrofe tecnologica ...