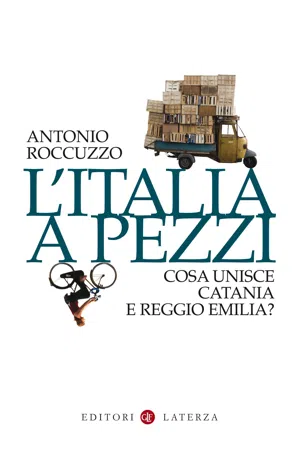La mafia nel Nord. I clan dove meno te li aspetti
«Questi si stanno mangiando, piano piano, anche l’economia delle parti sane del nostro paese», afferma Giovanni Melillo, magistrato della Procura nazionale antimafia.
Parla con la fermezza di chi dice una cosa scontata perché frutto di anni di indagini, ma non ancora scritta nella coscienza civile dell’intero paese. Sul computer di Melillo, in un ufficio giudiziario nel centro di Roma, scorrono ogni giorno e da anni i dati di tutta l’attività investigativa antimafia sui clan campani, siciliani e calabresi. Su altri computer simili, collegati in uffici delle procure di Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Torino, Milano e Bologna, scorrono gli stessi dati provenienti da altri uffici giudiziari minori, anche del Nord Italia.
Restiamo a Bologna e all’Emilia. Quel flusso di dati investigativi parla di uno scambio continuo di notizie, arresti, sequestri e atti giudiziari che riguardano gli affari delle cosche mafiose anche in questo profondo Nord.
La mafia arriva dove meno te l’aspetti. Arriva dove c’è ricchezza e i soldi sporchi si possono nascondere meglio perché in mezzo a tanti altri nessuno li vede per quello che sono. Soldi della mafia, appunto, e dunque sudici.
Nel suo ufficio di Roma, il funzionario dello Stato Giovanni Melillo parla delle mille emergenze mafiose di quella bolgia quotidiana che è la Sicilia o Napoli o la Calabria, ma parla anche dell’Emilia-Romagna come se fosse un altro pianeta, sul quale sono ormai sbarcati gli alieni e pochi sanno ancora riconoscerli.
Da alcuni anni le indagini quotidiane sull’asse giudiziario Napoli-Bologna sono condotte «a doppia firma», in calce c’è quella del procuratore di Napoli e quella del procuratore di Bologna.
Dice il pm Melillo: «Chi fa le indagini sulle mafie dà ormai per scontato il seguente fatto: l’Italia del Nord e anche l’Emilia sono luoghi dove la mafia è presente, ma si mimetizza perché non può permettersi di essere un potere sfrontato come accade nelle regioni del Sud».
Ma chi sono «questi alieni» che si stanno mangiando l’economia del profondo Nord? E come riconoscerli a Reggio Emilia, per esempio?
Gli alieni della mafia sono i manager dai nomi poco altisonanti, ma che nel Nord dell’Italia gestiscono gli affari della prima impresa per fatturato nel nostro paese: tra i 100 e i 130 miliardi all’anno, come ricordato. Nulla a che fare con prodotti industriali, capannoni, presse, software o quotazioni in Borsa valori.
Chi ha così tanti soldi – soprattutto se guadagnati fuori dalla legge e sporchi di sangue – va e investe dove nessuno può riconoscerlo, almeno all’inizio.
L’Emilia è uno dei posti giusti: ricca, aperta, non diffidente per cultura, abituata al benessere e alla ricchezza. Così, rieccoci alla battuta di Giovanni Melillo, magistrato antimafia da decenni impegnato in indagini sulle cosche campane: «Questi si stanno mangiando...». I poveri emiliani, insomma, divorati dalla mafia?
In quale modo le mafie siano sbarcate sul «pianeta» Emilia-Romagna è presto detto.
Hanno iniziato con la gestione del gioco d’azzardo e poi hanno continuato a controllare i subappalti. Prima i piccoli, poi via via anche quelli medi. Un vortice invisibile, silenzioso, inodore e insapore. Come i soldi.
Restiamo al nostro esempio di Reggio Emilia. E vediamo quando e come – in base agli atti giudiziari disponibili – le mafie avrebbero messo piede in città.
Partiamo dal rapporto annuale della Dna (Direzione nazionale antimafia), firmato dall’ufficio del superprocuratore nel 2007.
A proposito di presenza della ’ndrangheta, scrive la Dna alla pagina 284 del suo rapporto: «A Reggio Emilia, le indagini succedutesi nel tempo hanno permesso di affermare con certezza un forte radicamento di affiliati alle aggregazioni mafiose di Cutro e Isola di Capo Rizzuto riconducibili alle cosche Arena-Dragone e Grande Aracri-Nicoscia».
I reggiani iniziarono a rendersene clamorosamente conto la sera di domenica 12 dicembre 1998, quando ci fu un’esplosione all’interno del bar Pendolino di via Ramazzini. Era un locale gestito da calabresi proprio alle spalle del centro storico, lungo i binari della ferrovia che divide in due la città. Fu il primo attentato mafioso a Reggio, la prova del tentativo concreto di «esportazione» della sanguinosa faida tra i clan Dragone e Grande Aracri in quella città. Una bomba per avvertimento mafioso, nel cuore di Reggio nell’Emilia.
La sera del 12 dicembre 1998 quattro attentatori gettarono dentro il bar una bomba ananas: in quel momento nel locale c’erano una ventina di persone sedute ai tavoli a giocare a carte e alcuni ragazzi incollati ai videogiochi. Dieci di loro rimasero feriti.
Cinque giorni prima di quell’esplosione, sempre in città, era stato ucciso un uomo nato a Cutro e residente a Reggio. E la bomba nel bar con vista sulla ferrovia fu in quel momento messa in relazione a quell’omicidio. Una sorta di faida calabrese nel cuore dell’Emilia.
Va spiegato che c’è un solido legame storico tra Reggio Emilia e il paesone di Cutro, diecimila anime nell’entroterra ionico della provincia di Crotone. Laggiù c’è un paese che si è quasi interamente trapiantato mille chilometri più a nord: più della metà dei cutresi vivono a Reggio nell’Emilia. Per decenni gli emigrati cutresi a Reggio hanno fatto i muratori e i piccoli appaltatori. Il mercato dell’edilizia reggiana, prima dell’arrivo massiccio di immigrati rumeni, si fondava su manodopera cutrese. E cutresi, dopo un paio di generazioni, sono oggi alcuni esponenti della classe dirigente della città: siedono in consiglio comunale, sono dirigenti in partiti di sinistra e di destra e occupano poltrone di spicco in enti pubblici, fanno gli avvocati, i commercialisti e i professori.
Ma tra così tanta gente, e tutta proveniente da un luogo ad alto e storico tasso di mafia, ci sono anche le «mele marce». È il caso di Francesco Grande Aracri, fratello del capo cosca Nicolino e residente a Brescello, confini nord della provincia reggiana, in un quartiere di soli calabresi che i cittadini locali hanno non a caso ribattezzato «Cutrello».
Il 19 aprile 2007 la Cassazione ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di diversi componenti di spicco del gruppo malavitoso che fa capo a quella cosca cutrese, accusata anche di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, riciclaggio e inquinamento del sistema degli appalti a Reggio nell’Emilia.
A pagina 285, il rapporto della Dna continua così: «La profondità del radicamento nel territorio emiliano delle suddette organizzazioni mafiose è stata, del resto, attestata anche attraverso gli esiti di un’articolata indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che determinava l’arresto nel 2006, a seguito di numerosi omicidi verificatisi in Isola di Capo Rizzuto, di alcuni imprenditori calabresi, ritenuti esponenti delle due cosche cutresi, residenti a Reggio Emilia e provincia e arrestati perché ritenuti coinvolti in attività di riciclaggio di denaro proveniente dalle attività illecite delle cosche, operanti in quel comune». Il Comune di cui parlano i procuratori nazionali antimafia è proprio Reggio nell’Emilia.
Il pm Giovanni Melillo spiega la natura delle infiltrazioni mafiose nel Nord: «Le imprese illegali in questione sono per definizione flessibili, si adeguano ai mercati e li invadono. Prendono appalti anche piccoli e privati nel settore edilizio o in quello dello smaltimento dei rifiuti dove praticano una concorrenza serrata con le imprese legali perché hanno costi ridotti e agiscono fuori dalle regole. Oppure si associano con altre imprese e così si mimetizzano nel contesto in cui arrivano».
I magistrati nazionali antimafia raccontano che il meccanismo dello sbarco di interessi mafiosi a Reggio Emilia è avvenuto per cooptazioni successive, all’inizio confuso tra le pieghe dei flussi di emigrazione dal Sud.
Così la mafia calabrese si è infiltrata nell’economia locale, soprattutto nel settore dei piccoli appalti: ci sono varie e non smentite denunce alla magistratura reggiana sull’affidamento di lavori in ambito edilizio a imprese sospette. Per esempio, quelle sulle centinaia di rotonde che, nell’ultimo decennio, sono spuntate agli incroci di Reggio come funghi dopo la pioggia.
Spiega Melillo: «Il meccanismo della penetrazione mafiosa in aree civili del nostro paese è semplice. Quando un nucleo mafioso si radica in luoghi come Reggio a storica presenza di meridionali, inizia con l’ospitare latitanti. Poi mette in piedi lo strumento delle estorsioni mafiose ai danni delle imprese pulite gestite da calabresi o campani. Questi ultimi pagano e non denunciano perché conoscono i linguaggi e li temono. Così la storia, prima tutta interna a un nucleo originario che conosce e subisce quei codici, ricomincia anche là dove la mafia non è storicamente radicata».
Tra Reggio e Modena, del resto, ci sono ormai tante storie che provano quanto dicono la relazione della Superprocura e il pm Giovanni Melillo.
Lasciamo stare i cutresi e prendiamo la camorra e il clan dei Casalesi. Proprio al confine tra le due province emiliane, a Soliera, è stato a lungo residente Nicola Schiavone, figlio di Francesco, detto «Sandokan», boss di Casal di Principe, spopolato paesone campano di 17 mila abitanti, 4.500 dei quali con precedenti penali e pullulante di imprese. Alcune con sede legale proprio in Emilia: quasi che i casalesi abbiano pianificato di fare soldi oltre la «linea gotica» e con quanto guadagnato lì tornare al paese per costruire una casa.
Scrivono i procuratori antimafia nella loro relazione sull’Emilia: «Va sottolineata la presenza nel modenese di una cellula camorristica direttamente sottoposta a Schiavone Nicola, attiva a fini di riciclaggio nel settore degli esercizi commerciali, oltre che (come emerso anche nelle ricordate indagini sulla cosca calabrese Vrenna-Pompeo) della gestione di locali adibiti al gioco d’azzardo».
Un’indagine coordinata dalla Procura antimafia di Bologna, finita il 9 marzo 2009 con numerosi arresti di membri del clan dei Casalesi in Emilia, ha stabilito che nello sfruttamento delle macchinette mangiasoldi, nella sola Modena, i camorristi guadagnano illegalmente circa 800 mila euro al mese.
Sono le mafie da esportazione, infiltrate tra i soldi che il mercato dell’economia legale produce nel Nord Italia. Secondo i risultati delle indagini della magistratura antimafia napoletana e bolognese, il clan dei Casalesi aveva esportato il metodo delle estorsioni e per prima cosa taglieggiava le imprese campane emigrate in Emilia.
A pagina 288 del rapporto 2007, la Dna descrive così la presenza del clan camorristico proprio in questa parte dell’Emilia-Romagna: «In generale, a tali rapporti estorsivi quasi naturalmente inerisce il rischio della generazione di più ampi vincoli di soggezione psicologica ed economica, funzionali, oltre che a fini di riciclaggio e reinvestimento speculativo, a più complessivi obiettivi di infiltrazione nella realtà economico-sociale emiliana, dovendosi stimare già assai rilevante l’effetto di alterazione del regolare andamento del mercato delle imprese del settore edile (soprattutto nelle zone di Modena e Reggio Emilia) sia nel settore privato che in quello pubblico». In quale modo la mafia altera il mercato delle imprese edili a Reggio? Secondo la Dna ciò avviene «attraverso l’imposizione di ditte subappaltatrici fiduciariamente legate ai gruppi criminali campani e, in particolare, casertani. Quest’ultimo fenomeno appare marcato anche con precipuo riguardo al sistema dei contratti di subaffidamento e fornitura connessi all’esecuzione di grandi opere pubbliche in relazione alla gestione dei quali gli organi di polizia preventiva segnalano l’anomalia di una presenza elevati...