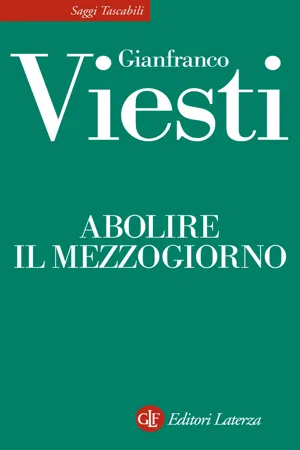
- 166 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Abolire il Mezzogiorno
Informazioni su questo libro
Per alcuni il Mezzogiorno è una palla al piede. Per altri è un alibi. Per alcuni è un noioso rituale da inserire in agenda. Per altri è la scorciatoia per arricchirsi illecitamente. Per tutti è una buona scusa per non affrontare realmente i problemi italiani. È dunque venuta l'ora di abolire il Mezzogiorno. Un saggio lucido e provocatorio di uno dei più innovativi economisti italiani.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Abolire il Mezzogiorno di Gianfranco Viesti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Business e Finanza. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
La storia del Nord e del Sud (1951-1992)
Un progetto per il Sud
«E cominciai anch’io a scendere per una specie di mulattiera, di girone in girone, verso il fondo. La stradetta, strettissima, che scendeva serpeggiando, passava sui tetti delle case, se così quelle si possono chiamare. Sono grotte scavate nella parete di argilla indurita nel burrone: ognuna di esse ha sul davanti una facciata; alcune sono anche belle, con qualche modesto ornato settecentesco [...]. Le porte erano aperte per il caldo. Io guardavo passando, e vedevo l’interno delle grotte, che non prendono altra luce e aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella: si entra dall’alto, attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri, dalle pareti di terra, vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia ha, in genere, una sola di quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini e bestie. Così vivono ventimila persone. Di bambini ce n’era un’infinità. In quel caldo, in mezzo alle mosche, nella polvere, spuntavano da tutte le parti, nudi del tutto e coperti di stracci. Io non ho mai visto una tale immagine di miseria: eppure sono abituata [...]. Continuavo a scendere verso il fondo del pozzo, verso la chiesa, e una gran folla di bambini mi seguiva, a pochi passi di distanza, e andava a mano a mano crescendo. Gridavano qualcosa, ma io non riuscivo a capire quello che dicessero in quel loro dialetto incomprensibile. Continuavo a scendere, e quelli mi inseguivano e non cessavano di chiamarmi. Pensai che volessero l’elemosina e mi fermai: allora soltanto distinsi le parole che quelli gridavano ormai in coro: – Signorina, dammi ’u chinì! Signorina, dammi il chinino! – Distribuii quel po’ di spiccioli che avevo, perché si comprassero delle caramelle: ma non era questo che volevano, e continuavano tristi e insistenti, a chiedere il chinino» (Levi 1949).
Così, in Cristo si è fermato ad Eboli la sorella descrive a Carlo Levi la realtà di Matera alla fine degli anni Trenta. È un’immagine forte; ma non diversissima da come una parte del Sud si presenta al termine della guerra: arretratezza, analfabetismo, miseria. Non mancano aree in condizioni migliori; ma la situazione è complessivamente difficile.
Eppure, la storia del Sud dopo l’Unità d’Italia non è affatto una esclusiva, tragica vicenda di depressione. Attraversa fasi di sviluppo, come negli anni Ottanta dell’Ottocento o all’inizio del XX secolo, durante il decollo dell’economia italiana. Grazie a fenomeni di apertura verso l’estero: alle esportazioni di prodotti agricoli e all’arrivo di imprenditori e imprese straniere; a un’emigrazione che aiuta a ridurre la pressione demografica, specie nelle aree interne, e garantisce rimesse che finanziano la modernizzazione agricola (più di 3.700.000 meridionali varcano l’oceano solo fra il 1901 e il 1913). Tuttavia, alcune grandi scelte nazionali non favoriscono quegli sviluppi; poi la Prima guerra mondiale, il blocco dell’immigrazione negli Stati Uniti e il fascismo (con l’opposizione a migrazioni da Sud a Nord nel paese) li frenano. L’autarchia rafforza la concentrazione al Nord dell’industria, le produzioni energetiche, chimiche, meccaniche lì localizzate; gli anni dopo la grande crisi del 1929 sono quelli «della disperazione nera» in tutto il Mezzogiorno (Rossi Doria 1982); il Sud ha un ruolo marginale nell’economia italiana, di grande area agricola a bassa produttività, con meno del 15% dell’occupazione industriale. Alla fine della Seconda guerra mondiale il reddito pro capite al Sud è un sesto rispetto agli Stati Uniti.
Dopo il fascismo e la Resistenza, è opinione comune che il miglioramento delle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini e il rafforzamento e l’ampliamento del sistema produttivo in tutte le regioni siano degli obiettivi politici essenziali per un paese moderno e civile. Vi è anche una forte sensibilità dell’Amministrazione statunitense per il Sud, per il quale viene immaginata una linea «rooseveltiana» di sviluppo. La strategia che viene progettata è coerente con la visione dell’azione pubblica dell’epoca: occorre intervenire direttamente nell’economia. La sua gestione è affidata a istituzioni straordinarie, anche per lo scetticismo sulle qualità della Pubblica amministrazione ordinaria, rimasta pressoché intatta dopo la caduta del fascismo. Non è una novità: a partire dalla creazione dell’INA nel 1912, e soprattutto dell’IRI nel 1933, lo sviluppo del paese è nelle mani di istituzioni «speciali» (Barca 1997). A un forte interventismo pubblico fa però riscontro una capacità di regolare l’economia assai scarsa: le attività produttive sono contrassegnate da estese barriere all’ingresso e dal prevalere di posizioni oligopolistiche e monopolistiche; le grandi imprese del Nord sono il centro dell’industria, ricevono ampi sussidi, e sono privilegiate dal credito bancario.
La strategia di sviluppo è impostata dagli stessi uomini che negli anni Trenta avevano creato l’IRI: l’idea di fondo è che occorre realizzare nel Mezzogiorno le precondizioni per lo sviluppo, prevalentemente infrastrutturali, attraverso un grande programma coordinato di opere pubbliche, gestito centralmente da un ristretto gruppo di capaci ed efficienti tecnocrati. La decisione di creare la Cassa per il Mezzogiorno ne è conseguente (D’Antone 1997). La sua azione ha inizialmente un grande successo: vengono realizzate importanti e utili opere pubbliche, di alta qualità tecnica: il 60% della spesa va a infrastrutture per l’agricoltura e il 15% ad acquedotti e bonifiche che sono alla base di un deciso aumento di produttività in diverse aree di coltivazioni orticole e frutticole. Il denaro dei contribuenti viene ben impiegato. Così al Sud, come al Nord, il benessere dei cittadini cresce a tassi sostenuti e per un lungo periodo di tempo. Al Nord significa case più ampie, elettrodomestici, motorizzazione di massa, le prime vacanze; al Sud significa svuotare i Sassi di Matera e dare una piccola ma «normale» casa ai loro abitanti, il calo dell’analfabetismo e della mortalità infantile.
Tuttavia, fino alla fine degli anni Cinquanta il Sud non ha alcun significativo sviluppo industriale, proprio mentre l’industria del Nord viene ricostruita e ampliata, e trae grande vantaggio dalla crescita del mercato interno e dagli iniziali successi all’esportazione, dai bassi salari e dalla loro dinamica molto più lenta rispetto alla crescita delle produttività. Le produzioni meridionali sono ancora principalmente basate su attività artigianali (fornai, sarti, ciabattini, falegnami, fabbri) o di piccolissime imprese (materiali da costruzione) orientate alla domanda locale. Alla fine degli anni Cinquanta l’industria manifatturiera rappresenta ancora solo il 13% circa dell’economia meridionale, poco più di un terzo del suo peso al Nord.
L’industrializzazione: cattedrali nel deserto?
Anche per questo, con il 1958 si decide di industrializzare il Sud. Come per la fase precedente, si tratta di un’operazione pianificata dalla Cassa, che realizza aree e nuclei industriali in cui attirare investimenti di grandi imprese pubbliche e private. Un ruolo fondamentale viene giocato dalle Partecipazioni statali, cui viene assegnato per legge l’obbligo di localizzare nel Mezzogiorno il 40% dei propri investimenti. Si ha così uno sforzo poderoso di investimento, soprattutto attraverso la costruzione di grandi complessi nelle industrie di base, chimica e siderurgica, che cambiano radicalmente il volto di molte aree meridionali, da Taranto a Siracusa, da Gela a Crotone. Nel 1963 gli investimenti arrivano a rappresentare circa il 30% del PIL meridionale. C’è grande ottimismo: si sta finalmente risolvendo il problema dello sviluppo al Sud; città e campagne meridionali stanno cambiando come mai in passato.
Questo grande sforzo di industrializzare il Sud non è comunque in grado di garantire all’intero paese uno sviluppo equilibrato. Sono anni in cui, grazie alla realizzazione del Mercato comune europeo e alla crescita sempre più vivace dei consumi delle famiglie, l’industria registra una forte crescita, ma che continua in gran parte ad aver luogo nel Triangolo industriale. Ben presto lì si crea lavoro per tutti, e viene conseguentemente favorita una grande emigrazione dal Sud (anche per contenere le spinte salariali sul mercato del lavoro) verso Torino e Milano. Nel solo anno 1961 Torino accoglie 60.000 nuovi immigrati. Si spostano al Nord, fra il 1951 e il 1971, 4.200.000 meridionali, per due terzi provenienti dalle zone interne montane. Non è facile dire se si sarebbe potuto evitare, almeno nelle dimensioni in cui ebbe luogo, uno spostamento così massiccio di lavoratori e delle loro famiglie dalle campagne del Sud alle città del Nord. Questa migrazione di massa ha comunque costi non indifferenti. Di abbandono – da parte dei giovani più intraprendenti – di molte aree interne del Sud; cosa che non avviene nelle regioni del Centro, dove lo sviluppo delle aree rurali sarà poi vivace. Di congestione e snaturamento di grandi aree urbane, dal centro di Torino alla periferia nord milanese, che divengono grandi dormitori, simili alle grigie città industriali inglesi.
Il processo di infrastrutturazione e di industrializzazione del Mezzogiorno di quegli anni è comunque complessivamente molto vantaggioso per l’intero paese e in particolare per l’economia delle regioni del Centro-Nord. Le imprese settentrionali non ne traggono solo cospicui incentivi per le produzioni che vengono localizzando al Sud, «produzioni che, per dimensioni di impianto e per l’inquinamento atmosferico provocato non potevano più insediarsi nel Nord del paese» (Bianchi 2002). Ne traggono un crescente mercato per i propri macchinari e impianti, e per i propri beni di consumo, al crescere e al diversificarsi della domanda in un territorio di venti milioni di abitanti. Ne traggono soprattutto le indispensabili forniture di base e di beni intermedi necessari per le loro produzioni. Tutti gli studi convergono nel valutare che l’aumento della produzione e del reddito al Sud induce automaticamente significativi vantaggi macroeconomici per il Nord.
Che cosa c’è, allora, che non va? Si tratta di un’esperienza condotta da uomini capaci ed esperti, in un clima di speranza sincera nello sviluppo civile ed economico, ma che ha limiti importanti, oggi facilmente individuabili (e che erano già chiari ad alcuni dei contemporanei), da ricordare con attenzione: perché spiegano una buona parte di ciò che accade dopo e, ancor più, perché contengono fondamentali insegnamenti per il presente e il futuro.
La scelta programmatoria pubblica si rivela – adesso è facile dirlo – assai infelice. Perché punta prevalentemente su quelle che all’epoca erano ritenute le industrie moderne: produzioni su larga scala di beni intermedi, come appena detto, necessari alle industrie utilizzatrici al Nord, vale a dire acciaio per le automobili e gli elettrodomestici, chimica di base per tutte le trasformazioni successive, petrolio raffinato per la motorizzazione. Industrie, per condizioni tecnologiche e di mercato, ben poco orientate all’esportazione: quando, dagli anni Sessanta, e poi ancora più intensamente in seguito, lo sviluppo dell’economia italiana è trainato dall’export, ne traggono vantaggio solo indirettamente. Sono poi industrie che vengono messe in crisi dal forte aumento del costo dell’energia alla metà degli anni Settanta e che perdono notevolmente importanza negli anni successivi, con la diffusione dell’economia della conoscenza. Se è possibile operare una schematizzazione in parte forzata, l’industrializzazione del Sud in questo periodo è un caso di scuola, come negli stessi anni in India, in Brasile o nei paesi comunisti, di strategia di «sostituzione delle importazioni» volta alla creazione di capacità produttiva nazionale. Da questo punto di vista è sostanziale la differenza, nella qualità dello sviluppo, rispetto a quello che si comincia a realizzare negli stessi anni in alcune regioni del Centro e del Nord-Est: questo è al contrario un caso di scuola di strategia, come nel Sud-Est asiatico, volta allo sviluppo delle esportazioni. All’epoca è impossibile immaginare che il caso di maggior successo dell’industrializzazione del Sud sarà la produzione di divani imbottiti in un’area interna, competitiva grazie a una fortissima innovazione organizzativa e di processo, totalmente orientata ai mercati internazionali e sorta e sviluppatasi dal basso grazie alle geniali intuizioni di un piccolissimo imprenditore, Pasquale Natuzzi, e ai conseguenti fenomeni imitativi (Viesti 2001a). D’altra parte, il successo del Veneto, della Toscana, delle Marche è basato su settori all’epoca ritenuti arretrati e marginali, e a lungo sottovalutati.
Ma non si tratta solo di questo. Sono in molti casi grandi stabilimenti indipendenti, «a ciclo continuo» e a tecnologia complessa. D’altra parte la modernità dello stabilimento tarantino, e l’importanza del suo ruolo nell’economia italiana, sta proprio nella tecnologia siderurgica a ciclo continuo, sostenuta dai vertici dell’IRI e della Cassa, contro la resistenza degli industriali privati. E la realizzazione di grandi moderni impianti con produzioni su larga scala è un tratto comune delle politiche industriali dell’epoca in tutti i paesi europei, a cominciare dalla Francia. Quando vengono localizzati in territori ancora largamente agricoli, essi hanno però ben poche possibilità di indurre lo sviluppo di fornitori di beni e servizi, che non siano quelli più semplici, dalla guardiania alla pulizia. La speranza di usarli come motori dello sviluppo di interi territori, ben presente in tutti i documenti programmatori dell’epoca, non si realizza. Si tratta dunque, quasi sempre, di «cattedrali nel deserto».
Il loro impatto è comunque notevole. Larghi tratti di coste bellissime sono pesantemente trasformati; e, purtroppo, come ci si renderà conto molto più tardi, è spesso forte l’impatto dovuto all’inquinamento. Nelle aree di insediamento, i nuovi stabilimenti reclutano gran parte della manodopera maschile disponibile a cui offrono condizioni salariali e normative migliori di quelle vigenti nelle altre imprese del posto: questo comporta l’abbandono non solo dell’agricoltura di sussistenza, ma anche di tutte quelle attività artigianali e di piccolissima impresa che in molte aree italiane, a cominciare dal Nord-Est, sono alla base dello sviluppo negli anni Settanta. La concentrazione delle assunzioni, e il fatto che esse possono determinare una fondamentale differenza nella vita di una famiglia, apre uno spazio, che non si richiuderà più, per l’intermediazione politica e clientelare. La presenza di nuclei operai sindacalizzati determina, poi, un notevole «potere contrattuale» di questi territori nell’ottenere misure di sostegno e di emergenza.
La localizzazione degli impianti è in parte legata a elementi geografici, come la presenza di porti, in parte casuale, in parte preponderante legata a scelte politiche discrezionali, a una domanda politica di sviluppo che incontra la sua offerta. Mai, comunque, se non nel caso dell’area napoletana in cui esiste una piccola imprenditorialità e una presenza operaia metalmeccanica, questi insediamenti hanno legami con la realtà sociale ed economica preesistente. La strategia è unica per l’intero Mezzogiorno e a esso in maniera omogenea viene applicata. Tuttavia, anche se il Mezzogiorno degli anni Cinquanta è un’area povera, non è certo un territorio omogeneo. Non economicamente, con differenze non solo fra l’area napoletana, di ben maggiore tradizione industriale e artigiana, e il resto del Sud; ma soprattutto fra zone ad agricoltura ben diversa, magistralmente descritte da Manlio Rossi Doria: fra la polpa, l’agricoltura intensiva, orticola, frutticola, vinicola, a più alta produttività, delle coste, e l’osso, l’agricoltura povera, di mera sussistenza di molte aree interne. Non culturalmente: basti pensare alla differenza tra il forte radicamento mafioso della Sicilia occidentale e la dinamicità della Sicilia sud-orientale: fra Palermo e Catania.
Come detto, protagoniste principali di questi processi sono le Partecipazioni statali: l’IRI e l’ENI, e poi, a partire dalla sua creazione nel 1962, il composito gruppo EFIM. Non mancano investimenti privati, in alcuni casi anche dall’estero: sono favoriti dal clima politico complessivo, dalla fiducia nella determinazione del Governo italiano nel voler far sviluppare il Sud; dalla realizzazione di aree industriali; dall’esistenza, ancora negli anni Sessanta, di condizioni salariali e di complessivo costo del lavoro che (per quanto superiori a quelle delle imprese locali) sono ben inferiori a quelle medie europee. Ma soprattutto da forti incentivi pubblici agli investimenti. Politiche di incentivi alle imprese (contributi, interessi agevolati) per gli investimenti in specifiche regioni sono uno strumento comune nell’Europa dell’epoca: gli incentivi per il Mezzogiorno sono però generosi e la capacità pubblica di selezione, al contrario di quanto accade in Francia, modesta: questo favorisce anche la costruzione di impianti dall’economicità di mercato dubbia, che sarebbero stati messi in crisi (come in effetti avvenne) dai primi problemi di mercato; o addirittura, investimenti «di rapina» da parte di imprese del Nord, destinati fin dall’inizio a dipendere esclusivamente dai contributi pubblici, e poi ceduti – come si vedrà più avanti – alle Partecipazioni statali, come accadde alla SIR e alla Liquichimica.
Vi sono importanti effetti indiretti. La continuazione di una politica «straordinaria» per tutti gli anni Sessanta rende definitivo il ruolo centrale dello Stato come protagonista dello sviluppo; e in particolare di istituzioni speciali, indipendenti dalla Pubblica amministrazione ordinaria, dotate di grandi risorse, quasi impenetrabili a ogni valutazione di efficacia. Queste istituzioni sono a lungo guidate da manager dal grande potere, ma anche di grandi capacità e dotati di un forte senso di missione. Progressivamente però, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, si rafforza il controllo politico diretto sull’attività degli enti straordinari, tanto sulle Partecipazioni statali quanto sulla Cassa. A esse vengono progressivamente assegnati sempre nuovi compiti: alle prime i salvataggi; alla seconda gli interventi infrastrutturali più minuti (le «fontanelle») cui avrebbe dovuto provvedere l’azione ordinaria. Ma soprattutto la loro gestione diviene sempre più legata alle volontà dei partiti politici, in primo luogo della Democrazia cristiana, ma anche del Partito socialista italiano.
Le fratture dell’industrializzazione
Tutto lo sforzo nel Sud scaturisce da due convinzioni: che l’industrializzazione, tramite imprese «fordiste» (grandi produzioni standardizzate), sia sinonimo di sviluppo economico e che lo sviluppo economico sia sinonimo di sviluppo civile, sociale, culturale.
Questo in parte accade, con non pochi effetti positivi. Ma questo processo...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Ringraziamenti
- Lo sviluppo territoriale in Italia
- La storia del Nord e del Sud (1951-1992)
- Gli anni Novanta
- Centrosinistra e Centrodestra
- Il futuro possibile
- Riferimenti bibliografici