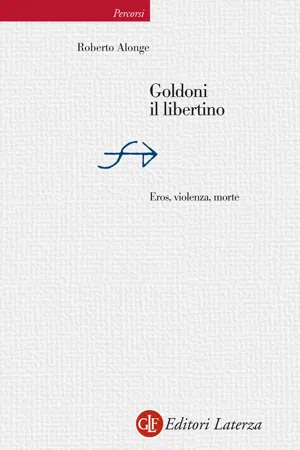1. In principio era il sesso
Un illustre contemporaneo di Goldoni, Denis Diderot (grande illuminista, padre della Enciclopedia), ricorda la propria giovanile tentazione di fare l’attore, e si confessa con lucida onestà: «Quale era il mio progetto? Essere applaudito? Forse. Vivere familiarmente con le donne di teatro che io trovavo infinitamente amabili e che io sapevo molto facili? Sicuramente». Ciò che conta – nel sogno di diventare uomo di teatro – non è tanto il successo, l’applauso del pubblico, bensì la possibilità di una vita più libera e più libertina, con le belle attrici che risultano «infinitamente amabili» e al tempo stesso «molto facili», cioè di facili costumi. Come dire che nel cuore del Settecento viene riconosciuto con estrema chiarezza lo stretto legame che sussiste organicamente fra palcoscenico e sesso, fra professione teatrale e pratica erotica. Peraltro, è così da duecento anni, da quando – a metà del Cinquecento – nasce la Commedia dell’Arte, che inventa il mestiere del teatro, fondato su un paio di decisivi elementi nuovi rispetto alla tradizione secolare: la presenza sulla scena della donna, vera calamita che attira i clienti-spettatori (come succede ancora oggi rispetto alla pubblicità, in cui il corpo della donna è l’autentico motore della promozione, essenziale per vendere qualunque cosa, da un dentifricio a una birra); e la prassi itinerante delle compagnie teatrali, che viaggiano incessantemente, per andare a cercarsi il pubblico, in un momento storico in cui le città sono ancora troppo piccole per consentire a un gruppo di lavorare stanzialmente, rimanendo fissi in un luogo determinato. Ma proprio la dimensione del viaggio continuo, con relativa promiscuità uomo-donna, determina rapporti interpersonali più trasgressivi, etiche sessuali più aperte, famiglie allargate. Le compagnie teatrali finiscono per porsi come micro-società con valori e regole alternative a quelle della macro-società dell’epoca, conservatrici e repressive.
Ecco, Goldoni non ha la limpida trasparenza delle esternazioni di Diderot, ma appartiene allo stesso secolo e alla stessa visione del mondo. Quando nelle proprie memorie rievoca la sua personale scoperta del teatro – lui allora adolescente di quattordici anni – utilizza espressioni particolarmente significative:
era la prima volta che vedevo delle donne sul palcoscenico, e trovavo che questo abbellisse la scena in una maniera più piccante. [...] I primi giorni andavo alla commedia molto modestamente, in platea, e vedevo dei giovani come me tra le quinte. Tentai di giungere fin là, e non trovai nessuna difficoltà; guardavo con la coda dell’occhio quelle signorine, e loro mi fissavano arditamente.
Il teatro non è riconducibile strettamente alla figura femminile, ma questa è sicuramente un abbellimento fondamentale della scena. Goldoni scrive le sue memorie in francese (da vecchio, quando da un quarto di secolo vive a Parigi), e usa l’aggettivo piquant, dal verbo piquer, pungere, stuzzicare, stimolare. La vista delle attrici lo eccita, e i suoi coetanei che si intrufolano fra le quinte lo spronano alla emulazione. Goldoni giovinetto è spinto a fare la stessa cosa, e accerta – con sorpresa e compiacimento – di non trovare nessuna difficoltà, di non incontrare resistenza. La scena è l’universo delle donne, che però si dischiude prontamente, si apre docile, offrendosi all’estraneo. È la medesima impressione di Diderot, che parlava di donne «molto facili» (très faciles). Goldoni ragazzetto è ovviamente più represso, osserva le attrici timidamente, con la coda dell’occhio (je regardois du coin de l’œil ces demoiselles). Notate che non le chiama «attrici», bensì «signorine» (demoiselles). Il teatro è veramente il territorio del femminile, la zona misteriosa e affascinante, il luogo inquietante dell’altro. Tanto più inquietante perché capace di fissare negli occhi il povero fanciullo, con il volto terrifico della Medusa: elles me fixoient hardiment, «mi fissavano arditamente». Il maschietto si vergogna di sbirciare il corpo delle signorine, perché sa benissimo che il suo è un rimirare bruciante di desiderio, di concupiscenza, e non già una contemplazione estetica della loro bravura attorica. Per questo le adocchia velatamente, pudicamente, «con la coda dell’occhio». Ma le signorine lo guatano hardiment, arditamente, sfacciatamente, spudoratamente, cioè senza pudore. Smascherano lo sguardo del ragazzetto per quello che è, sguardo carico di carnale pulsionalità. Il teatro si svela quale sorta di iniziazione sessuale del piccolo uomo. D’altra parte, di che stupirsi? È la tradizione della Commedia dell’Arte: le attrici sono tutte un po’ baldracche (per usare un bel termine pirandelliano), come gli attori sono tutti un po’ balordi e mascalzoni. Ci può anche essere qualche eccezione (per esempio, il teatrante settecentesco Luigi Riccoboni, detto Lelio, messo in croce fra le ragioni della devozione religiosa e le ragioni dell’Arte), ma è l’eccezione che conferma la regola.
Diciamolo in un altro modo, più affascinante (e più provocatorio): non è già che, a fare l’attore, si diventa libertini; è, piuttosto, che i libertini decidono prevalentemente di fare gli attori. Come oggi ci è assai comprensibile per molteplici problematiche: ad esempio che non ci si scopre pedofili a furia di lavorare con i bambini; sono i pedofili che optano per profili professionali dove il rapporto con i bambini è intenso. Carlo Goldoni, come occupazione – per campare –, dovrebbe fare l’avvocato, ma riesce di fatto a campare come commediografo (storicamente è uno dei primi a spuntarla in simile impresa). Perché gli piace stare insieme agli attori, e soprattutto alle attrici, che si porta a letto sistematicamente, facilitato in questo dalla presenza di una moglie paziente e sottomessa.
Ma vediamo che ricaduta ha tutto ciò a livello di drammaturgia, assai più intrigante di quanto si sia fin qui sospettato. E cominciamo con la prima commedia scritta da Goldoni, Momolo cortesan, andata in scena nel 1739 (non tengo conto – qui e sempre – del more veneto, per il quale l’anno solare iniziava il 1° marzo: dunque dico 1739 anche se la messinscena fu tra gennaio e febbraio 1738 more veneto). C’è però preliminarmente una complicazione da spiegare. Al tempo di Goldoni è ancora viva (sebbene già in decadenza) la Commedia dell’Arte, che da due secoli ha introdotto un nuovo modo di operare sulla scena: non c’è un testo, ma solo un canovaccio, una scaletta, una successione di argomenti, scena per scena, e per il resto gli attori improvvisano. Goldoni deve fare i conti con questa realtà. È rimasto famoso per aver realizzato la sua riforma teatrale, imponendo agli attori un testo scritto tutto intero dall’inizio alla fine – disteso, come si dice –, eliminando la prassi dei canovacci. Non sono però cose che si fanno dall’oggi al domani. All’inizio Goldoni scrive soltanto mezze commedie (o anche meno, forse solo un quarto di testo, e tre quarti lasciati all’improvvisazione). È la maniera – gradualistica, ragionevole – di far marciare la riforma, non contro gli attori, ma con gli attori. Orbene, questi testi scritti solo parzialmente si sono perduti, non ci sono arrivati. Ma un quindicennio dopo, quando ormai ha vinto, dall’altezza del suo piccolo trionfo Goldoni si mette a riscrivere le prime commedie/canovacci. Dunque – per capirci – Momolo cortesan è rappresentato nel 1739, ma il testo che abbiamo è stato in realtà ri-scritto nel 1757, con un nuovo titolo, L’uomo di mondo. So che filologicamente è una forzatura metterlo qui – ad apertura del mio romanzo goldoniano – ma cercherò di renderne conto nella Postfazione, cui pertanto rimando.
Nell’azione di rifacimento Goldoni (lo dichiara lui stesso) cambia moltissimo, ma conserva l’inquadramento veneziano e la parlata dialettale di Momolo: un modo fortemente simbolico di segnare l’incipit di una vasta produzione teatrale che affonda le sue radici nella humus veneziana. Ad apertura di sipario c’è persino il dato più coloristico della città lagunare, il profilo di una gondola che attracca, per scaricare due turisti romani. La prima battuta è del gondoliere, che invoca un qualche facchino per sbarcare i bagagli:
Truffaldino Son qua mi. Volìu che porta la gondola?
Gondoliere No vôi che portè la gondola, sior martuffo [babbuino], ma sto baul.
Truffaldino Dove l’hoi da portar?
Gondoliere Qua, alla locanda del Fongo.
Ludro (Vôi veder de introdurme con sti forestieri, per veder de beccolar [buscare] qualcossa, se posso) (da sé).
Truffaldino Quant me vulì dar a portar sto baul? (al Gondoliere)
Gondoliere Cossa serve? Avè da far con dei galantomeni.
Silvio Accordatelo voi. Noi non siamo pratici del paese.
Beatrice Questo star sulla strada non mi accomoda. In altri paesi vengono i camerieri delle osterie a ricevere i forestieri. Qui non si vede nessuno.
Ludro Comandele che le serva? che chiama mi i omeni della locanda?
Sin dalla prima scena della sua prima commedia Goldoni non indulge al patriottismo e al folklore municipalistico della razza padana, della brava gente di San Marco. Evidenzia criticamente che non c’è molto senso ospitale, e nemmeno professionalità alberghiera. Giustamente la signora (romana) fa confronti con altre città, dove i camerieri si sbracciano per introdurre i clienti nelle locande. Nemmeno il facchino, Truffaldino, sembra aver voglia di rompersi la schiena a portare bauli, e, pur essendo lì per questo, chiede stupidamente se deve guidare la gondola, prendendosi dello scimunito («martuffo», propriamente «babbuino») dal gondoliere. Per fortuna (o per sfortuna) si aggira all’intorno un sinistro figuro («imbroglione veneziano», secondo la tavola dei personaggi), Ludro, che fa valere la legge del taglieggiamento: ci pensa lui a pagare gondoliere e facchino, ma si tiene per sé una parte di quanto incassa dagli stolti turisti romani. Ed è solo l’inizio. Brighella è un oste svogliato quanto il facchino Truffaldino. Non guarda dalla finestra e non esce dal suo ostello finché Ludro non «batte alla locanda», e manifesta subito un incongruo approccio moralistico, che non è cosa da incoraggiare i clienti:
Brighella I sarà, m’immagino, marido e moglie.
Ludro Senz’altro. Ste cosse no le se dimanda. Un letto solo, non è vero? (a Silvio)
Silvio Siamo marito e moglie; un letto solo ci basta, ma almeno due camere sono necessarie.
Ludro Certo, do camere. Una per dormir, l’altra per ricever. A sto zentilomo bisogna darghele; bisogna servirlo ben.
Meno male che c’è Ludro, che però è troppo ladro, per dirla con una battuta facile di Truffaldino («Sior ladro», lo apostrofa Truffaldino, che poi si corregge: «Compatime; ho volesto dir sior Ludro»), e si mette a giocare a carte con il marito, spennandolo subito di tutto l’imprecisato contante che quello si ritrova in tasca, oltre a trenta zecchini sulla parola.
Poco dopo, in I, 6 (atto primo, scena sesta), arriva il protagonista, Momolo cortesan. L’aggettivo significa cortigiano, nel senso di uomo di mondo, attento ai piaceri della vita, ma anche con un suo profilo sportivo-cavalleresco. Non un intellettuale, ma un giovinastro sveglio, un po’ scialacquatore perché edonista. La tavola dei personaggi lo definisce «mercante giovane veneziano» ma per tutta la commedia non c’è modo di sentirlo parlare di affari e di mercanzie. Ha dei capitali, certo, ma vediamo come li spende, non già come li guadagni. La coloritura iniziale è pera...