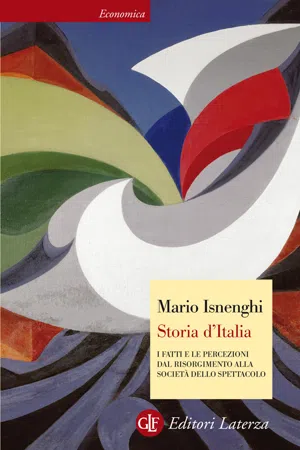VII. LA GRANDE GUERRA AL CALEIDOSCOPIO
Squadre benedette
All’altare officia un prete che intona le laudi. I soldati rispondono in coro: «Ora pro nobis...».
Verso la fine, accompagnati dalle note gravi e profonde dell’organo, i soldati cantano un inno. Il coro si leva solenne e riempie la chiesa. Io taccio: ignoro l’aria e le parole. Il ritornello dice:
Deh, benedici, o madre,
L’italica virtù;
Fa’ che trionfino le nostre squadre
Nel nome santo del tuo Gesù.
Il coro è finito con un lungo gemito dell’organo.
I soldati sfollano.
Benito Mussolini
Il diario di guerra (1915-1917), 15 novembre 1915
Canti degli Alpini
E quando passa l’artiglieria
coi suoi cannoni spazza la via.
Quando cavalca ‘Piemonte Reale’
non si sa bene qual è l’animale.
Trotta, galoppa, noi soma alpin,
Viva l’Italia e viva ’l bon vin.
E quando passa la fanteria
coi suoi fagotti ingombra la via.
Cessa la mafia, o bersagliere,
che con la penna ti buco il sedere.
Corda, manilla, piccozza e rampon,
questa è la bella vita dei veci scarpon.
L’Arma del Genio è l’arma dei fessi,
a noi alpini puliscono i cessi.
La Sussistenza la rispettiamo
per le pagnotte che le freghiamo.
Largo che passano i baldi alpini,
viva l’Italia e viva ’l buon vin.
E quando passa...
Istruzioni per l’uso
Attori o vittime? La storiografia odierna sulla prima guerra mondiale si divide per grandi approcci e presupposti mentali. I disincanti serpeggiano anche fra gli addetti ai lavori, diversi dei quali non riconoscono più grandi distinzioni fra storia e letteratura oppure fra storia, politiche della memoria e uso pubblico della storia: tutto è narrazione, retorica, invenzione, oppure asserzione di valori. L’immane strage della prima guerra mondiale – tuttora un magnetizzante campo di applicazione di metodologie ed approcci – appare oggi a molti un informe luogo di rottamazione di ideologie remote, destituita d’ogni ragion d’essere, ridotta all’esplosione dell’assurdo. Ma si dà storia dell’assurdo? Ha senso storicizzare il non-senso? La conseguenza di questa frattura valoriale è spesso un atteggiamento dimissionario, ovvero la dissoluzione dell’avvenimento storico in patologia disumana e in deprecazioni sdegnose per tutto quel sangue versato senza più un visibile perché. Così, nobilmente, la storia si converte in educazione civica, a maggior ragione ora che dobbiamo sforzarci di fraternizzare come nuovi cittadini europei. Qui faremo memoria delle vittime, né sarebbe possibile fare altrimenti; ma rimane protagonista il criterio degli attori, più inclusivo, e del loro proprio vissuto.
Rinviando a un quadro generale già fornito, traduciamone le acquisizioni nella luce propria di questa storia dell’Italia percepita e raccontata, a se stessi, prima ancora che agli altri. Ne uscirà un caleidoscopio di sguardi, situazioni vissute, elaborazioni immediate o nella memoria, dei singoli e collettiva. Questo potrebbe indurre sensi di destrutturazione – colorita, fantasiosa, e labile: il moltiplicatore visivo vuole invece rappresentare una variazione degli sguardi e un arricchimento della casistica, e niente affatto la rinuncia alla ‘grande narrazione’, una riduzione ai frammenti e una assolutizzazione del soggettivo e del relativo. Nel micro affiorerà il macro, nel dato di cronaca o esistenziale tracce ed indizi di un processo collettivo: ciò che è destinato a fissarsi nella memoria – non solo degli eroi, anche dell’uomo e della donna qualunque – come la Grande Guerra.
Cambiare, ripartire: Benito Mussolini
dall’«Avanti!» al «Popolo d’Italia»
C’è un’antica parola dotta – palinsesto – che il linguaggio televisivo ha rimesso in circolazione. E Benito Mussolini può essere considerato un palinsesto della storia d’Italia – il paese degli ex –, l’uomo-simbolo di questa riscrittura perenne, che permette di cogliere ancora le sottostanti stratificazioni: sue, di Mussolini, e della storia collettiva che gli avviene di interpretare e di portarsi addosso. Lo si guardi dal punto di vista del popolo o dal punto di vista della nazione, della scissione di classe o dell’integrazione interclassista. Di più: nelle svolte e negli itinerari suoi propri e nella riscrittura mentale e storica che investe le ripartenze dell’Italia, perché il personaggio si evolve, reinterpreta, rifà se stesso, e perché una moltitudine crescente e tuttora ininterrotta di interpreti ne ripercorre e rimette in sesto la biografia. Mussolini immaginario rappresenta un punto di arrivo di questa rifrazione degli sguardi, fra cui quelli degli autori di biografie sono solo i più visibili e idonei a propagarsi. Nell’estate-autunno del ’14 il comparire della guerra e la coazione a schierarsi travolgono identità e confini di singoli e gruppi. L’uomo-tipo di questo semiuniversale cambiare e ripartire è il trentunenne titolare, sin lì, di un itinerario classico da sovversivo – diciamo pure da ‘rivoluzionario di professione’ – nella più proverbiale delle regioni sovversive: la Romagna. Nel 1912 il congresso del Partito socialista a Reggio Emilia lo ha proiettato al vertice come direttore dell’«Avanti!»: la tribuna che da oltre un quindicennio alfabetizza e ‘nazionalizza’ il popolo di sinistra e da cui i socialisti fanno quotidianamente conoscere, meglio che alla Camera, le proprie posizioni. In quei due anni fra 1912 e 1914 il giovane massimalista ha tirato su il quotidiano che dal 1896 oscilla e fa da sponda nell’eterna dialettica fra riformisti e massimalisti: tiratura e diffusione crescono rispetto alla direzione di Claudio Treves, il vice-Turati. E mentre i Dioscuri del riformismo milanese, con Anna Kuliscioff, alimentano l’onesto ordito della loro rivista «Critica Sociale», anche il giovane leader lancia una sua rivista, che da quel gradualismo sconfina fin dal titolo suggestivo e captante «Utopia», oltre che con i temi e le frequentazioni dell’Estrema sinistra. Questo Homme qui cherche – così Mussolini si era qualche volta firmato su «La Voce», un luogo generazionale dei nati negli anni Ottanta che non manca al suo cursus honorum – si trova a suo agio nella stagione emozionale e decisionista che s’apre, molto più di coloro che fanno della misura, del gradualismo e dei tempi lenti di elaborazione la cifra della propria identità ed azione politica. Non al modo dei ventenni che stanno per essere impegnati sulla prima linea in senso militare, ma nel campo della lotta politica, Mussolini – classe 1883 – si può considerare in prima linea, adesso che l’esser giovani sta diventando una categoria politica. Giolitti nel ’15 ha settantatré anni, Salandra sessantadue, Sonnino sessantotto, appena meno attempato Turati che è del 1857 e sfiora i sessanta. Anche solo per quel senso di affinità insito nelle appartenenze generazionali si orientano verso il giovane e seduttivo direttore dell’«Avanti!» i giovani della Federazione giovanile socialista, gli «operaisti» di Torino, il napoletano Amadeo Bordiga.
Guerra alla guerra/Guerra alla pace Ebbene, dove indirizza i lettori dell’«Avanti!» e in particolare le componenti politiche e generazionali di cui può rivendicarsi interprete? Perentoriamente, nei primi due mesi della guerra europea alla più rigida neutralità: la famosa «neutralità assoluta», sui cui spalti si batte per tutta l’estate l’«Avanti» di Mussolini, e che solo sul far dell’autunno sfuma in «neutralità attiva e operante», per precipitare il 15 novembre nella «parola paurosa e fascinatrice: guerra!». Quella che chiude l’articolo di fondo del primo numero del suo nuovo giornale: in certo modo un nuovo «Avanti!» non più della Classe ma della Nazione, appellandosi per intero a «Il Popolo d’Italia», scommettendo cioè su una saldatura lasciata in gran parte irrisolta dal processo di unificazione. Che è poi il problema storico – se essa vi sia stata o meno, e quanto a fondo rispetto a contadini e operai – che percorre tutta la guerra, prima, durante e dopo l’indice ‘impazzito’ di Caporetto.
Il cambiamento necessario – perché chi davanti all’esplodere del fatto-guerra non riesce a cambiare se stesso è assente alla storia, un partito inerte, un uomo morto – si concentra, per quell’uomo-simbolo, nel periodo dopo il 22 settembre e prima del 15 novembre 1914 e il mese decisivo è l’ottobre.
La prima data è quella del Manifesto contro la guerra, firmato dalla Direzione del Psi, che Mussolini può ancora stendere in unità di intenti con Turati e Prampolini. Nei giorni seguenti lo difende con determinazione dagli attacchi concentrici di conservatori, moderati e interventisti e da una «insurrezione antisocialista», che rifiuta la «concordia nazionale» auspicata a gran voce dal «Corriere della Sera». Ha ancora la civetteria di osservare che «Noi siamo il ‘nemico interno’ e ci vergogneremmo di essere trattati in modo gentile da coloro che abbiamo combattuto ieri e combatteremo domani». Ma il 20 ottobre Mussolini presenta alla Direzione del partito, riunita a Bologna, un suo ordine del giorno in cui la neutralità «assoluta» viene messa in dubbio dal vorticoso procedere degli avvenimenti politico-militari, che suggeriscono di stare, più pragmaticamente, a vedere. Ora e più avanti, il no alla guerra assolutizzato sulle prime viene legittimato come l’enfatizzazione necessaria del no all’unica guerra che in concreto avrebbe potuto esserci, quella agli ordini dei vecchi alleati della Triplice; e quindi, implicitamente, come una presa di posizione tattica, da ripensare, una volta passato quel rischio. Posto ai voti, nessuno lo segue su questo terreno, anzi viene subito vergato un nuovo manifesto contro la guerra, firmato da tutti meno lui. Così Mussolini, rimasto solo, dà su due piedi le dimissioni da direttore. Il clima nel partito è però così aperto e non ancora irrigidito nei suoi confronti che la stessa Direzione approva, dopo queste dimissioni, un documento di solidarietà, affetto e ammirazione per la sua opera di direttore; e arrivando a Milano, la sera stessa del 20 ottobre, «veniva accolto da una calda dimostrazione di simpatia nell’affollatissima adunanza di quella Sezione socialista».
Due giorni dopo, sono ancora i socialisti milanesi – sindaco e diversi assessori compresi – a far sentire la propria voce pro-Mussolini, chiedendo un congresso nazionale straordinario del partito per rideliberare su una materia che sfugge ormai ai dettami dell’Internazionale e ai deliberati pregressi. Una specie di referendum di cui la direzione dà comunque notizia nei giorni successivi mostra che l’enorme maggioranza delle sezioni è ferma sulle posizioni neutraliste della Direzione e dei manifesti contro la guerra, anche se all’interno non mancano gruppi di iscritti che la pensano come Mussolini; e – commenta un decennio dopo l’informato autore di I socialisti italiani e la guerra, memore dei suoi propri percorsi di socialista – «questa fu una delle non lievi ragioni de...