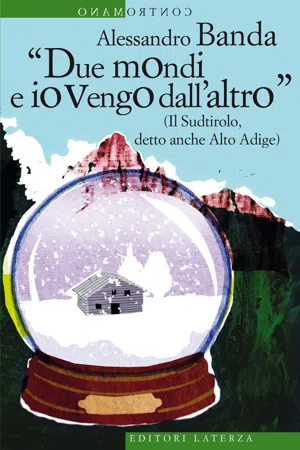Quando Kafka arrivò a Merano
In principio dunque erano i nomi.
Poi vennero i visitatori.
L’Alto Adige in effetti ha avuto molti visitatori famosi, di cui mena gran vanto. Guide turistiche, volumi riccamente illustrati o semplici dépliant tutti comunque si gloriano di questi ospiti noti. A ben guardare, cosa ne viene al turista dal fatto che un secolo o un decennio prima il tale o il talaltro scrittore, attore, regista, principe, conte o barone abbia soggiornato nel tale o talaltro posto? Niente, a rigore. Come spiegare questo culto della presenza passata? Questa venerazione della traccia lasciata? Forse come un’eco estenuata della vivificante apparizione divina. Solo che agli dèi antichi si sono sostituiti le dive e i divi moderni. Oppure si tratta di un caso particolare d’applicazione dell’argomento oggi più potente, quello d’autorità. Molto usato del resto dalla forma di comunicazione oggi più pervasiva e pressoché dominante, quella pubblicitaria. Ossia, per intendersi, è come se una voce anonima dicesse: vedi, pezzente d’un turista che non sei nessuno, anche il famoso Tizio e l’illustre Caio s’è degnato di passare qui, in questo luogo, una settimana o un mese; e quindi anche tu, melma della terra, puoi rallegrarti di imitarlo, benché non ne sia del tutto degno. O qualcosa di simile.
Comunque sia: tra questa innumerevole schiera di celebrità che hanno scelto l’Alto Adige come sede delle loro vacanze, ferie, momenti di svago o altro, un gruppo particolare è rappresentato dagli scrittori. Va da sé che io, per deformazione professionale (d’insegnante di lettere), sono particolarmente attratto da questo gruppo. Mentre attori, attrici, tronisti, manager, protagonisti di reality, cubiste, ciclisti, calciatori e press agent mi lasciano più indifferente. Ma la colpa è mia.
L’ho già detto che la loro presenza (parlo degli scrittori) sul suolo altoatesino è stata più volte ricordata e ricostruita, anche in testi di notevole pregio. Non voglio certo sostituirmi agli efficaci e diligenti autori dei testi suddetti, solo tentare di dare un quadro lievemente diverso, un taglio insolito alla descrizione di tutti questi soggiorni letterari o di letterati.
Cominciamo col dire che parecchi di questi scrittori non venivano in Alto Adige in quanto scrittori, ma in quanto malati. E se erano scrittori per loro, per se stessi intendo, e per i pochi intimi che sapevano che costoro scrivevano (e pubblicavano), non lo erano certo per l’universo mondo e nemmeno per il loro paese o, più modestamente, per la loro città o il loro quartiere. Nessuno sapeva che questi malati scriventi erano scrittori. Ignoti, sconosciuti, ignorati e isolati. Che venivano in Alto Adige a curarsi, generalmente affetti da tisi, e spesso vi morivano. In Alto Adige.
Quando Kafka arrivò a Merano per esempio, ai primi di aprile del 1920 (e aveva pubblicato la Metamorfosi e Un medico di campagna, cioè, a dire, alcuni dei più sconvolgenti racconti del secolo), il giornale locale che riportava le liste degli ospiti arrivati in città (allora usava così) non lo classificò certo come signor Franz Kafka scrittore o letterato o homme de plume, bensì impiegato (Beamter, in tedesco).
Kafka arrivò ai primi di aprile perché la stagione turistica (o di cura) andava dalla primavera all’inizio dell’estate, e infatti Kafka rimase a Merano fino alla fine di giugno. L’estate veniva saltata. Non rientrava nella stagione. E gli alberghi riaprivano d’autunno. Tuttora a Merano il periodo d’oro è ottobre, quando si fa la cosiddetta cura dell’uva. Come si vede la città ha a che fare non tanto con lo svago o il divertimento o il relax, quanto piuttosto con la salute minacciata, il ristabilimento di uno stato psicofisico compromesso eccetera. Del resto Merano era nota fin dall’Ottocento come Luftkurort, cioè traducendo in modo approssimativo: luogo dall’aria curativa.
Orbene Kafka scese al famoso Hotel Emma (che ora, dopo un irreparabile declino, è diventato una scuola, sì, una scuola, e lo splendido salone affrescato dove nobili di mezza Europa fumavano il sigaro o degustavano una flûte di champagne è adesso, tremo nel dirlo, un’aula magna, per quanto magnifica, dove anch’io, sospirando su come cambia il mondo, ho partecipato occasionalmente ad alcune interminabili assemblee sindacali, piene di professori incazzati sotto gli affreschi delle volte). Ma non gli piaceva. O forse, più probabilmente, era troppo caro. Kafka, è noto, era piuttosto oculato o, come dicevano i suoi colleghi d’ufficio, un micidiale taccagno. Quindi si cercò un’altra sistemazione. Dopo pochi giorni l’aveva trovata. Si trattava della Pensione Ottoburg. Una modesta pensioncina che l’aveva subito affascinato per il suo aspetto funerario, da tomba di famiglia, anzi, da «fossa comune».
E qui si vede come l’occhio infallibile di Kafka abbia individuato subito quell’insopprimibile aura mortuaria che Merano possedeva e che ancor oggi possiede. Altro che città mediterranea! Altro che luogo del Nord baciato dal sole caldo del Sud, e tutte le altre melensaggini insipide di guide e dépliant. Al di là della maschera c’è un insistente, ineliminabile alito di morte, che spira per Merano. Per me, e per molti altri, credo, ragione di fascino profondo. Profondamente e soavemente malinconico. (A conferma di ciò invito tutti i turisti e visitatori a soffermarsi sulla facciata dell’Hotel Steigenberger, che dal 2005, assieme all’edificio delle nuove Terme, ha letteralmente cambiato il volto della città, almeno in quella sua parte che si stende dal palazzo delle Poste al glorioso Hotel Meranerhof, e cioè una buona porzione del centro; i suddetti visitatori e turisti potranno vedere quanto da vicino lo Steigenberger ricordi la struttura di un columbarium romano, ossia di quella costruzione che, con tutti i suoi vuoti seriali, era fatta apposta per ospitare le urne cinerarie. L’architetto o gli architetti di questo hotel sono stati, non so se consapevolmente o meno, ispirati dal genio – cimiteriale – del luogo.)
La Pensione Ottoburg era non solo decisamente più economica e familiare, ma anche decentrata rispetto all’Emma e a tutti gli altri hotel sfarzosi che sorgevano nei pressi della stazione di Merano, nessuno dei quali oggi è sopravvissuto, in quanto hotel. Essa si trovava a Maia Bassa (Untermais), oggi popoloso e popolare quartiere meranese, il primo che si attraversa giungendo da sud, allora addirittura comune autonomo, e tale fino al 1924. Anche l’Ottoburg non è più albergo, ma semplice condominio, dal 1990. Così come è diventato condominio l’Hotel Scandinavia, che sta proprio di fronte all’Ottoburg. E più o meno negli stessi anni. Lo cito solo perché lo Scandinavia fu nell’immediato secondo dopoguerra la sede dell’oss. Chissà se qualche agente del servizio segreto americano sapeva che nella bianca pensioncina di fronte aveva abitato Kafka. Probabilmente non era questo il genere d’informazioni a cui tenevano quegli agenti.
Negli ultimi tempi, prima di essere ristrutturato e trasformato in condominio, quindi nell’ultimo periodo della sua esistenza da pensione, l’Ottoburg ospitò gruppi di cinesi, i primi cinesi di Merano, che gestivano il primo ristorante cinese della solare cittadina. A Kafka, che ha scritto le meravigliose pagine della Costruzione della muraglia cinese, frammento d’un romanzo incompiuto, ciò non sarebbe affatto dispiaciuto, credo.
Tutti sanno che dalla stanza a pianterreno di quell’alberghetto sono partite le prime lettere del nutrito carteggio con Milena, quella che viene pudicamente definita l’amica di Kafka. Ma in effetti di Merano non è che dica molto, Kafka, nelle lettere a Milena. Dice di più in quelle a Max Brod, o in quelle alla sorella Ottla. In queste ultime parla tra l’altro di una panchina sul Passirio in cui andava a cercare refrigerio nelle torride giornate di giugno. Sarà stata così calda la tarda primavera del ’20, a Merano? E qual era questa panchina sul fiume, che ospitò regolarmente l’ossuto deretano di Kafka? Impossibile ricostruirlo: sono troppe le panchine sul Passirio dove anche oggi i turisti cercano la frescura dell’acqua, sporgendo i piedi nudi dai parapetti giù verso la corrente impetuosa e spumeggiante del fiume (cedo anch’io all’aggettivazione prediletta dalle guide).
La lettera decisiva su Merano è però a mio parere una di quelle che non vengono mai o quasi mai citate. Et pour cause! In questa lettera a Minze Eisner del luglio 1920 Kafka scrive nero su bianco, papale papale: «Dal punto di vista della salute Merano non mi è servita a niente». Sperava di guarire o almeno di migliorare, invece è un po’ peggiorato.
Inoltre mi sono sempre chiesto l’esatto significato della locuzione «i piombi di Merano» («piombi» nel suo senso carcerario, Bleikammer, in tedesco) che ricorre alcune volte, questa sì, nel carteggio con Milena. Qualunque sia non mi pare possa essere molto positiva.
Un altro scrittore, poeta per la precisione, che ha legato il suo nome a Merano, anche perché vi è proprio morto (anche lui a Maia Bassa veramente), nel 1914, giusto un paio di mesi prima dello scoppio delle guerra, è Christian Morgenstern, certo meno noto di Kafka, e non solo al pubblico italiano.
Naturalmente era tisico anche lui. Anche lui voleva guarire a Merano. Ma non ci è riuscito. Però almeno ha trovato l’amore, a Merano. Un amore chiamato Margareta. Il nome era semplice, il cognome invece altisonante e intimidente: Gosebruch von Liechtenstein. Si sposarono, nella ridente cittadina, nel 1910.
Morgenstern era un poeta, l’ho detto, anzi erano due, due poeti. Uno amante del grottesco, del paradosso, predadaista e presurrealista. Che descrisse un ginocchio che vagava solo per il mondo. Che teorizzò l’esistenza dell’ermellino estetico e del pecoro lunare. Che cantò il canto notturno dei pesci, un canto muto, fatto solo dei segni grafici con cui si segnano, nello studio delle lingue classiche, le sillabe lunghe e le sillabe brevi. Insomma: un genio. Ma, accanto a questo visionario prefiguratore di avanguardie future, c’era, che conviveva con lui, in lui, un poeta completamente diverso, che si commuoveva davanti ai monti azzurrini, alle palme a ventaglio agitate dalla brezza, alla neve che si scioglie e che alla sera scende dai monti suddetti (azzurrini) calzando lievi «scarpette di velluto»... Un po’ come se uno scultore producesse a giorni alterni opere alla Alexander Calder e opere alla Vincenzo Gemito.
Non so come, ma la fase «Gemito» si infittì man mano che Morgenstern si avvicinava alla morte. E guarda caso più si avvicinava alla morte, più stava a Merano, dove poi come andò a finire lo sappiamo.
La casa in cui Morgenstern si spense, in via Winkel, da abitazione privata è diventata col tempo un bed&breakfast. Cioè ha conosciuto il destino inverso rispetto alla pensione di Kafka. Su entrambi gli edifici, comunque, una lapide ricorda il soggiorno dei due scrittori. Bilingue per Kafka, monolingue per Morgenstern, come a sancire lo scarso successo di quest’ultimo presso il pubblico italiano. Chi invece è privo di lapide, che ne ricordi il soggiorno meranese del 1952, all’Hotel Westend, tuttora esistente e tuttora hotel, è Gottfried Benn. Il grande poeta berlinese che pure dedicò una bellissima poesia a Merano, che parla di forsizie precoci. Come mai senza lapide? Forse per i suoi trascorsi nazisti. Forse per semplice dimenticanza.
Del resto non c’è una lapide nemmeno per Ezra Pound, che visse per ben due anni a Tirolo, nello splendido Castel Fontana (Brunnenburg), da cui si domina Merano e la valle dell’Adige. Provvede a mantenerne viva la memoria la figlia, che vive tuttora nel castello. Pound, che veniva da dodici anni di manicomio criminale, si dev’essere trovato piuttosto bene in Alto Adige, per trattenervisi così a lungo. Non so se le due circostanze abbiano un rapporto di correlazione. Poi però si stufò anche lui, preferì trasferirsi a Rapallo e, da ultimo, a Venezia, dove è sepolto.
Per citare un autore italiano, adesso, è risaputo che Alberto Moravia passò periodi a Merano e, soprattutto, a Bressanone, a metà degli anni Venti. Il famoso «Entrò Carla», l’incipit degli Indifferenti, fu scritto proprio a Bressanone, ma non so esattamente dove, se nel sanatorio o in un albergo o in un’abitazione privata. Moravia, è altrettanto risaputo, soffriva di tubercolosi ossea, a conferma del nesso soggiorno in Alto Adige-malattia. A Merano acquistò, in una libreria internazionale, alcuni volumi della Recherche di Proust; scoprì Proust non a Roma, a Cortina o chissadove, ma a Merano! La sconvolgente rivelazione sta in uno dei libri-intervista di Moravia, non so se in quello di Siciliano o in quello di Elkann (forse in tutt’e due).
L’elenco degli scrittori in Alto Adige potrebbe, realmente, continuare a lungo. Perché da queste parti sono passati Rilke e Schnitzler o, allargando il raggio d’osservazione a personalità non solo letterarie, Freud (al Renon, sopra Bolzano), Mahler (a Dobbiaco), e poi, tornando agli italiani, Grazia Deledda, Luigi Bartolini, e Pasolini.
Solo un momento vorrei soffermarmi sullo stranoto poeta-romanziere-regista-polemista-saggista-eccetera, diventato Santo (Sant’Infame, come avrebbe voluto lui), Santo subito, già poche ore dopo l’orrenda e famigerata notte tra il pr...