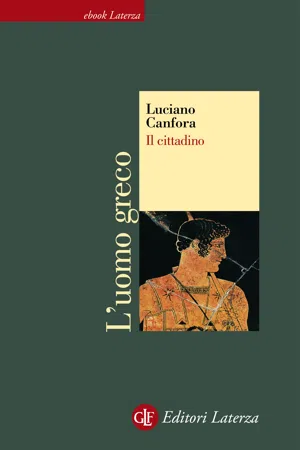Il cittadino
Introduzione
Nel VI secolo a.C., in molte città greche, le aristocrazie, sostenute dalle armi spartane, scacciarono i cosiddetti tiranni e assunsero il controllo della politica cittadina.
Le tirannidi, a quel che ci è dato di capire, avevano per lo più una base popolare: il tiranno era stato all’origine un demagogo. Nondimeno nella tradizione letterario-politica giunta sino a noi, l’immagine della tirannide si è definitivamente connotata come un valore negativo e si è addirittura venuta a confondere con la nozione di dominio oligarchico (come vedremo meglio nel seguito).
Epicentro e prototipo delle aristocrazie greche fu, com’è noto, Sparta. Qui la nozione di élite (gli Spartiati) coincide con la nozione stessa di liberi, e quindi di cittadini a pieno titolo (cfr. qui di seguito pp. 117 sgg.). Il dominio di questa aristocrazia perfetta, dedita in primo luogo alla virtù della guerra, si poggia su un cospicuo basamento di ceti dipendenti (perieci, iloti). La polarità liberi/schiavi coincide quindi, a Sparta, con la polarità élite/masse. Tra i due «mondi» (gli Spartiati, gli altri) vi è una durevole tensione di classe e di razza, che viene sentita e vissuta come una vera e propria guerra: simbolicamente, ma non troppo, gli efori spartani «dichiarano guerra» ogni anno agli iloti, e giovani spartiati fanno il loro tirocinio come guerrieri dedicandosi allo sport della caccia notturna agli iloti, la cui uccisione ha anche – oltre al voluto effetto terroristico – un evidente significato rituale e sacrificale. Il cittadino, lo spartiata, il maschio, deve imparare innanzi tutto a uccidere.
Ha osservato una volta A.H.M. Jones che gli aristocratici ateniesi, pur manifestando continua ammirazione per il sistema spartano (basti ricordare il nome di Crizia, ma anche quello di suo nipote Platone), difficilmente si sarebbero adattati a una comunità così chiusa e spiritualmente sterile. Il primo testo superstite in prosa attica, la Costituzione degli Ateniesi tramandata tra gli opuscoli di Senofonte (ma certo non da lui scritta), apre, per così dire, questa serie di tributi all’ideale spartano. L’autore rimpiange, ad esempio, il duro trattamento che si può infliggere agli schiavi a Sparta, così come auspica un regime politico, l’eunomia («il buon governo»), in cui il popolo ignorante e incompetente e dunque non legittimato a detenere il potere sia «ridotto in schiavitù».
Eppure in Atene questa idealità, così cara a una aristocrazia tutt’altro che rassegnata e disarmata, non ha mai avuto concreta realizzazione. O meglio l’ha avuta, e fallimentare, nei due brevissimi periodi del 411 e del 404-403, allorché le sconfitte militari subite da Atene nel lungo conflitto con Sparta parvero rendere attuale la possibilità di instaurare anche ad Atene il «modello Sparta». Perché questo fallimento, se davvero può parlarsi di fallimento? Proprio l’autore della Costituzione degli Ateniesi, pur mettendo in luce il principale difetto della democrazia (l’accesso degli incompetenti alle cariche pubbliche), riconosce nondimeno che in Atene il popolo lascia ai «signori» le più delicate cariche militari. L’aristocrazia ateniese, in realtà, si è adattata, come vedremo (pp. 122 sgg.), a un sistema politico aperto – la democrazia assembleare – che ha posto su nuove basi il problema capitale della cittadinanza.
Questa aristocrazia aveva dunque serbato, pur in una vicenda politica più mossa che a Sparta, una legittimazione a dirigere lo Stato, fondata sul possesso di determinate competenze (non solo belliche) e sulla durevole prevalenza dei propri valori, sancita anche dal linguaggio politico: sophrosyne, oltre che «saggezza», vuol dire appunto «governo oligarchico» (Tucidide, 8, 64, 5).
Nell’Europa del Settecento, fino alla Rivoluzione francese e oltre, era usuale l’accostamento Roma-Sparta. Non era del tutto infondato. Già Polibio se lo era prospettato in termini di comparazione costituzionale, e aveva ravvisato nel sistema politico romano un perfezionato equilibrio tra i poteri (cfr. pp. 133 sgg.). Egli non si nascondeva peraltro che perno di tale equilibrio era un’aristocrazia, coincidente con l’organo stesso (il Senato) attraverso cui essa esercitava il potere.
Non senza motivo sarà dunque appunto l’aristocrazia la protagonista dell’esperienza politica di cui si discorre nelle pagine seguenti. Se si volesse racchiudere in una formula la caratteristica di un così durevole predominio, se ne potrebbe indicare la causa nella capacità di rinnovarsi e di cooptare. E su questo terreno è proprio l’aristocrazia modello, quella spartana, quella che ha dimostrato, alla prova dei fatti, la minore lungimiranza.
I Greci e gli altri
«Le città non erano grandi, e il popolo abitava nel contado, interamente preso dai lavori agricoli»: è il quadro economico-sociale in cui Aristotele colloca il formarsi delle tirannidi, nel quinto libro della Politica (1305a 18). «Data la grandezza della città, non tutti i cittadini si conoscevano tra loro»: è uno dei fattori materiali che Tucidide chiama in causa per spiegare il clima di sospetti e la difficoltà di rapporti creatisi in Atene nei giorni di incubazione del colpo di Stato oligarchico del 411 a.C. (8, 66, 3). La città arcaica è piccola; questo rende la democrazia diretta, cioè la partecipazione di tutti i «cittadini» alle decisioni, un esito obbligato. Un esito che non è possibile contrastare, soprattutto da quando una parte sempre crescente di «cittadini» (o aspiranti tali) converge verso l’agorà e non rimane più inchiodata in campagna, assorbita completamente dal lavoro agricolo. Finché la situazione è quella descritta da Aristotele («il popolo abitava nel contado, interamente preso dai lavori agricoli»), lo scontro per il potere è dominio di alcuni «signori». Tali signori hanno il privilegio di portare le armi ed esercitano appunto così la loro egemonia: un privilegio che possiamo concretamente osservare nei corredi funerari delle tombe attiche (nelle antiche tombe dei demi di Afidna, Torico, Eleusi i nobili sono sepolti con le armi, i popolani ne sono privi). La σιδηροψορία, l’uso barbarico di andare in giro armati, «è un segno di nobiltà – scrisse Gustave Glotz – che segue l’aristocratico sin nella tomba».
In questa fase arcaica le forme di governo determinate dall’alternarsi al potere dei signori – aristocrazia, tirannide, «interregno» di un «mediatore» (aisymnetes, diallaktès) –, sebbene indicate con denominazioni differenti, dovute spesso al punto di vista di chi scrive, sono in realtà ben poco distinguibili. Basti pensare alle vicende della Lesbo di Alceo, e a figure come quella di Pittaco, diallaktès nella furiosa zuffa tra clan aristocratici ma che da Alceo viene bollato come «tiranno» sebbene sia poi assurto addirittura nell’empireo dei «sette sapienti» insieme al suo omologo ateniese Solone. Coloro che Alceo e gli altri come lui bollavano come «tiranni» erano – secondo Aristotele – coloro che si assumevano la «guida del popolo» (prostatai tou demou). Essi godevano – scrive Aristotele nel brano citato prima – della fiducia del popolo, e il «pegno» (pistis) di questa fiducia era «l’odio contro i ricchi»: odio che – spiega Aristotele – prendeva corpo ad esempio nel massacro del bestiame dei ricchi, sorpreso presso il fiume dal «tiranno» Teagene di Megara, uomo di fiducia del popolo. Tale del resto era anche Pisistrato, che Aristotele nomina nello stesso contesto.
Ma la paralizzante fatica nei campi (ἀσχολία) a un certo momento cessò di essere tale: gentaglia che un tempo non conosceva né giustizia né legge – lamenta Teognide (circa 540 a.C.) – e portava pelli di capra intorno ai fianchi, ora affluisce in città e conta più degli stessi nobili, ridotti in condizione di miserabili. Prima – nota con rimpianto Teognide – quella gentaglia viveva fuori della città, o meglio, secondo la sprezzante espressione teognidea, «pascolava» fuori della città. Ora sono entrati, e la faccia della città è cambiata (1, 53-56). È evidente che la spinta alla gestione diretta della comunità, la democrazia diretta, nasce appunto allora, con il crescente gravitare di popolani dentro la cerchia urbana: attenuarsi della ascholìa e spinta democratica vanno di pari passo. Il fenomeno è reso possibile dal fatto che la comunità è piccola, e l’alternativa al potere personale è, per così dire, a portata di mano. Non c’è dunque da favoleggiare di una innata spinta dei Greci verso la politica,...