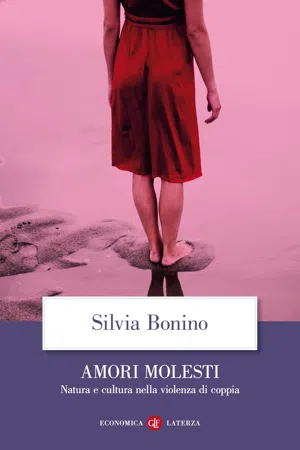1.
Né bruti né angeli
1.1. Il cervello uno e trino
Gli umani sono degli esseri del tutto particolari. Come appare evidente a qualunque osservatore senza pregiudizi, essi (in quanto mammiferi) presentano aspetti che li apparentano a molti altri animali. Chiunque abbia in casa un gatto o un cane è costretto a riconoscere che condividiamo con essi non solo le stesse funzioni fisiologiche di base – dalla respirazione all’assimilazione del cibo – ma anche, se pure in forma diversa, alcuni stati emotivi: ad esempio la rabbia, la paura e la contentezza, così come il piacere per le carezze e il desiderio di contatto fisico. D’altro canto è però altrettanto evidente che gli esseri umani hanno particolarità specialissime, che li fanno unici e diversi da tutti gli altri animali, anche da quelli a noi più prossimi, come i primati. Queste similarità e differenze possono essere comprese solo se vengono inquadrate nella lunga e meravigliosa avventura della vita e del suo sviluppo sulla Terra: un cammino che ha avuto origine miliardi di anni fa e di cui rimane memoria nel nostro patrimonio genetico.
È stato calcolato a questo riguardo che noi condividiamo una parte considerevole del patrimonio genetico con gli altri esseri viventi, piante comprese, in quantità variabili a seconda della specie. Queste percentuali di condivisione ci ricordano l’unità della vita e i nostri legami con tutti gli esseri con cui coabitiamo sul pianeta azzurro, la nostra casa comune, in un equilibrio fragile e oggi messo a dura prova. Con i primati, che sono i mammiferi a noi più vicini, la percentuale di condivisione è altissima; nello specifico, rispetto agli scimpanzé, la stima è del 98%. Questo valore è impressionante e va sottolineato, per non dimenticare la comune appartenenza alla stessa linea evolutiva sul piano filogenetico: che ci piaccia o no, abbiamo in comune gli stessi antenati. Ma ancor più impressionanti sono le differenze che noi esseri umani presentiamo rispetto a questi nostri parenti stretti: benché la percentuale di specificità umana sul piano biologico sia piccolissima, essa diventa enorme sul piano delle potenzialità cognitive, emotive e sociali. Gli esseri umani presentano infatti capacità del tutto particolari, che non si ritrovano nelle altre specie animali; queste fanno di noi animali culturali, capaci di pensiero, ragionamento, trasmissione degli apprendimenti, ma anche altruismo e cooperazione.
La similarità con gli altri esseri viventi, e nello stesso tempo la straordinaria specificità degli esseri umani, sono qualcosa di cui tutti noi possiamo renderci conto nella vita quotidiana: uomini e donne mescolano riflessioni profonde con comportamenti irrazionali, invenzioni tecnologiche con impulsività emotiva, altruismo e cooperazione con aggressione e sopraffazione. Per comprendere la complessità dell’essere umano e del suo comportamento, con tutta la sua ricchezza ma anche con le sue contraddizioni a volte sconcertanti, dobbiamo partire dall’analisi delle caratteristiche del nostro cervello. Benché quest’organo rimanga ancora oggi tra i più sconosciuti del nostro corpo, molte conoscenze si sono meglio precisate e consolidate negli ultimi decenni, grazie all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici. Partiamo perciò dall’analisi delle caratteristiche del cervello umano, così come si sono stratificate nel corso dell’evoluzione filogenetica, cioè di quel lungo cammino evolutivo della vita animale che ha portato alla comparsa della specie umana. Il lettore non si spaventi e resista alla tentazione di saltare ai capitoli seguenti o, peggio, di abbandonare il libro: non entreremo in analisi anatomiche o neurofisiologiche particolareggiate, ma descriveremo solo gli aspetti essenziali, utili per capire sia il funzionamento psichico in generale sia i temi specifici che sono oggetto di questo libro.
Il cervello umano è stato descritto fin dagli anni Settanta del secolo scorso da Paul D. MacLean come costituito da tre livelli, corrispondenti a tre piani di progressione filogenetica. Per questo si parla di cervello trino, o meglio ancora di cervello allo stesso tempo uno – per la globalità del suo funzionamento – e tripartito. Come sottolinea lo psicobiologo Jaak Panksepp, tra gli studiosi che più hanno contributo negli ultimi decenni alla comprensione dei sistemi motivazionali e dei circuiti emotivi nel cervello, la descrizione dei tre livelli è per molti aspetti una semplificazione didattica, che non è esauriente e non va presa alla lettera, soprattutto riguardo alle diverse strutture anatomiche che ne fanno parte. Non si deve quindi immaginare il cervello umano come diviso nettamente in tre parti, ciascuna con dei compiti specifici: una simile rappresentazione non rende ragione né dell’articolazione anatomica né di quella funzionale del cervello. Nonostante ciò, la descrizione dei tre livelli rimane anche oggi utile, poiché illustra bene la complessità del cervello umano e la sua evoluzione lungo la filogenesi. Infatti i tre strati riflettono la progressione dello sviluppo cerebrale nei vertebrati e nei mammiferi, dove a lunghi periodi di stabilità sono seguiti periodi di rapida espansione. Questa evoluzione non riguarda la struttura e il funzionamento dei singoli neuroni, che non hanno speciali proprietà negli esseri umani. Sono invece diversissimi il numero dei neuroni (stimato in circa 90 miliardi) e soprattutto l’ampiezza e complessità dei collegamenti tra i neuroni, attraverso le sinapsi (stimate in una cifra astronomica: tra 1013 e 1015), e tra le varie parti del cervello umano. Vediamo allora più approfonditamente i tre cervelli che coesistono nel nostro sistema nervoso centrale e le loro principali funzioni.
Il cervello più antico è quello rettiliano, che presiede alla regolazione delle funzioni vegetative (come respirazione e temperatura) e alle azioni più primitive, legate alla sopravvivenza dell’individuo e alla riproduzione della specie (tra le sue strutture anatomiche ricordiamo il tronco dell’encefalo e l’ipotalamo). A partire dalla percezione dell’ambiente esterno, il cervello rettiliano regola le attività che riguardano la conservazione di sé e della specie (come alimentazione, ciclo veglia-sonno, esplorazione, attacco, fuga ed eccitazione sessuale, in relazione alle differenti funzioni riproduttive di maschi e femmine) e attua piani innati d’azione.
Il secondo cervello è quello dei mammiferi primitivi, denominato più comunemente cervello emotivo o limbico (tra le sue strutture ricordiamo l’amigdala, l’ippocampo e il talamo). Oltre a modulare gli schemi d’azione del cervello rettiliano, il cervello limbico presiede alle emozioni fondamentali (come paura, rabbia, gioia, tristezza), che comportano specifici vissuti soggettivi e impulsi a reagire agli eventi del mondo esterno, sulla base di risposte somatiche e viscerali. Inoltre, esso è coinvolto nelle emozioni che riguardano relazioni sociali più evolute e complesse, come le cure materne e la stessa sessualità, i legami individualizzati, la gregarietà, il gioco.
Il terzo cervello è la neocorteccia, o cervello dei neomammiferi, nei quali presiede agli apprendimenti e al controllo dell’azione, modulando le emozioni e le risposte adattive con maggiore flessibilità in relazione agli eventi ambientali. Alcune parti della neocorteccia, definite paralimbiche per il loro stretto collegamento con le strutture limbiche, governano le emozioni complesse (come vergogna, colpa, orgoglio) legate alla vita sociale, particolarmente ricca ed evoluta nell’essere umano. La neocorteccia ha nella specie umana il massimo sviluppo e presenta un enorme aumento della connettività, con la costruzione di una complessa rete di scambio di informazioni tra le varie aree corticali. In questo modo diventano possibili funzioni cognitive specifiche, definite superiori: pensiero, linguaggio, narrazione, costruzione di valori, pianificazione e perseguimento di mete complesse, autocoscienza, autodeterminazione. La neocorteccia è, insomma, il cervello che ha reso possibili nella specie umana la cultura, l’educazione, l’arte, il mito, la religione e infine la scienza. Negli esseri umani questo cervello recente è fortemente immaturo alla nascita, quando si presenta ridotto sia per volume sia per complessità di funzionamento, e si sviluppa gradualmente fino all’adolescenza. È questa la soluzione che la natura ha trovato all’impossibilità di partorire un neonato con un cervello enorme, in un essere che cammina eretto su due gambe e ha di conseguenza un bacino relativamente piccolo: fare nascere un cucciolo molto immaturo, con un lungo periodo di sviluppo dopo la nascita, in una sorta di incubazione esterna. Come conseguenza, il piccolo dell’uomo, in misura molto maggiore degli altri primati, dovrà dipendere per molti anni dai genitori prima di raggiungere la maturità sessuale e la capacità di riprodursi, così come di ragionare da adulto e saper provvedere a se stesso in modo autonomo. Come vedremo, l’esistenza di questo lungo periodo di immaturità e dipendenza ha conseguenze importanti per i temi che stiamo trattando. La prolungata infanzia degli esseri umani, la più lunga in assoluto nel regno animale, si spiega dunque con la necessità di portare a maturazione la neocorteccia. Nel contempo, essa è anche un periodo di massima plasticità neuronale, nel quale l’esperienza, gli apprendimenti e l’educazione lasciano un segno decisivo nel cervello e nella mente. Il periodo fino alla prima giovinezza è il più duttile e sensibile alle influenze ambientali, ma l’essere umano rimane plastico e per molti aspetti infantile anche da adulto, come testimoniano la curiosità, l’attitudine al gioco e la possibilità di continuare a imparare.
I tre livelli di progressione filogenetica, spesso denominati per semplicità “tre cervelli”, convivono nel nostro sistema nervoso centrale e sono tra loro strettamente collegati e comunicanti: per questo il cervello è stato definito allo stesso tempo uno e trino. Essi comunicano sia nella duplice direzione “dal basso verso l’alto” e “dall’alto verso il basso”, sia al loro interno, in orizzontale. Si realizza così un’interazione continua di reciproca influenza, dove i livelli più arcaici influenzano quelli filogeneticamente più recenti e viceversa. Ad esempio, nel comportamento sessuale sono coinvolte sia le parti più antiche del cervello rettiliano (come la produzione ormonale) e di quello limbico (come i circuiti emotivi del piacere), sia quelle più recenti della neocorteccia (come le preferenze soggettive), con reciproche interazioni.
Ne deriva che globalmente il cervello è un sistema gerarchico molto interconnesso con funzioni superiori e inferiori, che possono operare sia in sinergia che autonomamente: i tre livelli evolutivi del cervello non sono entità separate, benché siano capaci di funzionare in qualche modo anche indipendentemente. Mentre le strutture più antiche sono chiuse, rigide e stereotipate, e rispondono agli stimoli ambientali con reazioni automatiche e precostituite, quelle superiori della neocorteccia sono più aperte e flessibili, e non sono più vincolate a schematismi e riflessi predeterminati a livello filogenetico. La neocorteccia introduce quindi maggiori gradi di libertà. Questa libertà non è infinita, sia perché le strutture filogeneticamente più antiche continuano a esercitare la loro influenza, sia perché i nuovi apprendimenti indotti dalla cultura e dall’esperienza lasciano una traccia biologica in un cervello che ha specifici limiti e precise modalità di funzionamento. Di conseguenza, l’azione degli esseri umani sull’ambiente fisico e sociale, così come su se stessi, presenta ampi spazi di manovra, ma non è di certo onnipotente, poiché resta sempre fortemente limitata dai vincoli intrinseci della specie. In pratica, ciò significa che le capacità che emergono dalla neocorteccia – in particolare il pensiero, il ragionamento e la riflessione su di sé – consentono a ogni essere umano di intervenire con maggiore flessibilità sul proprio comportamento, sottraendolo in parte agli automatismi biologici provenienti dal cervello rettiliano e da quello emotivo.
Il cervello umano presenta alcune differenze morfologiche e di funzionamento tra maschi e femmine, benché molto minori che nelle altre specie di mammiferi. Il cervello maschile è in media più voluminoso – anche tenendo conto delle differenze di corporatura – e questo aveva fatto erroneamente concludere agli studiosi dell’Ottocento che gli uomini fossero più intelligenti. Si ritiene oggi che le differenze riguardino alcune strutture del cervello, dove negli uomini sono maggiormente sviluppate quelle implicate nell’orientamento spaziale. La differenza più evidente riguarda la maggiore interconnessione tra gli emisferi destro e sinistro nel cervello femminile, che risultano quindi coordinati in modo migliore. Inoltre i due emisferi presentano nelle donne minore asimmetria: le aree del linguaggio, in particolare, non sono confinate nel cervello sinistro, come negli uomini, ma sono maggiormente presenti anche nel destro. Le ricerche mostrano, in generale, che nelle donne la dimensione verbale prevale anche di fronte a stimoli sessuali ed emotivi. Ugualmente, nelle decisioni il loro stile cognitivo è maggiormente fondato sulle abilità linguistiche, mentre negli uomini prevale una valutazione basata su capacità analogiche e d’insieme. Riguardo alla sessualità, la produzione degli ormoni sessuali è diversa in relazione al differente ruolo riproduttivo, con un meccanismo ciclico mensile nelle femmine e continuo nei maschi. Le due modalità sono pilotate dall’ipofisi, a sua volta controllata dall’ipotalamo, che stimola le gonadi a produrre ormoni femminili (estrogeni, progesterone) o maschili (testosterone). Sempre l’ipotalamo presiede a una maggiore secrezione di arginina-vasopressina nei maschi e di ossitocina nelle femmine (cfr. cap. 2); inoltre, alcune aree dell’ipotalamo connesse ai comportamenti sessuali sono più voluminose nei maschi. È oggetto di discussione se questa diversa organizzazione, che si compie nella vita fetale sotto l’effetto degli ormoni materni, possa essere alla base anche dell’orientamento sessuale e delle differenze di ruolo.
1.2. Gli esseri umani tra biologia e cultura
Vediamo ora più da vicino quali sono le specifiche capacità cognitive umane rese possibili dal particolare sviluppo della neocorteccia nella nostra specie. Ci baseremo sulla descrizione fatta da Jean Piaget, il grande studioso dell’età evolutiva che ha delineato con chiarezza e precisione, ancora oggi esemplari, l’emergere dell’intelligenza e del pensiero nel bambino: uno sviluppo che chiunque abbia a che fare con bambini piccoli può osservare personalmente, se li guarda con occhio attento. In sintesi, ciò che differenzia noi esseri umani è la capacità di costruire un’immagine mentale della realtà esterna anche quando questa non cade direttamente sotto i nostri sensi (vista, udito, ecc.), e di lavorare mentalmente su di essa. La mente umana va ben oltre il rispecchiamento della realtà esterna che avviene con la percezione; per quanto complessa, quest’attività mentale richiede sempre la presenza di un oggetto nel mondo al di fuori di noi, che viene percepito dai nostri sensi. La nostra mente ha la capacità di superare la percezione immediata degli oggetti esterni, per rispecchiare mentalmente e immaginarsi realtà che sono state percepite ma non sono più presenti, o addirittura realtà del tutto inesistenti o astratte, che mai cadranno visibilmente sotto i nostri sensi. Questa capacità di rappresentazione mentale, come Piaget l’ha definita, non è presente nel neonato, ma diventa evidente intorno ai due anni in tutti i bambini della specie umana, e solo in essi, purché abbiano un normale sviluppo neurofisiologico e relazionale. Intorno ai due anni compare insomma il pensiero, che non è ancora presente prima, quando l’intelligenza del piccolo è senso-motoria (o percettivo-motoria), vale a dire vincolata alla percezione della realtà e alla sua manipolazione. In concreto, la capacità di rappresentazione mentale si manifesta con alcuni precisi comportamenti, facilmente osservabili nei bambini intorno ai 18-24 mesi: l’imitazione differita (ad esempio, imitare il miagolio del gatto visto il giorno prima), il gioco simbolico (rincorrere una palla facendo finta che sia un gatto) e il linguaggio (usare il segno convenzionale che nella propria lingua materna indica il gatto). Seguiranno poi la capacità di lasciare un segno grafico cui viene attribuito un significato (ad esempio, uno scarabocchio è identificato con il gatto) e l’invenzione fantastica (immaginarsi un gatto con gli stivali).
La rappresentazione mentale permette di usare dei simboli per indicare una certa realtà, e per questo la nostra è stata definita una “specie simbolica”. Questi simboli possono essere personali, come avviene nel gioco infantile del fare finta, dove una scatola può essere usata come se fosse una casa e subito dopo come un’automobile, senza peraltro mai perdere consapevolezza della sua realtà concreta. I simboli possono però anche essere convenzionali e specifici di una certa cultura. Essi possono, in altri termini, avere un significato condiviso, come avviene nel linguaggio; in esso un certo segno fonetico – e poi grafico – sta ad indicare una determinata realtà in una certa lingua (ad esempio, la parola casa sta a significare sia la casa reale sia i vissuti a essa legati). Con questi simboli gli esseri umani diventano capaci di sviluppare concetti (ad esempio, l’idea di casa) e in seguito, a partire grosso modo dai sei anni, di compiere operazioni mentali sempre più complesse ma ancora vincolate alla realtà concreta. In seguito diventano capaci di ragionamenti sempre più astratti, grazie allo sviluppo del pensiero formale o ipotetico-deduttivo, caratteristico della scienza. In un normale sviluppo neurofisiologico la capacità di ragionamento astratto e deduttivo diventa possibile in adolescenza, ma la sua piena realizzazione dipende fortemente dall’uso della lingua scritta e dalla scolarizzazione. Di conseguenza questo tipo di ragionamento può non essere pienamente padroneggiato da chi ha una bassa scolarità e ancor più da chi appartiene a una cultura che non ha sviluppato la lingua scritta.
Gli studiosi ritengono oggi che la comparsa di queste peculiari capacità cognitive sia avvenuta, nel corso dello sviluppo della specie umana, sotto la spinta delle esigenze di adattamento poste non dall’ambiente fisico ma dalla vita sociale. Quest’ultima si presentava particolarmente ricca in un essere che aveva conquistato la stazione eretta e liberato le mani, ed era sempre più impegnato all’interno della famiglia e del gruppo in scambi molto articolati, indispensabili per la sua sopravvivenza. È per risolvere i compiti adattivi posti dalla complessità della vita sociale che si è sviluppata negli esseri umani un’intelligenza particolare, non più limitata alla percezione della realtà e alla sua diretta manipolazione. La vita sociale imponeva, infatti, di saper cooperare ma anche difendersi dalle manipolazioni altrui, di convincere così come di dissimulare, di aiutare gli altri e di trovare soluzioni pacifiche e durature ai conflitti. Mentre l’intelligenza raggiunta dai primati restava sufficiente per affrontare e superare i problemi di adattamento posti dall’ambiente fisico (ad esempio, la ricerca del cibo), essa si rivelava insufficiente per la vita di relazione. Per una buona vita sociale era infatti indispensabile riuscire a rappresentarsi mentalmente ciò che passava nella mente dei propri simili, cosa che non era sempre deducibile con chiarezza dalla loro pur ricca espressività. Era insomma indispensabile sapersi immaginare ciò che non era visibile, perché stava dentro la mente altrui: in concreto, saper pensare ciò che gli altri pensano e vivono. Questa capacità serviva a scopi diversi: ingannare o persuadere meglio, ma anche aiutare in modo efficace e cooperare insieme per un obiettivo comune, utile per la famiglia e il gruppo, da cui la stessa sopravvivenza di ogni individuo dipendeva. La mente umana emerge quindi nell’evoluzione biologica in relazione alla complessità della vita sociale e per questo è così strettamente connessa al linguaggio. Ciò significa che alla base del nostro sviluppo cognitivo, e delle nostre uniche capacità mentali, vi è la nostra intrinseca socialità. È questo il tratto primario caratteristico della specie umana: una socialità profonda, che si evidenzia non solo nella capacità di stabilire fin dalla nascita intense relazioni di attaccamento e di affetto, ma anche di realizzare con i propri simili una ricca gamma di comportamenti sociali positivi, come l’empatia, l’aiuto, la cooperazione. Secondo molti antropologi è proprio questa ricca socialità, e non solo la maggiore capacità cognitiva in sé, ad aver permesso agli esseri umani di espandersi su tutta la Terra.
La conquista del pensiero e del linguaggio, unita alla grandissima plasticità del cervello umano, ha reso possibile in particolare lo sviluppo della coscienza, che consente l’autoregolazione della relazione con l’ambiente, grazie all’integrazione mentale di un...