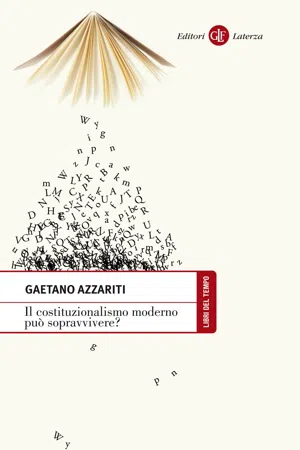VI. Il diritto debole
Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria.
Karl Marx, Friedrich Engels
Manifesto del partito comunista (1872) (traduzione non letterale)
1. La «grande trasformazione»
Il diritto costituzionale moderno sembra pericolosamente oscillare. Da un lato, il rischio di una cesura tra costituzione e politica, ovvero una progressiva impotenza della prima a limitare la seconda (come s’è visto al capitolo II), dall’altro, la frammentazione e moltiplicazione dei soggetti sovrani che operano ormai tanto in ambito nazionale, quanto e ancor più a livello sovranazionale (come s’è visto al capitolo III) rendono l’assetto dei poteri confuso e l’ordine costituzionale instabile. Ciononostante l’esigenza espressa dal moderno costituzionalismo di una limitazione dei «poteri selvaggi» non pare venir meno.
Sul piano dei diritti, invece, l’instabilità appare segnata da una perdita di forza normativa delle costituzioni, un affievolimento della loro capacità di assicurare che la garanzia dei diritti fondamentali sia inserita entro una prospettiva di emancipazione sociale e politica determinata, accompagnato da un accentuato ruolo della giurisprudenza nazionale e sovranazionale di tutela dei diritti fondamentali. Sono le Corti, più delle Carte, che vanno assumendo un ruolo centrale nella costruzione del sistema di protezione dei diritti, entro una prospettiva postmoderna di tutela indifferenziata e adespota (come s’è visto al capitolo IV). Eppure, anche sul fronte dei diritti, non può dirsi che siano venute meno le ragioni che sostengono il paradigma del costituzionalismo moderno. Il riconoscimento dei «diritti ai senza diritto», i limiti di una tutela generalizzata e senza qualità di ogni diritto per chiunque, scollegato dalle reali condizioni di vita dei soggetti sociali, fanno ritenere essenziale che si mantenga la forza non neutrale del giudizio costituzionale, inteso come strumento per fornire una legittimazione e un limite all’azione dei poteri (come s’è visto al capitolo V), dunque, entro una prospettiva classicamente moderna di costituzionalismo.
In questo complesso panorama quali sono i rischi per la sopravvivenza del costituzionalismo moderno?
Le pagine sin qui scritte hanno voluto far riflettere sulla costituzione e sul suo significato reale, poiché non interessa qui una ricerca sul significato che può astrattamente assegnarsi al concetto di costituzione, bensì quello effettivamente vigente e storicamente realizzabile: non il migliore concetto di costituzione immaginabile, dunque, ma quello concretamente possibile.
Proprio quest’impostazione realista induce a prospettare uno scenario caratterizzato da una «grande trasformazione». «Grande» perché segnerebbe il passaggio da una concezione moderna (per come c’è stata tramandata dall’epoca Moderna) a una concezione postmoderna di costituzione (per come si potrebbe profilare in epoca globale). Una trasformazione che – detto in estrema sintesi – potrebbe finire per incidere su ciò che deve essere considerato il proprium moderno delle costituzioni: la loro capacità ordinante; l’idoneità a porsi come atti normativi «superiori» (come s’è rilevato al capitolo I, § 2).
2. La costituzione come atto normativo «superiore» nel pensiero giuridico del Novecento
Non si può dubitare, infatti, che alle costituzioni, nell’epoca moderna, sia affidato principalmente il compito di definire (o comunque contenere) i principi fondamentali della convivenza sociale. È su questo presupposto che le costituzioni si pongono in funzione di promozione dell’ordine civile e politico, aspirando a essere riconosciute come fondamento ultimo di legittimità dei poteri e fonte prima dei diritti. Questi caratteri si sono andati sviluppando nella costruzione giuridica moderna fino a giungere, in Occidente nella sua fase più evoluta, a conformare per intero lo «Stato costituzionale»: un tipo di Stato – o, meglio, un’organizzazione sociale – che ha posto la costituzione al livello «più alto» dell’ordinamento giuridico. Lex superior (in Europa) o higher law (negli Usa), la costituzione diventa definitivamente l’atto normativo posto al vertice dell’organizzazione sociale. Tutto viene messo in rapporto di conformità e quindi subordinato a essa, persino la legge ordinaria e, in tal modo, la stessa sovranità popolare così come espressa nei Parlamenti democratici. È, dunque, in questa fase suprema dell’evoluzione storico-sociale del costituzionalismo che le costituzioni possono legittimamente aspirare a imporre per intero la loro valenza prescrittiva, facendo valere un peculiare carattere ordinatore da sempre presente nelle riflessioni sul ruolo delle costituzioni, ma che solo in questa fase e in questo contesto possono affermarsi come proprio tratto costitutivo. Ciò che viene a connotare le costituzioni (e il costituzionalismo) del Novecento è, dunque, non tanto una generica capacità di rappresentare un ordine, bensì una specifica capacità di conformare l’ordinamento sociale nel suo complesso, grazie ad un’acquisita forza normativa «superiore».
La scienza giuridica è giunta attraverso vie diverse ad affermare la superiorità normativa delle costituzioni. Il pensiero giuridico novecentesco si è, infatti, diviso radicalmente sul modo di intendere il concetto di costituzione. Differenti sono state le visioni costituzionali, vari i metodi adottati dai singoli interpreti e poste a fondamento delle diverse ricostruzioni di teoria del diritto. Su un punto però deve registrarsi una convergenza: l’attribuzione alla costituzione di una superiorità in grado.
Così nella prospettiva «normativista» la superiorità materiale della costituzione consegue alla classificazione della costituzione come norma sulla produzione giuridica, che regola «la creazione delle norme giuridiche generali». Una sovraordinazione dedotta logicamente, in base ad una ricostruzione tutta interna all’ordinamento giuridico – com’è peculiare della teoria «pura» – ma che appare tanto più importante giacché si pone a fondamento di validità di tutte le norme.
Diverso il percorso cui giungono ad affermare la superiorità della costituzione gli «istituzionalisti», particolarmente attenti al «fatto» legittimante la costituzione insieme all’intero ordinamento giuridico. In quest’ottica, la superiorità della legge «fondamentale» appare conformarsi come un dato sì subordinato all’imporsi «di fatto» del nuovo ordine, ma – una volta conseguita questa condizione – indiscutibile; direi ontologicamente data (la costituzione è «superiore» in quanto «fondamentale»). Non a caso Santi Romano ritiene «non dubbio», anche in un regime di costituzione flessibile, che lo Statuto sia espressione di «un potere legislativo superiore a quello ordinario. Il quale non soltanto è potere supremo, ma è altresì assolutamente insindacabile da ogni altro potere, compreso il giudiziario». D’altronde è noto che proprio a quest’autore si deve una tra le più penetranti riflessioni sui limiti materiali del legislatore, e appare assolutamente rilevante che tra questi si indichi il limite costituito dallo Statuto. Seppure – afferma all’inizio del secolo scorso Santi Romano – al Parlamento spetta la competenza di derogare allo Statuto, tale competenza non è illimitata, bensì è ammessa solo in tre casi: «quando la modificazione è imposta» dalla necessità, ovvero allo scopo di riconoscere una consuetudine, ovvero per integrare lo Statuto stesso.
«Superiore» è anche la costituzione nella prospettiva «decisionista». In questo terzo tipo di riflessioni teoriche, la sovraordinazione della costituzione non è una conseguenza logico-normativa, né può dirsi che le ragioni di carattere ontologico siano ritenute particolarmente rilevanti. È il modo di imporsi dell’atto che implica la necessaria supremazia della costituzione. Se il concetto positivo di costituzione è inteso – per usare la nota formulazione schmittiana – come «decisione totale sulla specie e la forma dell’unità politica», la «forza» della costituzione è presupposta, né può porsi in discussione, a pena dello sfaldamento dell’ordinamento giuridico e, insieme, della comunità politica. Vero è che anche in quest’ultima prospettiva, come nella precedente, il «concreto ordine ed assetto della società» esercita un’influenza diretta e decisiva sulla forza materiale della costituzione e sulla sua legittimazione. Pertanto la supremazia costituzionale non è data una volta per tutte, anzi essa appare fortemente condizionata dalla capacità di regolare in concreto gli interessi materiali e dalla necessità di dominare le trasformazioni della «struttura sociale». Ma ciò non tanto viene a indebolire la superiorità della costituzione come atto normativo, quanto impone di prestare una doverosa attenzione, non solo alle «forze» che la costituzione inizialmente impongono, ma anche a quelle che successivamente la sostengono. In questi casi si tende – più ancora che nella prospettiva precedente – a «uscire» dall’autoreferenzialità delle norme e dell’ordinamento giuridico, assegnando il massimo peso alla costituzione come documento storico-politico; nondimeno permane l’affermazione della superiorità costituzionale, che si pone come fondamento necessario della teoria.
Tre tipi di pensiero giuridico, dunque, che hanno percorso e caratterizzato l’intero secolo XX, le cui diversità sono abissali, ma che su un punto convergono: la superiorità della costituzione come norma.
3. La crisi della «forza» normativa delle costituzioni e la prospettiva analitica nella scienza giuridica
Nelle pagine che precedono è andata emergendo l’ipotesi che la crisi delle costituzioni sia oggi espressa dalla crisi della sua specifica capacità («forza») normativa. Sicché la naturale rigidità o superiorità delle costituzioni non può più essere ritenuta un dato certo. Non appare più sufficiente, nel nostro tempo, fondare la «superiorità» della costituzione su una mera deduzione logica in considerazione dei caratteri propri degli ordinamenti di riferimento (pur se le costituzioni continuano a essere poste al vertice del sistema delle fonti nei diversi ordinamenti); né vale più solo osservare il «fatto» che le costituzioni fondano nuovi ordini (e, dunque, a questi forniscono pur sempre legittimazione tanto politica quanto giuridica); né, infine, basta individuare le forze politiche che alla costituzione garantiscono il necessario sostegno materiale (pervenendo in tal modo a definire il concreto assetto dell’ordinamento).
Non ci si può, però, solo limitare a denunciare la crisi della capacità normativa delle costituzioni, si tratta anche di coglierne il senso. Infatti, al di là delle formali enunciazioni contenute nei testi costituzionali, da sempre si registra uno scarto tra la concreta esperienza giuridica, sociale, politica e l’effettiva «forza» delle costituzioni. Inesauribile è il problema dell’attuazione dei principi e della realizzazione di politiche costituzionali in grado di assicurare limiti al potere e rendere effettive le garanzie dei diritti. Da diverso tempo, inoltre, studi attenti hanno rilevato, in particolare per il nostro P...