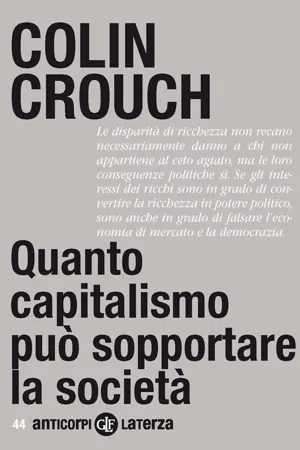capitolo settimo. La socialdemocrazia quale forma suprema di liberalismo
La tesi sostenuta alla fine del capitolo precedente, cioè che la socialdemocrazia rappresenta una fonte importante di alternative all’interno della società capitalista, suscita una sensazione di déjà vu riconducibile ai primi anni del movimento operaio, che portarono stimoli e innovazione in una forma di capitalismo i cui vecchi binari erano ormai logori, sorretta principalmente dal fatto che era al servizio di interessi estremamente potenti. Molte cose sono cambiate da allora. Nei primi decenni i socialdemocratici, o i socialisti, come venivano indistintamente chiamati all’epoca, cercarono di porre fine al sistema capitalistico e di sostituirlo con vari controlli statali, che a loro volta avrebbero ceduto il passo a varie forme non ben definite di gestione economica pubblica. Tale visione oggi è in gran parte scomparsa, in quanto il mercato ha dimostrato di avere una vasta capacità di rispondere a molte esigenze comuni, anche se di certo non a tutte, mentre il controllo statale ha rivelato il suo lato più oscuro nel socialismo di Stato, e le altre alternative continuano a essere definite con la stessa vaghezza di sempre. Come abbiamo visto nel primo capitolo, la socialdemocrazia, nel corso del tempo, ha finito per richiamarsi a un approccio basato sul capitalismo e sul mercato, ma che, attraverso la regolamentazione, la tassazione, l’offerta di servizi pubblici, la rappresentanza degli interessi di chi è relativamente privo di potere e una forte rappresentanza sindacale dei lavoratori, assicura che il capitalismo sia posto al servizio di una più ampia varietà di scopi umani, rispetto a quelli che il mercato potrà mai conseguire. Oggi afferma di essere una forza stimolante e innovativa, ma la veridicità di questa affermazione continua a dipendere dalla sua capacità di proporre alternative all’interno di un’economia di mercato, alternative che rischiano di essere messe ai margini via via che il neoliberismo avanza lungo i suoi ferrei binari.
La riflessione su un secolo di socialdemocrazia europea rivela inoltre che essa ha riportato i suoi più grandi trionfi allorché ha garantito il pluralismo e l’inclusività sul piano sia politico sia economico a un livello più diffuso di quello altrimenti raggiungibile nelle società capitaliste. Dovrebbe essere questo risultato essenzialmente liberale a caratterizzarla, più che il controllo statale. Questa prospettiva fornisce la base per una valutazione ottimistica del futuro della socialdemocrazia, purché si possano affrontare gli elementi inospitali dell’ambiente sociale odierno e futuro, esaminati nei capitoli precedenti.
Nonostante la scarsa lungimiranza, la vecchia sinistra socialista comprese la natura del potere nelle società capitaliste meglio di molti socialdemocratici. Capì che il problema della disuguaglianza non era una semplice questione di differenze di reddito, bensì un problema di rapporti di potere. I socialisti potevano avere questa visione della realtà perché, da marxisti, credevano nell’inevitabilità del superamento finale del capitalismo; convinti che la rivoluzione sarebbe sicuramente arrivata, non avevano paura di vedere tutto ciò che era sbagliato, ma non poteva essere risolto conducendo normali campagne politiche nella società capitalista. I socialdemocratici, invece, riuscivano a vedere la mancanza di realismo nella valutazione del futuro da parte dei marxisti, ma, avendo bisogno di credere che i problemi fossero risolvibili mediante la politica parlamentare, dovevano pensare che il capitalismo fosse essenzialmente domato e addomesticato. Anche questa, come i sogni dei marxisti, era una fuga dalla realtà.
E se entrambe le vie di fuga ci sono precluse? E se pensiamo che il potere capitalista continui a rappresentare un grosso ostacolo verso una società più giusta, ma anche che tale potere e le disuguaglianze che lo accompagnano non potranno mai essere eliminati del tutto, mentre un’economia di mercato basata sulla proprietà privata offre prospettive di gran lunga migliori di un’economia basata sulla proprietà «comune», che alla fine si traduce sempre in controllo statale? Se tutto il potere è concentrato nello Stato nel nome del popolo, di fatto finirà per essere concentrato nelle mani di una piccola e potente élite, che lo userà per promuovere i propri interessi e probabilmente per schiacciare l’opposizione. L’egoismo è endemico tra coloro che aspirano al potere, e quanto più potere questi ultimi ottengono, tanto più diventano pericolosi. Ci si para sempre davanti la famosa massima liberale di Acton: «Il potere tende a corrompere e il potere assoluto corrompe in modo assoluto». La socialdemocrazia, in quanto movimento politico di chi è relativamente privo di potere, non può mai tralasciare questa intuizione liberale fondamentale, anche solo per salvarsi da se stessa.
La socialdemocrazia trascende il liberalismo, ma non nel modo in cui i pensatori socialisti credevano. Il significato essenziale della differenza tra destra e sinistra politica è la differenza tra chi detiene il potere costituito (la destra) e chi è soggiogato da tale potere (la sinistra). Se le forze dominate diventano quelle dominanti, l’ex sinistra diventa la destra e viceversa. Questo è il normale corso degli eventi, che ha visto alternarsi al potere cricche rivali, spesso con la violenza, riscontrabile praticamente in tutte le società predemocratiche. È una spiegazione un po’ troppo semplicistica. Spesso esistono gruppi che, sebbene non facciano assolutamente parte dei poteri costituiti, ripongono cieca fiducia nei loro confronti e nell’ordine rigoroso che rappresentano e in molti casi vorrebbero che si spingessero persino più a destra di quanto quegli stessi poteri ritengano opportuno. Sovente sono motivo di imbarazzo per la destra istituzionalizzata, anche se ogni tanto le tornano utili. Un importante esempio storico è fornito dal movimento ultrarealista nella Francia della restaurazione borbonica, plus royaliste que le roi. Oggi ci sono populisti e razzisti di estrema destra, persone al di fuori della politica che però vogliono l’esercizio di una forte autorità da parte dei poteri costituiti.
Marx era convinto che, se la sinistra fosse stata costituita dalla classe operaia, il ciclo di alternanze sarebbe cessato, perché la classe operaia era per definizione la classe oppressa nella massa della popolazione e, quando fosse assurta al potere, avrebbe posto fine una volta per tutte ai rapporti di potere. Ma una massa non può mai salire al potere. Può soltanto rovesciare i rappresentanti che sostengono di governare in suo nome, ma che poi inevitabilmente, almeno in parte, perseguono i propri interessi politici. Le masse operaie rimangono dove sono sempre state. I lavoratori hanno migliori probabilità di acquisire una certa influenza politica quando possono scegliere fra élite concorrenti e quando la società offre loro un grande insieme di istituzioni diverse, rispetto a quando si confrontano con un’élite monopolistica che afferma di essere la loro unica rappresentante e le istituzioni considerate rappresentative delle classi ostili vengono spazzate via.
Questo argomento trova conferma nei partiti politici che storicamente hanno assunto il ruolo di rappresentanti dei lavoratori: i partiti comunista, socialista, socialdemocratico e laburista. Quando vanno al governo in un’economia capitalistica che rimane capitalistica, i poteri costituiti della società non vengono sovvertiti, ma si crea una situazione di contrasto tra una destra economica elitaria e una sinistra politica. Possono scendere a compromessi e, a seconda della natura di tali compromessi, la sinistra politica o conserva il proprio status oppure si compromette al punto di diventare indistinguibile dalla destra. Invece, se tali partiti aboliscono l’economia capitalistica e la sostituiscono con un’economia controllata dallo Stato, tale situazione di contrasto viene meno. La «sinistra» governa sia sul piano economico sia su quello politico. Ma ogni volta che questo sistema è durato più a lungo di qualche anno, la conseguenza è stata che la sinistra si è rivelata un’autorità esclusivistica e intollerante e si è trasformata in una nuova destra istituzionalizzata: un processo descritto brillantemente da George Orwell nella Fattoria degli animali. Il risultato finale è visibile nell’uso assai indistinto dei termini «sinistra» e «destra» nell’ex blocco sovietico. Paradossalmente, quando conquista il potere politico, la sinistra può rimanere la sinistra soltanto se opera in condizioni di tensione permanente con una sopravvivente destra economica.
Poiché la classe operaia non potrà mai trionfare assumendo collettivamente il controllo di un sistema politico ed economico – nel modo in cui possono farlo le élite – le società e gli Stati caratterizzati da forti movimenti socialdemocratici che coesistono con le economie di mercato sono il miglior contesto a disposizione per salvaguardare il pluralismo e mantenere una tensione politica creativa. Negli anni Cinquanta la vita a Oslo o a Stoccolma non appariva tanto diversa da quella a Praga o a Varsavia: una scelta austera e limitata di prodotti, un accento sull’approvvigionamento collettivo anziché individuale, un governo formato da partiti con una spiccata retorica socialista. Gli scandinavi erano tuttavia pervenuti al loro modello mediante libere elezioni e un dibattito aperto; gli abitanti dell’Europa centrale avevano acquisito il loro attraverso l’intervento militare dell’esercito sovietico, seguito dalla violenta repressione di tutte le forze rivali. Questi due gruppi di società si sono poi sviluppati in maniera del tutto diversa. Le prime diventarono le società più aperte e trasparenti del mondo, con alti livelli di innovazione nell’economia e in altri ambiti della società. Le altre diventarono lugubri Stati di polizia, con economie rigide e incapaci di produrre innovazione. I socialdemocratici nordici non hanno mai tentato di abolire le competizioni elettorali o l’economia capitalistica; potenti sindacati operavano al fianco dei rispettivi partiti di riferimento, ma in modo autonomo, e piccole economie, estremamente aperte, venivano mantenute senza forme di protezionismo. Alcune di queste condizioni, soprattutto l’apertura delle piccole economie, imponevano vincoli severi a una socialdemocrazia forte che doveva operare al fianco di potenti forze di mercato. Il contrasto produsse un alto livello di creatività nello sviluppo delle politiche e negli approcci economici. Come abbiamo visto nel quinto capitolo, un assetto di questo tipo perdura tutt’oggi e continua a produrre risultati vincenti sotto forma di welfare fondato sugli investimenti sociali, abbinato a relazioni industriali solide e coordinate e a un’economia di mercato vigorosa. In uno scenario neoliberista generalizzato, dove molte economie nazionali sono ricavate da un unico stampo, con le stesse capacità e carenze, questo assetto possiede qualche cosa di diverso che conferisce vantaggi competitivi.
Non è così che i socialdemocratici nordici interpretavano la loro situazione, almeno non all’inizio. Per decenni credettero di condurre una lotta per trascendere il capitalismo. Non promossero la contrattazione collettiva centralizzata al fine di assicurare che i sindacati fossero sollecitati a tenere conto dell’interesse generale e a sostenere la competitività nazionale, come descritto nel quinto capitolo: cercavano di aumentare al massimo il potere unilaterale dei lavoratori organizzati. Tuttavia, il tentativo di massimizzare tale potere in economie aperte li portò, dapprima inconsapevolmente, a realizzare qualcosa di ben diverso, ma più prezioso. Analogamente, quando i socialisti britannici crearono il servizio sanitario nazionale, che è tuttora il più grande risultato mai conseguito dal Partito laburista, non prevedevano la vasta raccolta di prassi mediche eccellenti che oggi costituiscono tale servizio. Condividevano la convinzione generale dei socialisti dei primi del Novecento, secondo cui la cattiva salute era in gran parte dovuta allo sfruttamento capitalistico e, una volta che la società socialista fosse stata costruita, il sistema sanitario nazionale sarebbe diventato un elemento secondario del servizio pubblico. Le conquiste non sempre corrispondono alle intenzioni, nemmeno quando hanno enorme successo.
Oggi, con il senno di poi, possiamo vedere i risultati effettivamente conseguiti da forti movimenti dei lavoratori e prevedere un futuro che si fondi su tali risultati anziché su sogni fallaci. Un risultato fondamentale cui deve portare questo processo è la conclusione che la socialdemocrazia non solo può prosperare in un ambiente capitalistico liberale, ma in tale ambiente produce anche un grado di liberalismo più elevato rispetto al liberalismo tradizionale lasciato a se stesso, perché è lo scontro tra liberalismo e socialdemocrazia a generare l’incentivo a proseguire la ricerca di nuovi compromessi creativi. Ciò è particolarmente vero quando il liberalismo assume la sua forma contemporanea di neoliberismo del terzo tipo, dominato dalle imprese. L’economia neoliberista contemporanea si è tramutata in una serie di relazioni fra, da un lato, le imprese e, dall’altro, i governi e vari tipi di organizzazioni, nell’ambito delle quali i cittadini rischiano di essere utenti passivi, che non partecipano, non sono parti contraenti. I politici e gli intellettuali che la sostengono insistono su un dogma dei liberi mercati che azzera la diversità e la possibilità di scelte alternative ed è applicato impropriamente in un modo che ignora importanti inadeguatezze del mercato che colpiscono i lavoratori, ma non disturba le intime relazioni all’interno dell’élite.
La premessa essenziale del liberalismo è che una società caratterizzata da un dibattito costante, senza egemonie durature, produce tensioni creative che mutano di frequente e danno origine a innovazione e varietà. L’argomento vale innanzitutto per la politica, dove è abbinato alla tesi a favore della contestazione permanente del potere radicato delle élite e del contenimento delle disuguaglianze. Nell’economia si presenta come l’idea di imprenditorialità associata a Joseph Schumpeter: un processo di distruzione creatrice, attraverso il quale gli innovatori producono combinazioni sempre nuove di elementi che in precedenza non erano in relazione fra loro. Di qui, il passo è breve per cogliere anche l’argomento a favore del liberalismo quale portatore di varietà e subbuglio nelle conoscenze, comprese le conoscenze necessarie per la politica pubblica.
A questo proposito, una figura chiave fu il filosofo Karl Popper, originario dello stesso ambiente viennese di Karl Polanyi, il quale, in risposta alle tirannie tanto del fascismo quanto del socialismo di Stato, evidenziava l’imperfezione di praticamente tutte le conoscenze umane, anche quelle derivanti dalla scienza sperimentale, e quindi la necessità di mantenere sempre la mente aperta, di non aspirare mai alla certezza, di non limitare mai le fonti di nuove conoscenze a quelle con le quali si ha già dimestichezza. A differenza di Friedrich von Hayek, suo concittadino austriaco e collega alla London School of Economics del dopoguerra, nonché figura di primaria importanza nel pantheon neoliberista attuale, Popper non interpretava il problema dell’incertezza nel senso che tutto andrebbe affidato alle forze del mercato. Insisteva sulla necessità di riesaminare e correggere continuamente le teorie e le conoscenze utilizzate sia nelle scienze sia nella definizione delle politiche, il che significava mettere in discussione le teorie del mercato assieme a tutte le altre. Chiamò il suo approccio «ingegneria sociale» – espressione che usava in senso positivo, ma che in seguito fu totalmente distorta dai pensatori neoliberisti, che la usarono per descrivere un approccio alla riforma sociale onnisciente, dall’alto verso il basso. Popper intendeva l’esatto contrario: il suo ingegnere è colui che ripara, il risolutore gradualista dei problemi via via che si procede, destreggiandosi nella vita e cercando di tener testa alle difficoltà mano a mano che si presentano. Rispetto a questa concezione, sono i neoliberisti a credere di aver trovato un sistema perfetto.
In politica Popper era un socialdemocratico, se pur di una specie molto liberale. Seguendo la logica degli argomenti di Popper, Ralf Dahrendorf, uno dei suoi più autorevoli seguaci, abbandonò l’impegno iniziale nei confronti della socialdemocrazia tedesca e diventò un liberale democratico. Per Dahrendorf il perseguimento della certezza o di stati utopistici della società era un anatema, perché lo scopo dell’utopismo era pervenire a uno stadio finale in cui il conflitto sarebbe cessato e in cui i contorni della buona società fossero perfettamente noti in anticipo. Riteneva che i socialdemocratici avessero una mentalità di questo tipo, che impediva loro di essere amici del dibattito costante, del pluralismo e dell’apertura mentale. Ma per lo stesso motivo rifiutava anche Hayek e altri pensatori che aspiravano a perseguire la perfezione attraverso il mercato. «[S]e il capitalismo è un sistema», scrisse provocatoriamente a un collega polacco nel 1990, «allora va combattuto come è stato combattuto il comunismo. Tutti i sistemi significano servitù, compreso il sistema ‘naturale’ di un totale ‘ordine di mercato’».
La socialdemocrazia ufficiale dei partiti socialdemocratici, socialisti e laburisti da molto tempo ha rinunciato alla ricerca di una società perfetta; anzi, la socialdemocrazia difensiva odierna si colloca al polo opposto dell’ambizione politica. Tuttavia la socialdemocrazia utopica e quella difensiva sono entrambe vulnerabili all’accusa di Dahrendorf di rifuggire dal conflitto e dall’innovazione. Al tempo stesso, il filosofo non aveva risposte per un dilemma fondamentale del liberalismo: come scongiurare un arroccamento delle élite, come garantire le tensioni sociali e i conflitti moderati che, a ragione, considerava essenziali per sostenere la capacità di innovazione. Il suo stesso partito «liberale», la Freie Demokratische Partei (Fdp) tedesca, è divenuto uno dei più convinti sostenitori in Europa di un’idea dogmatica della perfezione dell’ordine di mercato.
Il problema del liberalismo contemporaneo in quanto movimento politico, anziché filosofia, è che dipende dall’esistenza di un certo equilibrio tra le forze presenti nella società per riuscire ad assicurare la varietà di cui quest’ultima ha bisogno; ma non può fare altro che amministrare le forze che già esistono, non le produce autonomamente. Dategli cattolici e non conformisti, e saprà come incoraggiare la tolleranza fra loro. Dategli nuove classi medie e lavoratrici che chiedono a gran voce l’ammissione nella cittadinanza, e saprà come accoglierle. Ma non è in grado di determinare da sé quali gruppi si delineeranno e potranno quindi avanzare rivendicazioni. È una politica da amministratore, motivo per cui in ogni paese il liberalismo è scivolato in una posizione minoritaria, a meno che non si sia alleato con gruppi di sinistra o di destra che rappresentano identità di più antica origine. Se l’ago della bilancia del potere si sposta in una posizione che favorisce la crescita della disuguaglianza e la nascita di un’élite egemonica, il liberalismo ha difficoltà a lanciare un’offensiva sociale contro tale orientamento – ed è precisamente quel che accade oggi ai partiti liberali in tutta Europa.
In questa situazione è necessaria una nuova articolazione dei vari interessi della massa della popolazione dei quali le élite attuali non si curano, e soltanto la socialdemocrazia, alleata ad altre forze, come gli ambientalisti, ha la capacità di assolvere tale missione. I partiti socialdemocratici sono stati più bravi di tutte le altre famiglie politiche a promuovere la causa delle donne e a integrare le minoranze. Sono stati più sensibili del centro-destra alle problematiche ecologiche. Affermazioni analoghe si possono fare per i sindacati. Pochissime altre organizzazioni di massa nella società contemporanea, salvo alcune organizzazioni religiose, hanno avuto altrettanto successo nel rappresentare le donne e le minoranze etniche. La socialdemocrazia continua a essere in grado di svolgere il proprio ruolo storico: rappresentare chi è privo di potere nella società capitalista, un ruolo di natura perpetua e senza il quale il neoliberismo cessa di far parte della famiglia liberale.
D’altro canto, molti elementi legati all’assunzione di tale ruolo oggi non si attagliano alla socialdemocrazia storica, né alla sua forma difensiva prevalente ai giorni nostri o alla direzione verso cui è stata spinta da alcuni aspetti del programma della «terza via». Possiamo individuare i vantaggi e le difficoltà presentati dalla sua posizione esaminando tre ambiti fondamentali nei quali occorre rispondere alle sfide e cogliere le opportunità. I socialdemocratici sono invitati a riconoscere sia la continuità con la loro tradizione storica rappresentata dalle sfide, sia la necessità di adattarla al fine di fronteggiarle. Quest’ultimo aspetto risulta tanto più semplice quanto più la socialdemocrazia nel ventunesimo secolo si può intendere come un movimento collettivo che riunisce gli ambientalisti e alcuni altri recenti movimenti radicali.
Salvaguardare il pluralismo istituzionale
In primo luogo, è necessario salvaguardare il pluralismo economico e sociale contro il predominio della classe capitalista e della monetizzazione di ogni valore. Un tempo l’uguaglianza, giusto o sbagliato che fosse, era considerata nemica della diversità: oggi è la sua alleata. L’idea di concorrenza economica è stata reinterpretata nella legislazione antitrust degli Stati Uniti e nell’economia neoliberista. Invece di descrivere una situazione di concorrenza crescente tra un gran numero di imprese, può riferirsi a un contesto in cui la concorrenza è terminata con la vittoria...