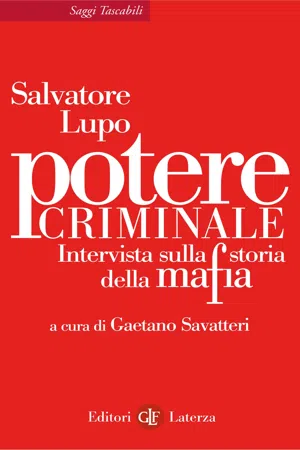Una storia difficile
Gaetano Savatteri L’episodio dell’archivista di Palermo deciso a non far vedere i documenti ci porta direttamente alla tua attività di ricerca e di studio. Ci mostra le difficoltà che hai incontrato, anche di carattere più generale. È molto strano infatti che fino al 1993, quando hai pubblicato per Donzelli la tua «Storia della mafia», nessuno avesse mai ritenuto di poter scrivere di quest’argomento dal punto di vista strettamente storico, con una visione complessiva. C’erano molti libri, ovviamente, una letteratura vastissima, ma erano testi sociologici, interventi giornalistici, romanzi o saggi di costume. Un ritardo, dal punto di vista dalla scienza storica, di oltre un secolo rispetto al dibattito politico e sociale sulla mafia.
Salvatore Lupo Sì, questo è vero per quanto riguarda gli storici. Ma non vuol dire che non ci siano stati contributi, diciamo scientifici, di cultori di altre scienze sociali. La discussione sulla mafia ad esempio vide tra Otto e Novecento fondamentali contributi di personaggi come Leopoldo Franchetti, Gaetano Mosca e, per un aspetto singolo ma cruciale, Santi Romano.
S. Quale aspetto?
L. Romano è un grande giurista palermitano di inizio Novecento, universalmente noto per la sua teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, secondo la quale coesistono nello stesso tempo e nello stesso luogo, accanto a quello statale, altri ordinamenti importanti (ad esempio quello ecclesiastico) o minori (ad esempio quello di una federazione sportiva), che il più delle volte non sono antagonistici all’ordinamento statale – a meno, certo, che non assumano un atteggiamento eversivo o rivoluzionario. Romano stesso cita tra gli esempi possibili quello di «certe» organizzazioni segrete e criminali, e dei loro ordinamenti.
S. Quindi ordinamenti antistatali?
L. Non antistatali – questo è il punto – almeno finché non si mettono in testa di fare concorrenza all’ordinamento «maggiore», statale. Non possiamo nemmeno dirli «comunitari», perché non riguardano tutti i membri di una comunità ma solo i componenti del gruppo criminale. Vorrei ricordare un’applicazione davvero geniale della teoria di Romano da parte dell’etnogiurista sardo Antonio Pigliaru, che nel suo libro del 1959, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, definisce la faida come ordinamento giuridico prestatale comune a tutta la società pastorale della Barbagia; da distinguersi dunque dalla mafia e dal suo ordinamento che riguarda un sottogruppo particolare. Ecco, con Romano e Pigliaru siamo sulla strada giusta.
S. Intuizioni che tu definisci geniali, ma ancora fuori dal campo della scienza storica...
L. Esatto. Potrei aggiungere il contributo importantissimo di Emilio Sereni, grande studioso di storia agraria e dirigente comunista degli anni Trenta e Quaranta, che andò a collocare la questione mafiosa in una grande discussione storiografica: quella sul latifondo meridionale. Sereni – riprendendo le fila di un dibattito quasi secolare – vide la mafia come uno strumento del ceto sociale dei gabelloti, cioè gli affittuari dei latifondi, una sorta di variante locale e mancata di borghesia. La funzione storica dei gabelloti e dunque della mafia, gli uni e l’altra intermediari tra latifondisti e contadini, sarebbe secondo Sereni venuta meno con l’accentuarsi della lotta di classe.
S. Pensiero che segnerà tutte le analisi successive di impronta marxista.
L. Basterebbe pensare allo studio di un grandissimo storico marxista come Eric Hobsbawm, I ribelli, che, con riferimento a certe situazioni calabresi, citava l’onorata società come strumento di una «forma primitiva di lotta sociale», destinata a esaurirsi quando si fossero creati moderni movimenti collettivi. Le altre versioni marxiste peraltro assunsero questa tesi in una forma più semplificata, politicamente più spendibile. La cultura di sinistra degli anni Cinquanta rappresentò la mafia come un mero strumento dei latifondisti. D’altronde gli eventi drammatici del dopoguerra si prestavano a questa interpretazione, mostrando latifondisti e mafiosi saldati in un gruppo unico. Questa stessa cultura di ispirazione marxista o radicale vide la mafia come il segno della permanenza di antiche «tare» nella nostra società, nonostante l’avvento della democrazia e dei processi di sviluppo economico.
S. Un contributo importante arrivò da sociologi e antropologi.
L. Sì, ma spesso erano stranieri, che avevano poca conoscenza dell’argomento nel suo complesso e, potrei dire, non avevano letto né Romano né Pigliaru. Prevalse, come nel caso del sociologo tedesco Henner Hess, lo «sguardo esterno» di chi leggeva il comportamento mafioso come specchio di una cultura mediterranea resistente alla moderna etica statale. Così però il fenomeno veniva collocato in una sfera arcaicizzante, nella categoria dei «fossili culturali», in un mondo per definizione senza tempo e senza storia. Comunque negli anni Sessanta si erano cominciati a vedere in libreria testi scritti da storici di professione: il primo a cimentarsi fu Salvatore Francesco Romano, un pioniere negli studi contemporaneistici sulla Sicilia, ma che sullo specifico non fornì contributi di ricerca originale. Sino a quel periodo, d’altronde, la storia sociale aveva poco credito in Italia e gli storici dell’età contemporanea si occupavano di altro: dello sviluppo e del sottosviluppo economico, dei partiti di massa...
S. Può sembrare strano, peraltro, che i primi studi e le prime ricerche storiche siano venute da Catania e non da Palermo, in teoria un luogo di osservazione purtroppo privilegiato rispetto alle vicende mafiose.
L. Palermo era forse un punto di osservazione troppo privilegiato, ovvero troppo vicino all’oggetto. Comunque, per spiegare quest’arcano, bisogna partire dagli anni Settanta.
S. Prova a farlo, magari seguendo un filo autobiografico.
L. Allora bisogna partire da prima ancora, dall’inizio. Mio padre era ufficiale di polizia, mia madre un’insegnante di lettere. Lasciarono la natia Catania per trasferirsi a Novara nel 1949, e poi a Siena dove sono nato nel 1951. Abbiamo vissuto a Vicenza e Forlì, tornando in Sicilia solo nel 1964, quando mio padre venne destinato a Siracusa. Insomma, sono figlio di un’emigrazione borghese, nazionalizzata e nazionalizzante. A casa mia era in uso un rigorosissimo italiano. Guai se – approdati in Sicilia – mia sorella e io ci lasciavamo condizionare da qualche dialettismo: era escluso che usassimo transitivamente i verbi intransitivi, cosa che usualmente fanno molti siciliani. Tutt’oggi né io né lei parliamo decentemente il dialetto. Tutto questo spiega forse qualcosa del mio carattere di siciliano di complemento, che ha sempre guardato alla sua terra un po’ dall’esterno.
S. I tuoi studi universitari iniziano in Sicilia...
L. Sì. Mi sono iscritto al corso di laurea in Filosofia a Catania nel 1970, ma optando per un piano di studi storico. Fu dunque naturale che, al pari di altri studenti politicizzati (ed erano tanti in quegli anni!), privilegiassi la storia contemporanea che dal 1965 era insegnata da un docente di grande fascino e prestigio come Gastone Manacorda. Già direttore prima di «Società» e poi di «Studi storici» – due imprese cruciali nella formazione della cultura comunista italiana –, Manacorda non si era presentato col piglio militante che ci si aspettava da lui, ma con un appello a ragionare sulle fonti, a lavorare con rigore, a rifuggire dal facile ideologismo. Come «continentale» in Sicilia, come studioso di livello nazionale e internazionale finito a insegnare storia contemporanea (tra i primissimi nel nostro paese) in periferia, provò a porre le basi di una storiografia regionale, ma non di taglio regionalista.
S. C’era già una grande tradizione di studi storici. Non sembra possibile che si dovesse ricominciare da capo a fare storia della Sicilia.
L. Nel campo della storia medievale e moderna magari no, ma in quello della contemporanea le cose stavano proprio così. E comunque c’era una tradizione, soprattutto a Palermo, che considerava l’isola come un mondo diverso, da trattarsi separatamente dal resto d’Italia e con strumenti intellettuali differenti da quelli adottati altrove. Peraltro, Manacorda era consapevole che la stessa storia nazionale avesse da guadagnare dall’attenzione alla storia regionale, in particolare se parliamo di una regione così ricca di conflitti, cultura e discussioni pubbliche come la Sicilia. Per usare una sua frase: dal punto di vista siciliano, si possono vedere prospettive e vedute d’insieme diverse rispetto a quelle che si scorgono dalle finestre del Principe, ovvero dai punti culminanti dello sviluppo.
S. Oltre a te, chi erano gli allievi di Manacorda?
L. Tra quelli che hanno lavorato sulla mafia o su argomenti simili, citerò Giuseppe Barone e Rosario Mangiameli. Non era allievo di Manacorda ma entrò nel suo giro Nino Recupero, fine studioso e intellettuale carismatico che oggi purtroppo non c’è più. Ne potrei ricordare altri, giovani e politicamente orientati a sinistra. Mangiameli e io, ad esempio, militavamo nel «manifesto».
S. Un’area dentro la quale già allora si affrontava la questione della mafia.
L. Sì, ma nel gruppo palermitano piuttosto che in quello catanese. A Palermo «il manifesto» era guidato da Mario Mineo, personaggio di rilievo, di tutt’altra generazione rispetto alla nostra, già deputato nel dopoguerra alla Consulta regionale siciliana ed estensore di uno dei progetti di Statuto, poi passato attraverso varie esperienze nella sinistra, senza radicarsi in nessuna in particolare, a causa – diciamo così – del suo eccessivo spirito critico. Ricordo quando discutevamo di mafia con lui e con Umberto Santino, che avrebbe fatto dell’antimafia una ragione di vita: Mineo sosteneva che in Sicilia, come nel dopoguerra ai tempi del movimento contadino, la mafia fosse ancora il problema centrale. A me e agli altri del nostro gruppo, catanesi e tanto più giovani di lui, sembrava un vecchio ossessionato dal passato e dai conflitti del passato, ossessionato da altri vecchi con le coppole storte, gli abiti di fustagno e così via. D’altronde non eravamo gli unici a pensarla così: anche a livello nazionale nel «manifesto» nessuno gli prestava orecchio, tanto che lui e i suoi seguaci si sarebbero tirati fuori ben presto anche da quell’esperienza.
S. Ma nella Catania di allora non c’era la discussione sui grandi imprenditori cittadini, i cosiddetti Cavalieri del lavoro, cioè Carmelo Costanzo, Gaetano Graci, Francesco Finocchiaro e Mario Rendo? Stavano all’interno di una rete di relazioni di cui facevano parte anche esponenti e gruppi mafiosi.
L. Ma noi non saremmo stati eventualmente in grado di riconoscere la mafia in quegli ambienti, e nemmeno nei figuri di cui si contornava Carmelo Costanzo – massimamente in colui che stava emergendo come il boss cittadino, Benedetto Santapaola, detto Nitto. Certo, eravamo molto critici verso il Pci, che considerava personaggi del genere come interlocutori affidabili di un improbabile «patto dei produttori», ma non perché ci vedessimo un meccanismo di collusione mafiosa, bensì per la deplorevole subordinazione del movimento operaio agli interessi del capitalismo – di un capitalismo che sapevamo particolarmente corrotto e dipendente dall’aiuto pubblico, certo.
S. Insomma, nutrivi molte perplessità sul discorso politico che in Sicilia veniva portato avanti dai comunisti...
L. Sì, in particolare per la faciloneria con cui veniva attribuita la patente del progressista a chi non ne aveva i titoli, per l’abuso dell’argomento sulla difesa degli interessi siciliani contro i «monopoli» del Settentrione. Risentivo gli echi della vicenda di fine anni Cinquanta, quando, invocando gli stessi interessi, i comunisti si erano ridotti a fare da supporto al governo regionale presieduto da Silvio Milazzo, un’ibrida alleanza comprendente (tra l’altro) la destra neofascista. Vedevo che, ancora sulla base del medesimo argomento, i comunisti si preparavano a sottoscrivere un «patto autonomistico» con la Democrazia cristiana. Temevo che avremmo avuto su scala regionale il peggio di quello che a me già appariva il peggio, il compromesso storico. Proprio in polemica con questo tipo di strategie, Mineo parlava già da tempo di «borghesia mafiosa». Ma, devo ribadirlo, nemmeno noi del «manifesto» comprendevamo allora a Catania l’importanza della sua polemica.
S. Insomma i comunisti erano regionalisti, ma come le altre forze politiche e come molta parte dell’opinione pubblica siciliana.
L. Come gli altri, certo. Però in una situazione come quella degli anni Settanta, nella stagione del compromesso storico e del patto autonomistico, questo posizionamento diveniva assai condizionante non solo per la politica, ma anche per la cultura e in particolare per gli studi sulla storia recente della Sicilia. Ti sintetizzo in poche battute la vulgata che era diffusa allora e che forse è diffusa ancor oggi. I latifondisti – si diceva – avevano oppresso i contadini come lo Stato unitario aveva oppresso i siciliani almeno fino al secondo dopoguerra, quando i partiti avevano ottenuto l’autonomia regionale, anche utilizzando lo choc (lo storico Massimo Ganci diceva: il «pugno sul tavolo») del movimento separatista. Nel corso di lussuosi convegni organizzati negli sfarzosi saloni dell’Assemblea regionale, si guardava al passato, ma dal punto di vista di quello sbocco escatologico, delle luminose sorti e progressive della Sicilia autonoma. Gli storici di sinistra (Ganci appunto, Francesco Brancato, Carlo Marino, Francesco Renda) si univano al coro, sia pure con diversità di accenti e con qualche distinguo.
S. Parli di storici palermitani o comunque radicati a Palermo.
L. La regione ha la sua «capitale» a Palermo. A Palermo c’è il suo «Parlamento» (così enfaticamente lo si chiama), e quindi non casualmente l’intera storia della Sicilia viene vista da Palermo in una prospettiva ossessivamente regionalista. Nella mia testa, la differenza tra quella «vecchia» storiografia e la storiografia nuova corrispondeva alla differenza tra Palermo e Catania. Catania guardava alla storiografia nazionale, cui aveva dato un grandissimo come Rosario Romeo. A Catania insegnava Giuseppe Giarrizzo, preside della facoltà di Lettere, lo storico forse più illustre tra quelli rimasti a lavorare nell’isola, uno dei pochi a essersi mantenuto immune dalle lusinghe del sicilianismo. A Catania c’erano le forz...