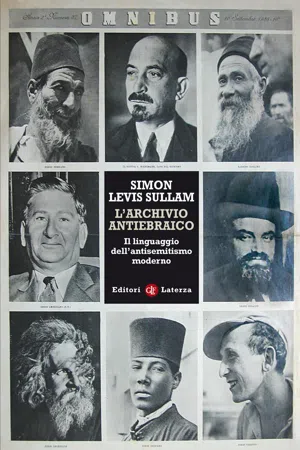II. La storia
1. Da Voltaire a Marx
Nei prodromi di due rivoluzioni, quella francese del 1789 e quella europea del 1848, Voltaire e Marx introducono la questione ebraica nel discorso sulla modernità riprendendo anche alcuni luoghi della tradizione antigiudaica, e così facendo forniscono nuovi testi all’archivio antiebraico del lungo Ottocento e dell’età contemporanea. Inaugurano, inoltre, un uso «sineddochico» degli «ebrei» come parte per il tutto, generalmente negativa, attraverso cui la società europea inizia a pensare se stessa. Gli scritti dei due pensatori, costruiti attorno alla questione della sopravvivenza della religione nell’età moderna e, nel caso di Marx, dell’emergere della società capitalistica, ripropongono elementi del repertorio antigiudaico di matrice religiosa, ma allo stesso tempo secolarizzano l’approccio alla questione ebraica, facendo dell’antiebraismo una pratica discorsiva e ideologica laica, legata a tendenze della modernità come il ripudio delle credenze religiose e l’emergere di un’economia di mercato. Nel caso di Voltaire l’ostinato attaccamento degli ebrei alla propria tradizione religiosa – un tema tipico della polemica antigiudaica, emblematicamente rappresentato dalla «sinagoga cieca» (tipica figurazione dell’iconografia medievale) – viene utilizzato come critica della sopravvivenza della religione. In Marx la discussione del ruolo e dei comportamenti economici degli ebrei si unisce a una critica dei comportamenti economici della borghesia e della nascente società del mercato. Qui per la prima volta si saldano antiebraismo e critica anticapitalista: un tema ricorrente, in seguito, nel cosiddetto antisemitismo economico. In questi autori tra i primi, la polemica antiebraica si sgancia da motivazioni e giustificazioni teologiche – pur riprendendone quasi inavvertitamente alcuni motivi, rimobilitandone per alcuni aspetti l’archivio – e si lega a una critica della religione prima e in genere della società contemporanea poi, nelle sue supposte tendenze degeneri, rappresentate emblematicamente, se non ispirate, dagli stessi ebrei.
Allo stesso tempo Voltaire e Marx appartengono, secondo vari interpreti, a una costellazione di voci, autori, testi che pongono nello stesso periodo la questione ebraica in termini analoghi, spesso ispirandosi a vicenda, comunque influenzandosi, e certamente garantendo la trasmissione e diffusione di determinate interpretazioni: di un nuovo o rinnovato archivio. Nel caso degli illuministi, oltre e prima di Voltaire – con gli scritti che si leggono oggi come una postuma voce, Juifs, del suo Dictionnaire philosophique1 –, va considerato il Montesquieu delle Lettere persiane e dello Spirito delle leggi, e il D’Argens delle Lettres juives. Tutti si occupano della ostinata sopravvivenza delle credenze religiose degli ebrei e dello stesso popolo ebraico. Molti degli argomenti che essi utilizzano provengono dall’archivio teologico antigiudaico, dei Vangeli e dei Padri della Chiesa. In Voltaire, seppure usato talora in chiave ironica, si incontra l’intero repertorio tardoantico e medievale sugli ebrei: dal loro legalismo religioso (con aspetti considerati barbarici come la circoncisione), all’attaccamento al denaro, fino alla rappresentazione animalizzata e al sospetto di sacrifici umani. Secondo alcuni interpreti si tratta di una critica generale alla religione; secondo altri di una critica al cristianesimo attraverso un attacco al giudaismo che l’ha generato; altri vi leggono l’anticipazione del più virulento antisemitismo politico moderno2. Altri ancora, infine, ritengono che gli ebrei siano per Voltaire il luogo dove studiare e criticare la persistenza da un lato e la malleabilità dall’altro dell’umanità, in definitiva una dimostrazione della perfettibilità umana3. Secondo questa stessa interpretazione gli ebrei costituivano una sorta di «schermo opaco» su cui «gli scrittori dell’Illuminismo potevano proiettare le loro fantasie». Allo stesso tempo erano percepiti come ampiamente conosciuti e familiari attraverso secoli di dispute teologiche. «Le tracce di questa eredità possono scorgersi nel fatto che filosofi anticristiani continuavano a ricoprire di antichi insulti cristiani gli ebrei, chiamandoli ostinati e letteralisti» e desiderando persino la loro conversione. In genere gli illuministi chiedevano agli ebrei cambiamenti radicali, in sostanza l’abbandono della propria fede e del proprio particolarismo: «Tuttavia poiché gli ebrei erano allo stesso tempo simboli in esercizi intellettuali sulla perfettibilità umana e veri esseri umani che abitavano la Francia [...] quest’attività altrimenti astratta avrebbe potenzialmente potuto produrre conseguenze reali e concrete»4. La pratica discorsiva e ideologica antiebraica sarebbe divenuta, quindi, nel dibattito sull’emancipazione degli ebrei in Francia, richiesta concreta di conversione o ammissione ai diritti di cittadinanza condizionata all’abbandono della propria appartenenza particolare. L’archivio antiebraico diveniva allora politica concreta, concretamente discriminante o perlomeno azzerante le diversità.
Nel caso di Marx e del suo scritto sulla questione ebraica, esso per molti versi costituisce un intervento più occasionale di altri che appartengono alla medesima costellazione ideologica, sono prodotti nello stesso periodo, esprimono posizioni più radicali veicolati in discorsi più virulenti. Si pensi all’Alphonse Toussenel di Les juifs, rois de l’époque, del 1844, antisemita tradizionalista, ruralista e anticapitalista; o più tardi al Proudhon che nei suoi taccuini accettava l’accusa antigiudaica di deicidio, considerava gli ebrei una razza asiatica e giungeva a invocarne lo sterminio5. Marx stesso, in un’analisi dei temi dell’emancipazione sociale e politica e di quella umana, criticava il pregiudizio religioso e la separatezza ebraica, l’egoismo e il legalismo ebraico, il «Dio geloso di Israele». Affermando di criticare «l’ebreo reale», riproponeva luoghi tipici dell’archivio antiebraico di matrice innanzitutto religiosa, e individuava nel superamento di supposte caratteristiche ebraiche della società moderna la premessa alla sua emancipazione:
Qual è il fondamento mondano del giudaismo? Il bisogno pratico, l’egoismo. Qual è il culto mondano dell’ebreo? Il traffico. Qual è il suo Dio mondano? Il denaro. Ebbene, l’emancipazione dal traffico e dal denaro, dunque dal giudaismo pratico e reale, sarebbe l’autoemancipazione del nostro tempo6.
«L’emancipazione sociale dell’ebreo – concludeva Marx – è l’emancipazione della società dal giudaismo». La soluzione era dunque anche per Marx la scomparsa dell’ebraismo.
Anche in questo caso l’apparire degli «ebrei» offriva una sorta di «‘strumento metonimico’ necessario allo svolgimento del discorso filosofico»: qui «sul tema dell’alienazione»7. Altri, attraverso un’interpretazione retorica e psicologica, hanno insistito su questa funzione di «dispositivo retorico» della questione ebraica in Marx, che avrebbe anzi una ben più antica radice espressa, ad esempio, nel teatro rinascimentale di Marlowe e Shakespeare.
La Questione ebraica [di Marx] rappresenta lo sviluppo ottocentesco di un’idea o meglio di un tropo tardo cinquecentesco. Marlowe e Marx si impadroniscono dell’ebreo come una sorta di potente dispositivo retorico, come modo di organizzare un profondo odio popolare e di chiarirne l’oggetto. L’ebreo è accusato non di devianza razziale o di empietà religiosa, ma di un crimine economico e sociale. [...] Entrambi gli scrittori sperano di focalizzare l’attenzione su un’attività che è vista allo stesso tempo come estranea e tuttavia centrale alla vita della comunità e di dirigere contro quell’attività i sentimenti antisemiti del pubblico8.
Ma vi è anche chi ha ricordato come in brevi, influenti righe, Marx riproponga la contrapposizione radicale elaborata dall’antigiudaismo tardoantico tra il cristianesimo «spirituale» e l’ebraismo «carnale»: riattivando e perpetuando così uno dei luoghi più duraturi e fecondi dell’opposizione del cristianesimo all’ebraismo9.
2. Marr, Drumont, «Civiltà Cattolica»
Gli ultimi tre decenni dell’Ottocento rappresentano il momento di fondazione del moderno antisemitismo politico propriamente inteso. Una serie di passaggi storici in diversi contesti nazionali portano, per cause non legate alla questione ebraica, al riemergere, alla riformulazione e al consolidamento di retoriche antiebraiche. Questi passaggi generano «momenti antisemiti»10, che generalmente confermano come l’antisemitismo abbia a che fare innanzitutto con le società in cui esso nasce e si manifesta, delle cui tensioni e contraddizioni e dei cui scontri l’ebreo diviene oggetto simbolico. L’unificazione tedesca e le tensioni politiche, sociali e religiose dell’età bismarckiana; la sconfitta della Francia nel 1870 e la Comune di Parigi; il completamento dell’unità italiana con la presa di Roma e il confinamento politico-diplomatico della Chiesa cattolica nelle mura del Vaticano, determinano tensioni e reazioni che trovano nella questione ebraica – per alcuni esponenti politici, scrittori o aree politiche o culturali – uno dei luoghi di coagulo. Pensiamo ai movimenti politici nazionalisti e cristiano-sociali in area tedesca e austriaca, alla cosiddetta destra rivoluzionaria che inizia a emergere in Francia negli anni Ottanta, alle campagne di stampa della «Civiltà Cattolica» contro gli ebrei come rappresentanti dei mali della modernità.
Per il particolare contributo che diede alla pratica discorsiva antiebraica, dei molti esponenti e movimenti antisemiti di area tedesca e austriaca che iniziano a fiorire e prosperano in questo periodo e fino ai primi del Novecento – da Stoecker a Fritsch, da Dühring a Lueger11 –, citeremo qui Wilhelm Marr, cui è stata attribuita la paternità del termine stesso «antisemita». Marr rappresenta in genere un nuovo antisemitismo laico e una transizione da una concezione confessionale a una razziale della questione ebraica. Essa si trasmetterà poi dentro il Novecento attraverso un’ulteriore radicalizzazione da parte di figure come Theodor Fritsch, l’autore del Antisemiten-Katechismus (Catechismo antisemita) (1887), edito dal 1907 con il titolo Handbuch der Judenfrage (Manuale della questione ebraica), che fu riconosciuto da Hitler come una importante fonte di ispirazione12.
Uno dei motivi per cui Marr avrebbe introdotto il termine «antisemitismo», fondando una Lega «antisemita» nel 1879, sarebbe stato quello di voler utilizzare un vocabolo non religiosamente connotato, che slegava cioè la polemica antiebraica da un’interpretazione religiosa – a lui estranea – insistendo piuttosto sulla contrapposizione razziale tra «semitismo» e «arianesimo»13. L’affermazione del termine si dovette tuttavia probabilmente a fonti diverse, tra cui il suo utilizzo, in quello stesso 1879, in un articolo dello storico Treitschke, e soprattutto la promozione nel corso dell’anno successivo di una «petizione antisemita» indirizzata al Parlamento tedesco e a Bismarck per la limitazione dei diritti civili degli ebrei. «Prima della fine del 1880, e cioè in poco più di un anno, il termine è diventato di uso comune [...]. Nel 1881, escono diversi libri che recano il nuovo termine come titolo, e nel 1884 esce addirittura la prima storia del ‘movimento antisemita’ in Germania»14. In un certo senso, permanendo in effetti qualche incertezza sull’origine del termine e sulle modalità della sua diffusione, si potrebbe suggerire che esso sia almeno in parte un vocabolo «senza autore», che si afferma – se vogliamo rifarci di nuovo a Foucault – presso autori o in testi diversi, da cui viene appropriato e riutilizzato, talora anche con interpretazioni contrastanti.
Oltre a vocaboli e a testi senza autore, vi sono in ogni caso, nell’archivio antiebraico, molti autori certi e riconosciuti. Secondo alcuni l’autore principale, se non il fondatore dell’antisemitismo politico, non fu un tedesco o un austriaco, ma un giornalista francese, Édouard Drumont15. Si tratta di uno degli ideologi della destra rivoluzionaria e certo di uno dei maggiori propagandisti dell’antisemitismo forse di tutti i tempi, se si considera che la sua opera più nota, La France juive, edita per la prima volta nel 1885, aveva raggiunto la duecentesima edizione nel 1914 e che dovettero vendersene centinaia di migliaia di copie nel corso di alcuni decenni (assieme a versioni ridotte e a diverse altre opere polemiche sugli stessi temi, in svariate edizioni). Certamente La France juive, con cui Drumont affrontava in prospettiva «storica» i problemi della società francese contemporanea denunciandone la «giudaizzazione», costituiva un luogo di collezione, riformulazione e riproposizione di temi, intrecci, simboli dell’archivio antiebraico e, specificamente, un tentativo di amalgama e unificazione delle tradizioni dell’antigiudaismo cattolico, dell’antisemitismo economico anticapitalista e dei nuovi discorsi razzista e socialdarwinista applicati al contesto francese. Se si scorre il copioso indice dei nomi dei due volumi dell’opera, le fonti di que...