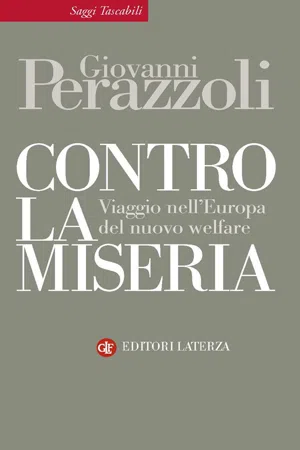1. Le due Europe
L’Italia restò purtroppo indifferente dinanzi a questo progredire sociale
Giuseppe Penso, in «Socialismo», 1945
1. Utopia e alibi
Già nel 2000, dunque ben prima della crisi economica di questi anni, il 56% dei giovani adulti italiani viveva con i propri genitori, mentre in Francia erano solo il 20% e nei paesi del Nord Europa il 10%. Esiste dunque un’antropologia specificamente italica di «bamboccioni»? Forse no; la realtà è che i giovani nordeuropei hanno certamente più opportunità di lavoro, ma sono anche tutelati, oltre che dalla famiglia, anche dal welfare, ovvero dal reddito minimo garantito. Più lavoro e vero welfare sono correlati. Il welfare ha una grossa parte nell’accrescere le opportunità di lavoro nonostante il margine di disoccupazione volontaria che produce.
Il quotidiano britannico «The Guardian» (19 settembre 2012) scopre con sorpresa che, come suona il titolo dell’articolo, Un terzo degli italiani adulti vive con i genitori. L’articolo riporta il «bamboccioni» imprudentemente riferito dal ministro Tommaso Padoa-Schioppa ai giovani adulti italiani. Dallo stupore del giornale britannico emerge però, involontariamente, l’altro paradigma. Dal punto di vista britannico c’è infatti solo una spiegazione al fenomeno dei «bamboccioni», e il sottotitolo lo dice chiaramente: i tagli al welfare (benefit cuts). Gli adulti, ovvero i giovani, tornerebbero a casa dai genitori perché, improvvisa «The Guardian», «non hanno altra scelta, data l’alta disoccupazione e i tagli al welfare per i disoccupati». Tagli al welfare per i disoccupati? Attenzione, cari amici inglesi, rileggete il filosofo David Hume. Che fine ha fatto la vostra tradizione empirista? Bertrand Russell non aveva spiegato che se su 100 abitanti di un villaggio 99 si chiamano Smith non è detto che tutti si chiamino Smith? È proprio questo il caso: il fatto che in molti paesi europei esista il welfare per i disoccupati non implica che esista in tutti. «The Guardian» evidentemente non può neanche immaginare che in Italia i giovani non possano lasciare la casa dei genitori grazie al welfare, e che non ci sono mai stati tagli al welfare per i disoccupati, per la semplice ragione che non c’è mai stato un welfare per i disoccupati, e quello che non c’è non può essere tagliato. Anzi, è vero addirittura il contrario: recentemente è stata estesa a più lavoratori una rudimentale indennità di disoccupazione. Ma i benefit a cui si riferisce «The Guardian» non sono l’indennità di disoccupazione, bensì le misure di reddito minimo garantito che in tutta Europa sono una cosa molto seria.
Più empiristi, a sorpresa, i tedeschi. Il giornale liberale e conservatore «Frankfurter Allgemeine Zeitung» è più in sintonia con la realtà del Belpaese; e con l’aria di voler sorprendere i lettori scrive (3 marzo 2010): Keine Sozialhilfe in Italien. Potremmo tradurre così: «In Italia non c’è un welfare per i disoccupati». Secondo l’autore dell’articolo, «dal punto di vista italiano» la Germania è «il paese della cuccagna» (das Schlaraffenland): infatti «in Italia non c’è mai stata alcuna forma di welfare per i disoccupati (Sozialhilfe)». Ci sono dei sussidi per i disoccupati (Arbeitslosengeld), ma, scrive l’editorialista, «solo in una forma rudimentale». E dunque? «Poiché manca il welfare, deve supplire la famiglia». In Italia, scrive il giornale tedesco, si preferiva andare in pensione a 50 anni. Inoltre, i «sussidi di disoccupazione per tutti» (Arbeitslosengeld für alle) sono «indesiderati dal punto di vista politico».
Si giudica per paragoni e confronti. Ma l’Italia si confronta con difficoltà con gli altri paesi europei. In generale, i paesi europei si confrontano poco tra loro: manca un’opinione pubblica europea. D’altra parte, la letteratura scientifica parla agli specialisti, il suo compito non è quello di permettere a tutti di farsi un’idea concreta delle forme di reddito minimo garantito europee, della loro diffusione e quotidianità. Inoltre, espressioni come «esclusione sociale», «reddito di sussistenza», «lotta alla povertà» fanno pensare, senza un adeguato contesto, a sussidi marginali per i casi di «povertà assoluta». Pensiamo a strumenti per l’eccezione, non per la normalità. Non pensiamo, in altre parole, che un diciottenne di famiglia medioborghese possa andare a vivere da solo grazie al welfare. Ma è questo che invece accade nell’altra Europa. Osservare questi strumenti di welfare non solo nei libri, ma anche direttamente all’opera nei paesi che li adottano, è davvero un’esperienza impressionante. Vista la potenza e l’estensione del welfare, di quello vero, ci si chiede subito perché non se ne sappia niente da noi. Per dirla senza perifrasi: in Italia non ci si rende conto della colossale importanza che ha il vero welfare.
Prima di procedere vediamo che cosa si deve intendere con l’espressione «reddito minimo garantito». Dal 1992 l’«Europa ci chiede», come riportato testualmente dalla raccomandazione 92/441 Cee pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale», «l’introduzione [...] di un reddito minimo garantito», universale e illimitato. Per questo, o anche per questo, useremo l’espressione «reddito minimo garantito», e non, ad esempio, «reddito di cittadinanza», o «reddito di inserimento», «minimo vitale», «reddito di ultima istanza». Un’espressione vale l’altra purché si definisca di che cosa si parla. L’espressione «reddito minimo garantito», oltre ad essere più utilizzata, ha il vantaggio di essere ideologicamente neutra e quindi più utile a un confronto con le misure di tutela del reddito adottate in Europa. Indica semplicemente una serie di misure che garantiscono a chi cerca un lavoro di non cadere al di sotto di un minimo vitale. Trattandosi di misure che non esistono in Italia (vedremo perché non si possono confondere con la cassa integrazione o con gli altri sussidi che sono estremamente limitati nella durata, riservati a una platea ristrettissima, discrezionali e corporativi) evidentemente non c’è neanche un nome che le possa rappresentare. Ad esempio, «sussidio di disoccupazione» ferma alcuni aspetti, ma è equivoco e parziale. D’altro canto, «reddito di cittadinanza» indica un reddito per tutti e incondizionato. In Italia di solito, quando non si confonde il reddito minimo garantito con i sussidi di disoccupazione (limitati e corporativi), lo si confonde con il reddito di cittadinanza: o si sbaglia per difetto oppure per eccesso.
Gli aspetti essenziali del reddito minimo garantito sono: a) il carattere illimitato nella durata del sussidio (dura tanto quanto dura la ricerca di un lavoro, anche diversi anni); b) la sua universalità condizionata solo dalla disponibilità a cercare un lavoro e dall’accertamento dei mezzi (non bisogna essere ricchi per averne diritto, ma neanche essere «poveri» e non è necessario fare riferimento a intermediari politici o sindacali).
Per queste misure di tutela del reddito ogni paese ha la sua denominazione: Jobseeker’s Allowance nel Regno Unito, Revenue solidarité active in Francia, Arbeitlosengeld II in Germania, ecc. Le denominazioni colloquiali sono: the dole nel Regno Unito, Hartz IV in Germania, chômage in Francia. Molto diffuso nella stampa di lingua inglese è riferirsi a queste misure di tutela del reddito con la parola «benefits», al plurale, benefici. Qui useremo «reddito minimo garantito» soprattutto nel senso generale di benefit, intendendo quindi anche gli assegni per l’alloggio, per i figli, ecc. Non bisogna pensare dunque al reddito minimo garantito semplicemente come a un assegno mensile. Sarebbe fuorviante limitarsi a dire, ad esempio, che in Germania il «reddito minimo garantito» è di 380 euro al mese, senza aggiungere che con questi soldi il disoccupato non ci deve pagare l’affitto per l’alloggio (perché per l’affitto c’è un altro sussidio), oppure senza spiegare che la cifra si riferisce al disoccupato single, e non ad una famiglia (più è grande, più aumenta il sussidio). Bisogna notare, inoltre, che mentre in Italia con «welfare» s’intende soprattutto riferirsi alle pensioni e alla sanità, nei paesi nordeuropei ci si riferisce più spesso proprio ai benefit contro la disoccupazione. Per questo si può sentir dire, ad esempio, che quella tale persona «vive solo di welfare» (come scrive «The Guardian», i giovani adulti tornerebbero a casa in conseguenza dei «tagli al welfare»). In Italia «welfare» significa in determinati contesti «piena occupazione»; ma la piena occupazione nasce con il complemento dei benefit: il fatto che in Italia questo aspetto manchi è molto indicativo.
Quando dunque parliamo di «disoccupazione europea» dobbiamo capire che stiamo mettendo in un’unica pentola realtà diversissime. Sotto lo stesso titolo vengono catalogate, da una parte, la disoccupazione che lascia qualche soldo sicuro in tasca ogni mese, la sicurezza dell’alloggio e degli assegni per i figli, e, dall’altra, la disoccupazione di chi finisce sotto al ponte, o, nella migliore delle ipotesi, di nuovo a casa con mamma e papà. Ma alla luce di quello che vedremo (e che sorprenderà), i dati sulla disoccupazione dei diversi paesi europei dovrebbero essere letti in modo diverso, e, per l’Italia, in modo più drammatico. Se si confrontano le economie di due paesi a partire dai dati della disoccupazione, ma non si mette nel conto che in uno c’è il reddito minimo garantito, o, come dicono gli inglesi, i benefit, e nell’altro no, il confronto risulterà evidentemente falsato. In Italia il problema della disoccupazione è quello brutale dell’Inghilterra, ma di quella ottocentesca, la disoccupazione che non porta il pane in tavola.
Come non può non «interrogarci» il fatto che in Italia si consideri un’utopia quello che in Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio e in altri paesi è realtà da decenni? Il reddito minimo garantito è una realtà così ovvia in Europa che, come abbiamo visto, nella stampa britannica si attribuisce, come si dice oggi, «di default». L’utopia, al contrario, è una forma politica e sociale irrealizzabile, che, come dice l’etimologia, non esiste in nessun luogo. Ma il reddito minimo garantito esiste dietro l’angolo di casa, nel nostro stesso contesto politico europeo. Un tempo c’era l’«utopia socialista», che riguardava il mondo comunista, il quale non solo era diverso dal modello economico e politico occidentale, ma era anche nemico di questo. Nel caso del reddito minimo garantito l’«utopia» appartiene, invece, al cuore dell’Occidente, alla vecchia Europa. È l’Italia l’eccezione, non il contrario. Non si può utilizzare l’alibi (secondo l’etimologia: alius ibi, l’«altro da qui», l’«essere altrove») che è qualcosa che non ci riguarda nella misura in cui «non accade da noi ma da un’altra parte»: infatti, rispetto al reddito minimo garantito non ci troviamo in un «altrove» ma, al contrario, più che mai dentro il modello sociale occidentale europeo. Ad essere «altrove» in questo caso è l’Italia.
Anche l’obiezione più immediata al reddito minimo garantito, quella che riguarda i costi, dovrebbe tener conto di questo dato di realtà. Non si tratta di un’utopia, evidentemente, perché quello che è reale è anche possibile. Ma interessante è notare che la quasi totalità dei paesi che adottano forme di reddito minimo garantito – la Francia, la Germania, il Regno Unito, il Belgio, l’Olanda, la Danimarca, l’Austria, il Lussemburgo, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia... – non solo non sono schiacciati da un debito pubblico enorme e insostenibile, ma è vero proprio il contrario: ad essere in crisi è il nostro debito pubblico. Se poi, sempre seguendo la linea dei confronti, considerassimo che l’altro paese in Europa che non ha il reddito minimo garantito è la Grecia, e se ricordassimo che anch’essa ha un enorme debito pubblico, saremmo persino tentati di stabilire una connessione – forse un po’ unilaterale, ma non priva di ragioni – tra l’alto debito pubblico e l’inesistenza di un reddito minimo garantito. Il Portogallo e la Spagna, che restano sotto il tacco della crisi di questi anni, hanno una forma di reddito minimo garantito molto modesta; in Spagna è frammentata, differente da regione a regione. L’Irlanda, che invece sta uscendo dalla crisi, ha un reddito minimo garantito sconcertantemente generoso, anche se con una tassazione molto bassa. L’Irlanda spende meno, ma meglio.
In Italia c’è più assistenzialismo che redistribuzione. Il welfare moderno, quello vero, è universalistico: è redistributivo più che assistenzialista; non individua infatti categorie, ceti, gruppi, territori, amici, famiglie, zie e nipoti, ma determina un diritto. Non prevede intermediari che accrescono il loro potere distribuendo favori. Non è pensato come una rendita, proprio perché non è clientelare o corporativo.
Un sistema universale di welfare crea più autonomia, maggiore disponibilità al rischio d’impresa. Inoltre, fatto questo essenziale, poiché limita il clientelismo, aiuta la trasparenza democratica. La democrazia implica un welfare universale. Che, peraltro, fa anche risparmiare. Se, infatti, l’universalità del welfare regolata per legge è una grandezza finita, lo stesso non può dirsi per il bisogno di consenso ottenuto attraverso il clientelismo.
Il confronto con gli altri paesi lascia emergere allora una realtà del tutto capovolta rispetto all’utopia. Ciò non toglie però che dobbiamo fare i conti con un contesto politico e culturale che associa al...