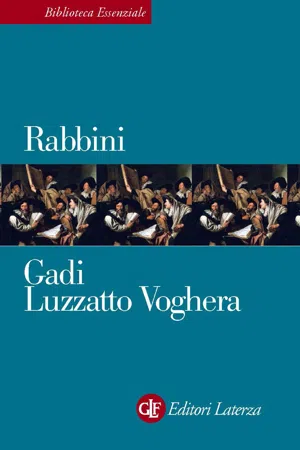
- 150 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Rabbini
Informazioni su questo libro
Sapere giuridico, pensiero filosofico e scientifico, creatività letteraria, custodia della tradizione: le competenze dei rabbini sono tante, si tramandano e si trasformano nel corso dei secoli.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
Teologia e religioneCategoria
Religioni comparateCapitolo 1.
Dalle origini all’eclissi del rabbinato
Non è concentrando la nostra attenzione sull’origine linguistica del termine rabbino che riusciremo a fare chiarezza a proposito della complessità delle funzioni, delle competenze, delle attribuzioni che nel corso del tempo e in differenti aree geografiche vennero via via assegnate a questa figura essenziale per la comprensione della storia e della tradizione ebraica. E tuttavia non sarà inutile indicare alcune possibili tracce che ci aiuteranno a identificarne le varie fasi di trasformazione e di adattamento. Prendiamo quindi le mosse dalle lingue semitiche in generale, in cui la radice RBY indica «grande, essere grande». In accadico la radice è vitale dal terzo millennio al I secolo a.C. e prende la forma RBU, da cui deriva l’aggettivo rabû «grande», «essere grande»: per esempio šarru rabû, «gran re». L’aggettivo sostantivato rabû, in stato costrutto rab, associato ad un nome di funzione indica un ufficiale-capo addetto alla funzione stessa: il rab šaqê, letteralmente il «grande delle bevande», è il famoso Gran Coppiere di biblica memoria. In semitico di nordovest, che include l’ebraico, la radice è ben attiva proprio come RBY, che si presenta come verbo in aramaico antico e d’impero; è attestata in due iscrizioni in ebraico e, come sostantivo/aggettivo, in aramaico, e proprio nella funzione di «grande di ... = capo-...», nella Storia di Ahiqar [Hoftijzer, Jongeling, pp. 1054-56]. In ebraico la radice è attiva ma non molto comune, certo oscurata dal successo di gadol e dall’uso parallelo di reš.
Anche nell’ebraico biblico il termine rav si può tradurre con il termine «grande»; tuttavia esso non compare nella Bibbia, non si riferisce comunque a una funzione particolare e ha soprattutto un’accezione quantitativa (molto, ampio). È necessario giungere all’epoca della composizione della Mishnah (I sec. d.C.) per veder utilizzato il termine nel senso di «maestro» e del possessivo Rabbi nel senso di «mio maestro» (rav = maestro + shelì = mio → Rabbi, che quasi sempre compare accentato sulla lettera ì). Probabilmente i testi più precoci in nostro possesso, in cui compare il termine Rabbi in maniera diffusa e precisa, sono i Vangeli di Giovanni, di Marco e di Matteo. Anche se – com’è stato fatto autorevolmente notare [Zeitlin 1968] – il termine nei Vangeli è usato in maniera anacronistica e non risponde all’uso dell’epoca, è comunque da rilevare il fatto che Gesù stesso fosse chiamato Rabbi dai suoi discepoli; di maggior interesse risulta ai nostri fini l’utilizzo che Gesù stesso avrebbe fatto del termine nella sua virulenta polemica riportata in Matteo 23, 1-12 e in particolare nei versi 6-8:
6Si compiacciono [i farisei e gli scribi] dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, 7dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati «rabbì» dalla gente. 8Ma voi non fatevi chiamare «rabbì», perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli.
A prescindere dall’invettiva politico-sociale del verso 8, il testo indica – se letto in prospettiva storica – la presenza di un’istituzione chiaramente riconoscibile nella società ebraica dell’epoca, con posizioni sociali privilegiate (posti d’onore ai banchetti e nelle sinagoghe) e funzioni precise sul piano istituzionale. «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei» (Mt. 23, 2) sono parole che indicano una chiara genealogia, segnalata sia nel primo capitolo del Pirqé Avoth (Mishnah), sia in precedenza nella stessa Bibbia in Deuteronomio 34, 9, quando Giosuè riceve da Mosè l’investitura (letteralmente semikhah, con l’apposizione delle mani sul capo), iniziando con quel gesto una tradizione di passaggio di poteri legata alla residenza degli ebrei in Eretz Israel. Ma quali sono queste funzioni? Le dure parole di Gesù contro «scribi» e «farisei ipocriti» indicano l’esercizio di funzioni legislative e ritualistiche («Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono», Mt. 23, 3), ma anche funzioni religiose legate ai sacrifici nel Santuario di Gerusalemme. Che si trattasse di un termine utilizzato prima o dopo la distruzione del secondo Tempio (70 d.C.) ha qui relativamente poca importanza. Di maggior rilievo è invece il significato da conferire alla parola Rabbi che, alla luce di quanto detto, non si limiterebbe a un semplice appellativo possessivo (mio maestro), ma sarebbe un vero e proprio sostantivo, con funzioni e caratteristiche ben precise, una procedura di investitura e un ruolo nella società ebraica dell’epoca.
È tuttavia sulle funzioni politiche e giuridiche che è necessario fare chiarezza, ed è quindi importante ragionare almeno a grandi linee a proposito della lunga storia conflittuale fra il potere secolare e la leadership spirituale nel mondo ebraico dei primi secoli successivi alla distruzione del Tempio di Gerusalemme [Zeitlin 1940]. All’epoca del secondo Tempio esistevano numerose fonti distinte di potere (il re, il gran sacerdote, il profeta e l’anziano, con diverse gradazioni di forza a seconda dei periodi); in questo contesto era già assai visibile il contrasto fra una leadership legata alla stirpe davidica (e quindi di matrice secolare) e una legata alla funzione sacrale del sacerdozio presso il Santuario ricostruito. Per lunghi secoli prevalse nei fatti una guida legata all’attività del Tempio, ma i conflitti fra le due entità rimasero ben vivi. I grandi sacerdoti erano spesso disprezzati e vilipesi dagli studiosi, dai periti della Legge, e perfino fra il popolo la loro reputazione non era elevata. Tuttavia all’epoca della rivolta antiromana del 65 d.C. dopo i primi momentanei successi militari, la leadership del governo provvisorio veniva affidata al gran sacerdote Ananus, cui veniva affiancato quale comandante in seconda Shimon, figlio di Gamliel e presidente (Nasì) del Sinedrio. L’ultima autorità governativa ebraica in Palestina prima della distruzione del Tempio venne quindi condivisa dal potere secolare e da quello sacerdotale, e fu anche l’ultima occasione di quest’ultimo, costretto dagli eventi politici e militari a perdere ogni forma di autorità riconosciuta. Fu quindi la perdita di indipendenza con l’inizio del secondo esilio a determinare la definitiva ascesa degli studiosi, dei maestri: ma non chiamiamoli ancora rabbini perché non abbiamo ancora chiaro chi e cosa rappresentino sul piano istituzionale.
Dopo il 70 d.C., con la fine – che solo ora sappiamo definitiva, ex-post – di una pseudo-indipendenza politica e giuridica e di un’autonomia nell’esercizio del culto divino presso il Santuario di Gerusalemme, la civiltà ebraica subisce una trasformazione epocale. Israele diviene una società fondata sul Testo e sulla sua interpretazione, da cui si produce un corpus legislativo generalmente accettato e riconosciuto. Ma si apre anche un periodo durato molti secoli (ben oltre la canonizzazione del Talmud di Gerusalemme e del Talmud babilonese) in cui dominano la confusione e spesso il conflitto. In questo contesto assume sempre più consistenza e visibilità l’autorità delle accademie rabbiniche e dei maestri, dei saggi che in esse si esercitarono e vennero formati. «Il soggetto della loro formazione era il testo: in primis il suo significato, a seguire la sua applicabilità in presenza di condizioni ideali (cioè come se il Tempio ancora fosse in attività e si fosse governati dal re), ed infine la sua applicazione nelle reali condizioni del mondo, con un’Israele costretta all’esilio. In tal modo i maestri governavano sia nel mondo immaginario, sia nel presente, come filosofi e come giudici» [The Jewish Political Tradition, p. 247].
Il nostro occhio di osservatori della società ebraica dei primi secoli della nostra era può tentare di farsi un’idea delle forme di autorità politica, giuridica e religiosa che ne caratterizzavano il governo in una realtà di esilio non omogeneo, ma appare chiaro fin da subito che mancano alcuni elementi fondamentali che ogni studioso dovrebbe avere a disposizione in abbondanza e con possibilità di scelta: le fonti. Nonostante la grande quantità di studi che riguardano la vita dell’Israele biblico e post-biblico, ci si rende conto con un certo imbarazzo che la maggior parte di questi (anche rinomati testi universitari) si basano in buona sostanza sull’analisi – accorta e puntuale, spesso svolta con acume – di quegli stessi testi della Tradizione orale che rappresentano il prodotto della medesima società, e che vengono alternativamente utilizzati come fonte storica, linguistica, giuridica, letteraria. Arnaldo Momigliano rilevava con allarme «l’attuale svalutazione del concetto di prova [evidence] e della corrispondente sopravalutazione della retorica e dell’ideologia come strumenti per l’analisi delle fonti letterarie» [Momigliano]. Allo stesso modo, la discussione è aperta e accesa sulla possibilità stessa di considerare la Mishnah e i due Talmud come fonti storiche utilizzabili nell’ottica di una autorappresentazione anche solo parzialmente attendibile. Di principio la questione non dovrebbe neppure essere posta, per motivi meramente cronologici e metodologici: è semplicemente impensabile e illegittimo attribuire a testi, tratti da tradizioni orali prodotte in un arco temporale che va dal I alla fine del V secolo della nostra era, dei propositi di narrazione e interpretazione della realtà anche solo assimilabili a quelli di una moderna composizione storiografica. Persino testi coevi che apertamente si autodefinivano narrazioni storiche (si pensi ad esempio alle Guerre giudaiche di Flavio Giuseppe) sono continuamente messi in discussione nella loro qualità di opera storiografica pura. Contengono certo elementi utili allo storico per ricostruire un contesto e per ottenere preziose informazioni, ma necessitano di incroci e conferme con altre fonti documentarie, e non sempre tali fonti sono a nostra disposizione. I prodotti delle culture altre (non ebraiche), e le testimonianze archeologiche, apportano sì tasselli utili ad approfondire la nostra conoscenza, ma non sono al momento sufficienti a costituire una base documentaria tale da consentirci di fare chiarezza sulla realtà giuridico-istituzionale dell’ebraismo di quell’epoca.
Ma allora di cosa stiamo parlando? È pensabile che una società complessa come quella dell’Israele dell’esilio (primo e secondo), con una lunga e articolata storia che si svolge lungo oltre due millenni interessando l’intero globo terracqueo, non riesca a fare chiarezza sull’origine e sulla funzione di una delle sue istituzioni fondamentali quale è il rabbinato? E rimane effettivamente valida, e per quanto tempo, e in quali condizioni, l’ipotesi considerata generalmente attendibile secondo cui la storia istituzionale di Israele si fonda sul contrasto fra la leadership secolare e quella spirituale [Zeitlin 1940]? E che ruolo ha il rabbino in questo confronto?
Prendiamo le mosse da una prima considerazione di fondo: nel periodo che va dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme (70 d.C.) alla definitiva codifica della Torah orale con la chiusura canonica del Talmud (V sec. d.C.) la posizione dell’«erudito», del «saggio», del «maestro», cioè di colui che conosce a sufficienza la Legge per poter essere nominato giudice e avere l’autorità necessaria a emettere sentenze, inizia il suo percorso come autorità secolare, a volte antisacerdotale, e termina tale percorso con un ribaltamento di posizione finendo col prendere il posto dei sacerdoti stessi (pur se non formalmente). L’ambiente da cui emerge questa nuova figura è indubitabilmente quello dei Farisei.
È l’esistenza stessa di una legge a far nascere il bisogno di una sua conoscenza professionale [Schürer, vol. II, pp. 394 sgg.], e la figura del conoscitore della legge è istituzionalmente legata in Israele alla nascita dei tribunali e all’istituzione del Sinedrio. Presentare questo particolare tipo di tribunale e le funzioni che assolse nel corso dei secoli richiederebbe una trattazione a parte; ai fini del nostro studio è comunque necessario segnalare il fatto che – pure se non costantemente – anche i suoi membri vennero a volte chiamati con l’appellativo di Rabbi.
Di certo, all’epoca del Sinedrio questo titolo non era codificato e non indicava in alcun modo una funzione fissa e riconosciuta, mentre certamente già andava assumendo un peso rilevante nella società ebraica la figura dell’esperto nella Legge, che prendeva variamente anche alternative denominazioni, quella ebraica di moréh (maestro), a volte quella aramaica ´abbah. Siamo quindi in presenza di una figura essenziale per il funzionamento di una società che andava elaborando un’importante giurisprudenza, che veniva continuamente sottoposta a dure prove da numerose fonti di stress: il potere secolare dominante (Roma dal I sec. a.C.) che concedeva solo una parziale autonomia giurisdizionale agli ebrei; la presenza del Tempio di Gerusalemme e dei Sacerdoti, che rappresentavano certamente il centro ispiratore della giurisprudenza ebraica stessa, ma che spesso tentavano di allargare la loro sfera di influenza su di un piano più propriamente politico; la popolazione civile (specie quella di Galilea) che «da sempre passava per essere poco fedele alla Legge» [Stemberger, p. 24]; e infine i numerosi e articolati gruppi che costituivano la società di Israele e che conformavano la propria condotta quotidiana come singoli e come comunità secondo principi e interpretazioni della legge spesso piuttosto difformi fra loro.
Farisei, sadducei, zeloti, esseni, comunità di Qumran, samaritani, e in seguito caraiti e paleocristiani, formavano una società complessa nella quale la figura del giudice non sempre aveva l’effettiva forza politica e giuridica per imporsi. Da questa situazione piuttosto confusa, sulla quale gli storici tentano di fare chiarezza ma senza disporre di un sufficiente corpus di fonti utilizzabili in concreto, nella prospettiva di un arco temporale di alcuni secoli emerge – prendendo le mosse in gran parte dall’ambiente degli scribi – la figura del rabbino. Una figura che va progressivamente caratterizzandosi attorno ad alcune categorie che ne istituzionalizzeranno la funzione per un periodo piuttosto prolungato.
Pur se la prospettiva disegnata dovrebbe risultare, se non chiara, almeno comprensibile, non ci possiamo permettere di ipotizzare una forma istituzionale universalmente riconosciuta nel mondo ebraico successivo alla distruzione del Tempio di Gerusalemme: sussisteranno per molti secoli profonde differenze nelle funzioni assunte dai rabbini in diverse aree geografiche. E tuttavia siamo in grado di fissare alcuni punti comuni che diventeranno importanti nel disegnare la forma delle nuove comunità ebraiche della diaspora.
Innanzitutto le attività dei rabbini, sia quelle legate all’insegnamento, sia quelle giudiziarie, dovevano essere svolte in forma gratuita. «Colui che trae profitto dalle parole della Torah rimuove la propria vita dal mondo» (Mishnah, Avoth 4.5). Non abbiamo fonti sufficienti per sapere se e come questa prescrizione venisse rispettata o meno; di certo ne comprendiamo le ragioni più profonde in rapporto all’attività giudiziaria, mentre sembra difficile che l’insegnamento venisse svolto sempre in forma gratuita. Nel Talmud babilonese (Tb, Nedarìm 37a) si distingue – per quanto concerne l’insegnamento – fra l’attività di miqrà (compitazione del testo biblico, per cui è permessa la retribuzione) e quella di midrash (interpretazione, per cui è vietata). Rimane comunque un dato di fatto che il rabbino come figura professionale sottoposta a contratto non compare se non nel Medioevo, e che è senz’altro comune la figura del rabbino che svolge oltre allo studio anche una normale attività lavorativa non legata alla sua funzione. Carpentieri, calzolai, tessitori, portatori d’acqua, contadini: sono solo alcune delle molte attività professionali esercitate dai rabbini che compaiono nelle fonti talmudiche. Una situazione certo non facile, a volte sottolineata criticamente come si può intendere dalle parole di R. Yehudah bar Alay che si lamentava (Tb, Berachoth 35b) di come i tempi fossero mutati, per cui mentre nelle precedenti generazioni i rabbin...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Ringraziamenti
- Capitolo 1. Dalle origini all’eclissi del rabbinato
- Capitolo 2. La rinascita in età medievale
- Capitolo 3. La definitiva affermazione di una struttura istituzionale
- Capitolo 4. Emancipazione, fra crisi e rinnovamento
- Appendice
- Figure di rabbini italiani
- Riferimenti bibliografici
- L’autore
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Rabbini di Gadi Luzzatto Voghera in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Religioni comparate. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.