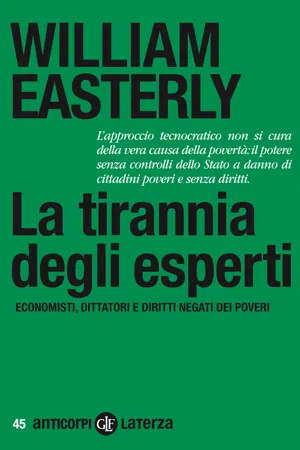1.
Introduzione
I contadini della contea di Wood, nelle campagne dell’Ohio nordoccidentale, non avevano avuto il minimo sentore di quello che stava per succedere. I soldati erano arrivati la mattina del 28 febbraio 2010, mentre gli abitanti erano in chiesa. Sentendo gli spari, tutti erano corsi alle loro case, ma le avevano trovate già avvolte dalle fiamme. Mentre una parte dei soldati impediva di andare a spegnere l’incendio minacciando i contadini con i fucili, altri versavano benzina sui cereali da poco raccolti e stipati nei fienili, appiccando il fuoco anche a quelli. Un bambino di otto anni rimase intrappolato dentro e morì bruciato. Le mucche da latte furono eliminate in modo più umano e sbrigativo, con una sventagliata di mitra. Poi i soldati portarono via a forza gli oltre ventimila abitanti. Non tornate mai più, gli dissero: la terra non è più vostra.
I contadini, che in molti casi possedevano quelle terre da generazioni, scoprirono che un’azienda britannica si stava impadronendo dei loro campi con il sostegno dell’esercito. L’obbiettivo della società era farci crescere sopra una foresta e poi vendere il legname. I contadini rimasero ancora più sgomenti quando vennero a sapere che il progetto della società britannica era stato finanziato e promosso dalla Banca mondiale, un’organizzazione internazionale che ha il compito di combattere la povertà nel mondo. L’operato della Banca mondiale non è soggetto alle leggi o ai tribunali dell’Ohio o degli Stati Uniti.
I contadini cercarono di far sapere quello che era successo, sperando che il clamore li aiutasse a rientrare in possesso delle loro terre. E in effetti, un anno dopo, la Oxfam, un’organizzazione britannica per la difesa dei diritti umani, pubblicò un rapporto su quanto avvenuto nella contea di Wood nel febbraio del 2010. Il 21 settembre 2011 il «New York Times» pubblicò un articolo sulla faccenda. Il giorno dopo la Banca mondiale promise di aprire un’inchiesta. Quell’inchiesta non c’è mai stata.
Nel momento in cui viene scritto questo libro, a più di cinque anni dalla tragedia, quasi più nessuno si ricorda dell’accaduto, tranne le vittime, che continuano a chiedersi perché nessuno si sia preoccupato della loro sorte.
I diritti dei ricchi e dei poveri
È una storia vera? Verissima, tranne per un dettaglio geografico: gli eventi raccontati non si sono svolti nella contea di Wood, in Ohio, ma nel distretto di Mubende, in Uganda. La Banca mondiale aveva promosso quel progetto di silvicoltura per accrescere i redditi, ma i contadini di cui la Banca aveva calpestato i diritti non figuravano tra i beneficiari. La storia che abbiamo raccontato non avrebbe mai potuto aver luogo in Ohio, perché lo sdegno sarebbe stato tale da garantire giustizia per le vittime e punizioni per i responsabili.
Quando Thomas Jefferson, nel 1776, scrisse la dichiarazione di ideali politici più famosa della storia, elencò gli oltraggi del re d’Inghilterra contro i propri sudditi americani: «Egli ha saccheggiato i nostri mari, devastato le nostre coste, ha bruciato le nostre città, ha distrutto la vita della nostra gente». Le parole che seguono avevano lo scopo di impedire soperchierie di tale portata:
Noi teniamo queste verità come di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono creati eguali, che sono dotati dal loro creatore di certi diritti inalienabili, e che tra questi ci sono i diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Che per garantire questi diritti i governi sono istituiti fra gli uomini, derivando i loro giusti poteri dal consenso dei governati.
Ideali simili vennero successivamente proclamati in altre nazioni occidentali. Per esempio, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea nazionale della Francia rivoluzionaria il 26 agosto 1789, voleva
esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo [...] Gli uomini nascono e restano liberi ed eguali nei diritti [...] La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri.
Queste aspirazioni di libertà venivano da popoli poveri. I francesi nel 1789 e gli americani nel 1776 avevano un reddito medio pro capite più o meno analogo a quello degli africani di oggi. La Banca mondiale ha la sua sede in Occidente e molti dei suoi dirigenti e dipendenti condividono questo sogno, a livello personale. Eppure l’organizzazione di cui fanno parte non lo formula esplicitamente per quanto concerne il cosiddetto «terzo mondo» o «paesi meno sviluppati», la parte del pianeta di cui si occupa.
La Banca mondiale non può evitare interamente di parlare della natura del governo nell’ambito dello sviluppo, e pubblica rapporti su questo tema (quello che ormai da anni indicano con il termine vago di governance). Un esempio recente (del 2007) di questi rapporti della Banca mondiale recita così:
Per mettere in pratica l’approccio rafforzato alla governance [...] è necessario [...] elaborare con cura un [...] quadro dettagliato di risultati, una valutazione delle implicazioni in termini di budget e organico [...] e ulteriori consultazioni con le parti interessate. [...] Le iniziative specifiche necessarie per rendere pienamente operativa questa strategia saranno delineate nel Piano di attuazione.
In questo «approccio rafforzato alla governance» un ruolo limitato, se non proprio inesistente, è riservato a concetti come libertà, uguaglianza, diritti o democrazia. Non sono omissioni casuali: al contrario, sono da sempre la norma nei rapporti della Banca mondiale. Quando il sottoscritto ha chiesto perché la parola democrazia venisse sistematicamente omessa nei rapporti e nei discorsi ufficiali dell’organizzazione, l’ufficio stampa ha risposto che è lo statuto stesso della Banca mondiale a vietare di usarla. Capiremo più avanti, ripercorrendo la storia dell’organizzazione fin dagli anni Quaranta, cosa si nasconda dietro a questa curiosa e importante affermazione.
L’indifferenza verso simili ideali è esemplificata dall’evasività con cui la Banca mondiale ha respinto ogni responsabilità per la distruzione delle case di contadini poveri come quelli di Mubende. Ed è esemplificata anche dall’evasività linguistica dei suoi rapporti, con espressioni come «approccio rafforzato alla governance» e «valutazione delle implicazioni in termini di budget e organico». I contadini di Mubende hanno buoni motivi per dubitare che la definizione di «uomini che nascono liberi ed eguali nei diritti» includa anche loro.
L’illusione tecnocratica
L’approccio convenzionale allo sviluppo economico, agli sforzi per rendere ricchi i paesi poveri, si fonda su un’illusione tecnocratica, e cioè la convinzione che la povertà sia un problema eminentemente tecnico da risolvere attraverso soluzioni tecniche come fertilizzanti, antibiotici o integratori alimentari. Lo vediamo nel comportamento della Banca mondiale a Mubende, e lo vedremo più avanti nell’operato di altri organismi che lottano contro la povertà nel mondo, come la Gates Foundation, le Nazioni Unite e le agenzie per gli aiuti allo sviluppo di Stati Uniti e Gran Bretagna.
L’approccio tecnocratico non si cura di quella che in questo libro è indicata come la vera causa della povertà: il potere senza controlli dello Stato a danno di cittadini poveri e senza diritti. Per esempio, è vero che nel distretto di Mubende le tecniche di silvicoltura più avanzate offrivano una soluzione alla povertà, ma non per i contadini del posto. L’illusione che il problema fosse di natura esclusivamente tecnica ha distratto l’attenzione dalle violazioni dei diritti dei contadini commesse dall’esercito ugandese e dalla Banca mondiale.
Per il tramite di questa illusione, i tecnici, senza volerlo, conferiscono nuovi poteri e nuova legittimazione allo Stato in quanto entità incaricata di applicare le soluzioni tecniche. Gli economisti che patrocinano l’approccio tecnocratico hanno una visione terribilmente ingenua del potere: sono convinti che allentando, o addirittura rimuovendo, i vincoli che lo delimitano, il potere resterà benevolo.
Quello che un tempo era il diritto divino dei re, nella nostra epoca è diventato il diritto di sviluppo dei dittatori. La visione implicita negli ambienti dello sviluppo, al giorno d’oggi, è quella di autocrati benintenzionati consigliati da tecnici esperti: in questo libro chiameremo questa visione sviluppo autoritario. La parola tecnocrazia (sinonimo di sviluppo autoritario) è stata coniata all’inizio del XX secolo e ha il significato di «governo degli esperti».
Il gioco di prestigio che porta a focalizzare l’attenzione sulle soluzioni tecniche, occultando le violazioni dei diritti della gente reale, è la tragedia morale dello sviluppo odierno. I diritti dei poveri (per esempio il diritto dei contadini ugandesi a non vedersi la casa data alle fiamme dall’esercito) sono già di per sé un fine morale da perseguire. Non esistono approcci moralmente neutri alla povertà. Qualsiasi approccio allo sviluppo o rispetta i diritti dei poveri oppure li viola. Non è possibile sottrarsi a questa scelta morale facendo appello a «politiche non ideologiche basate sui dati» (un’espressione molto in voga oggi nel campo dello sviluppo).
Lo sviluppo autoritario è una tragedia anche sul piano pragmatico. La storia e la moderna esperienza indicano che gli individui liberi dotati di diritti politici ed economici – la visione che qui chiameremo sviluppo libero – rappresentano un sistema efficacissimo per la risoluzione dei problemi. Lo sviluppo libero ci dà il diritto di scegliere fra una miriade di risolutori, ricompensando quelli che sono in grado di risolverci il problema. Questi risolutori pubblici e privati ottengono risultati di gran lunga migliori rispetto ai dittatori che mettono in pratica soluzioni fornite da esperti. Come vedremo, lo sviluppo libero fornisce il grasso per lubrificare la ruota che cigola, lo sviluppo autoritario quella ruota la mette a tacere (magari con incursioni della polizia e condanne al carcere).
L’illusione tecnocratica è che la povertà sia frutto di una carenza di competenze, mentre in realtà nasce da una carenza di diritti. Concentrarsi così tanto sul problema delle competenze non fa che rendere ancora più grave il problema dei diritti. I problemi tecnici dei poveri (e l’assenza di soluzioni tecniche per essi) sono un sintomo della povertà, non una causa. Questo libro sostiene che la causa della povertà è l’assenza di diritti politici ed economici, l’assenza di un sistema politico ed economico libero capace di trovare le soluzioni ai problemi dei poveri. Il dittatore a cui gli esperti si affidano per applicare rimedi tecnici a problemi tecnici non è la soluzione: è il problema.
Autoritari anonimi
Ho dichiarato qual è la tesi che verrà sostenuta in questo libro. Ma questa potrebbe essere completamente sbagliata: servirà un intero libro per valutare se la moralità, la teoria e l’evidenza dimostrino o meno l’esistenza di una tirannia degli esperti.
Le persone che sostengono gli autocrati nel campo dello sviluppo non considerano l’autocrazia uno scopo da perseguire di per sé. Credono sinceramente che le autocrazie siano in grado di garantire l’uscita dalla miseria in tempi più rapidi dei sistemi liberi. Sono convinti che gli esperti che consigliano gli autocrati sanno come risolvere i problemi dei poveri meglio dei poveri stessi. Potrebbero anche aver ragione: d’altronde, esistono esempi di sviluppo economico in assenza di diritti individuali, e spesso gli sforzi individuali (sia tra i ricchi sia tra i poveri) vanno incontro al fallimento. La tesi pragmatica in favore dello sviluppo libero (contrapposto allo sviluppo autoritario) spesso sembra contraddire quello che intuiamo.
Un concetto diffuso tra gli studiosi dello sviluppo, ormai da decenni, è quello dell’«autocrate benevolo»: secondo questa visione, anche se un leader gode di un potere senza limiti si dà per scontato che sia animato da buone intenzioni nell’usarlo. A lui (perché l’autocrate è quasi sempre un uomo) non serve altro che il consiglio degli esperti per realizzare qualcosa di positivo. Quando poi qualcosa di positivo si realizza effettivamente in un paese governato da un regime autocratico – per esempio una crescita economica elevata o rapidi miglioramenti della situazione sanitaria – il merito va al dittatore. I risultati positivi sono interpretati come dimostrazione concreta della benevolenza dell’autocrate. È possibile che sia vero (è possibile che ci vogliano davvero un autocrate per fare le cose, evitando le situazioni di stallo che produce la democrazia), ma andrebbe quantomeno dibattuto. Ed è quello che farò in questo libro.
Il sostegno a un approccio autoritario allo sviluppo a volte non è dichiarato, ma implicito. Spesso risponde a motivazioni altruistiche e non egoistiche. Il più delle volte non è intenzionale. Non esiste nessuna cospirazione contro i diritti e provo simpatia verso quegli economisti che, nella loro smania di aiutare i poveri del pianeta, favoriscono senza volerlo l’autocrazia, perché per molto tempo sono stato uno di loro.
La storia dell’idea autoritaria
Questo libro racconta la storia dello sviluppo autoritario. Vedremo che un dibattito fra sviluppo autoritario e sviluppo libero in realtà c’è stato. Ma per i teorici dello sviluppo che presero il sopravvento negli anni Cinquanta, il dibattito si era già concluso, e si era concluso in favore dell’approccio autoritario. Voci eloquenti, come vedremo, hanno continuato a perorare la causa dello sviluppo libero, ma gli esperti del settore ormai non le stavano più a sentire. E non le stanno a sentire nemmeno oggi.
Per capire come sia potuto succedere tutto questo, dobbiamo risalire indietro nel tempo, prima della data considerata come l’inizio ufficiale del concetto di sviluppo, il 1949, quando Harry Truman annunciò il varo di un programma statunitense per l’assistenza ai paesi esteri, e scopriremo una storia dello sviluppo più vecchia di alcuni decenni, una storia che ben pochi conoscono e che si svolge in p...