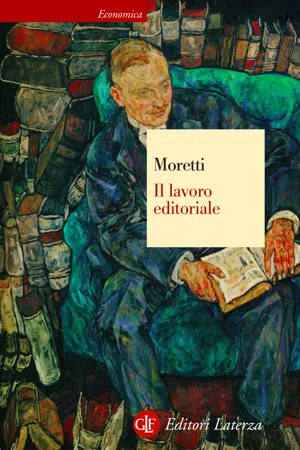
- 110 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il lavoro editoriale
Informazioni su questo libro
A trarre giovamento dalla lettura di questo libro non saranno solo coloro che vorrebbero 'lavorare in una casa editrice' (i quali scopriranno che oggi si lavora 'per' una casa editrice) ma anche gli aspiranti scrittori, i quali scopriranno che per fare un libro non basta scriverlo. Paolo Vinçon, "L'Indice"Da Gutenberg ai nostri giorni, l'editoria ha conosciuto numerose rivoluzioni. Oggi sembra a molti che stia vivendo una svolta fatale. Dario Moretti ce ne parla con chiarezza, in modo informato, aggiornato e completo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il lavoro editoriale di Dario Moretti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Contabilità e budget. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Contabilità e budget1. Creazione o prodotto?
Un oggetto di piacere
Leggere un libro (un bel libro) è un piacere formato da una somma di piaceri diversi. Al centro c’è quello più forte: la gratificazione consistente nello scoprire punti di vista nuovi o valori condivisi espressi con parole efficaci, la sensazione di capire un poco di più una parte del mondo. È la sostanza di ogni libro e la prima motivazione di ogni lettore, da quello che le statistiche definiscono «occasionale» (uno-due libri l’anno) a quello che si fregia della qualifica di «forte lettore»; anche se, come sempre nel mondo della statistica, si tratta di forza non necessariamente di pensiero, ma semplicemente di consumo.
Intorno a questo nucleo, per fortuna di chi va a caccia di piaceri, si allargano come cerchi concentrici altri godimenti libreschi, di cui ciascuno è partecipe secondo le sue inclinazioni personali, la sua fisionomia psicologica, i suoi tic.
Per esempio il piacere di guardare e toccare il libro. Piacere visivo offerto dall’allinearsi delle righe nella pagina e dalla nitidezza dei caratteri, dall’equilibrio tra spazi bianchi e caratteri neri: confrontare l’edizione tedesca e quella italiana di uno stesso libro fa balzare agli occhi la differenza del gusto medio dei lettori dei due paesi. Piacere tattile di passare le dita sulla pagina: i tecnici parlano di mano della carta, usando lo stesso termine che i sarti usano per definire le qualità di una stoffa. Per non parlare del piacere olfattivo: odore della carta e dell’inchiostro da stampa. Un piacere più raro, un tempo mitizzato dai giornalisti dei quotidiani, per i quali l’odore dell’inchiostro fresco si identificava con il sospirato termine del lavoro notturno.
In un cerchio ancora più esterno c’è il piacere (sadico) di collezionare i libri, con la corrispondente blanda perversione dell’incapacità di disfarsene anche se li si considera ormai poco significativi per il proprio itinerario intellettuale: l’antologia di letteratura latina del liceo, la versione purgata e mal tradotta dei Tre moschettieri... Collezionismo e piacere fisico sono forze tanto potenti che, negate, possono guastare anche il piacere intellettuale del contenuto: come nel caso del professor Peter Kien, il bibliomane protagonista di Auto da fé (Die Blendung, 1935-1963) di Elias Canetti (1905-1994), che possiede venticinquemila libri conservati in una biblioteca feticisticamente ordinata:
[...] Si recò impettito, con passo tremante, nella terza stanza e trasse da uno scaffale I pantaloni del signor von Bredow. Possedeva quel libro fin dai primi anni di scuola; a quell’epoca l’aveva prestato a tutti i suoi compagni di classe e da allora non l’aveva più potuto soffrire per il cattivo stato in cui gliel’avevano ridotto.
Infine c’è lo squisito piacere di frequentare le librerie, anch’esso diffuso in una versione positiva – l’amichevole consuetudine con un certo libraio-consigliere, in una sorta di raffinato rapporto sociale simile a quello del gourmet con il suo salumiere di fiducia – e in una versione perversa ma non rara: quella di chi, pur abitando in una grande città con molte librerie, acquista libri solo da una perché delle altre non si fida; trascurando che, nella storia degli oggetti, i libri sono stati tra i primi a raggiungere gli alti livelli di standardizzazione richiesti dalla produzione industriale, e quindi sono identici a se stessi, da qualunque dettagliante vengano acquistati. Si ricorda anche il caso di chi, pur potendo far acquistare a metà prezzo i romanzi che gli interessavano da un parente impiegato in una casa editrice, preferiva pagarli a prezzo intero perché non resisteva alla tentazione e al piacere dell’acquisto immediato in libreria.
E le librerie, del resto, si frequentano anche come negozi di articoli da regalo: un libro regalato è un piacere intellettuale per chi lo sceglie e spesso perfino per chi lo riceve; è un simbolo di condiviso livello culturale che gratifica donatore e ricevente; è un omaggio tanto più raffinato perché la sostanza del regalo sono le idee. Anche se proprio immateriale non è: circa un terzo del fatturato delle librerie italiane si realizza nel periodo natalizio; e, in generale, da un’indagine-campione del 1995 è risultato che il 38,6 per cento dei cittadini italiani con più di 15 anni d’età (in proiezione 18.776.000 persone) erano entrati di recente in libreria per acquistare un libro da regalare (Indagine sulla lettura di libri in Italia, Doxa-Il Sole 24 Ore, elaborazione Ufficio studi AIE). Il che è un altro indicatore di un aspetto cruciale: il libro è fatto per trasmettere idee, ma è un oggetto.
Operazioni occulte
Il piacere di leggere un libro è fatto di molti piaceri intrecciati; ma mentre il primo, fondamentale, dipende dall’autore e dal suo modo di scrivere, gli altri hanno a che fare con il libro come oggetto fisico e come oggetto di scambio e di possesso, cioè come merce: una parte importante della presenza del libro nella nostra vita dipende da come esso viene prodotto e messo in commercio.
Il fatto più curioso è che quando l’incontro intellettuale con l’autore avviene, scocca una scintilla che mette in ombra la fisicità e gli aspetti percettivi e produttivi del libro. Come nel caso di un’esecuzione musicale entusiasmante, il contatto con l’autore prevale su tutto: si ascolta Paganini, non si pensa, se non a margine, al costruttore del violino, all’impresario che ha organizzato il concerto, al proprietario della sala. Solo se qualcosa non funziona (in sala si soffoca, sono stati venduti più biglietti dei posti disponibili, l’acustica è pessima, l’esecutore stona) la carica di materialità dei mezzi espressivi e delle forme organizzative torna prepotentemente – e sgradevolmente – alla ribalta.
Così se un libro è carico di errori di stampa, o composto con caratteri illeggibili, o difficile da trovare in libreria, la trasparenza che permette il contatto diretto con le idee dell’autore si annulla. Come l’illusione teatrale può fallire miseramente per colpa di un cattivo regista, così la magia del libro svanisce se una delle componenti del lavoro editoriale è scadente. E, all’inverso, come una buona regia porta alla riuscita dello spettacolo senza che il pubblico si accorga che una regia esiste, così l’approdo ideale del lavoro editoriale è la trasparenza. Il lavoro editoriale opera per passare inavvertito agli occhi dei lettori, pur essendo – anzi, proprio perché è – onnipresente.
Non c’è libro se non c’è pubblico
La ragione e il peso di questa onnipresenza nascosta non si comprendono se non si legge il mondo del libro rovesciando quello che in apparenza è il suo principio fondamentale: la centralità dell’autore. È il lavoro editoriale stesso, nella sua tensione a celarsi agli occhi del lettore, che promuove l’immagine di questa centralità: tutti i segni – dal nome in copertina al sistema dei premi letterari, dai talk shows televisivi alle pagine culturali dei quotidiani – proclamano e rafforzano l’idea che un libro viene pubblicato perché un individuo, l’Autore, vi esprime un pensiero importante e degno di essere diffuso.
Il che è quasi vero. È una concezione mutuata dal mondo della ricerca, in cui l’editoria libraria ha il suo punto di riferimento d’origine. Un ricercatore (accademico o solitario, professionista o eccentrico) fa una scoperta e la trasmette al mondo; la dignità di questa operazione è intrinseca alla scoperta, si giustifica da sé. Ma la diffusione del pensiero avviene inevitabilmente nel contesto di tutti quegli aspetti fisici, percettivi ed economici che caratterizzano il piacere della lettura: le idee, anche quelle buone, non si possono diffondere in modo coatto, ma solo per via di persuasione. E si è persuasi a venire in contatto con un’idea anche dal proprio libraio e – perché no? – dal buon odore della carta.
Quindi, diversamente da quanto accade nel campo della ricerca, la figura di riferimento del lavoro di diffusione delle idee (di cui il lavoro del libro è stato per almeno tre secoli una componente dominante) non è quella dell’autore, ma quella del pubblico. Un libro nasce e circola solo perché esiste un pubblico che, più o meno coscientemente, sente l’esigenza di venire in contatto con le idee dell’autore.
Sulla capacità di intuire l’autenticità di un’esigenza del pubblico, e non sulla capacità di distinguere autori buoni da autori meno buoni, si gioca prima di tutto la scommessa di ogni editore. Il percorso della storia dell’editoria è lastricato dei cadaveri di editori geniali che, con istinto da ricercatori, anticipavano splendide idee di cui il pubblico non sentiva l’esigenza; e di questo sublime peccato sono professionalmente morti. In termini meno drammatici, anche le vicende della casa editrice Einaudi negli anni Ottanta non andrebbero interpretate solo come l’assalto di un’editoria tutta imprenditoriale all’editoria pura, di cultura. Molto più concretamente occorre leggerle in termini di cambiamento del pubblico dei lettori italiani e di inadeguatezza del modo tradizionale di raggiungerlo. Il lavoro culturale di un editore consiste nel capire per tempo la cultura dei lettori, anche quando essa non si evolve nella direzione che l’editore, come uomo di cultura, preferirebbe.
Libri, automobili, frullatori
In tempi di polemiche sull’Auditel come strumento di orientamento dei programmi televisivi si potrebbe giudicare questa affermazione viziata dalla cultura del marketing, cioè troppo appiattita sulla soddisfazione dei capricci immediati del pubblico; mentre si tratta piuttosto di una posizione di sgradevole realismo. Come sgradevolmente lucide sono le parole pronunciate in un’intervista con Giancarlo Bosetti, A scopo di lucro (1995), da un manager, Franco Tatò, all’epoca amministratore delegato del Gruppo Mondadori:
[...] ritengo che l’editoria sia una forma di business come può essere quella dell’automobile, del frigorifero o di altri beni di consumo durevoli. Se qualcuno, per esigenze sue che possiamo definire culturali, ovvero propagandistiche o politiche, decide di pubblicare un libro perché a lui interessa propagandare o diffondere determinate opinioni o punti di vista, non sta facendo del business, ma sta facendo un’altra cosa. Diciamo che è un’attività di comunicazione che può essere svolta in un quadro di puri costi, o di costi e ricavi.
Oggi, e non solo in Italia, il lavoro editoriale si sviluppa sempre meno nel primo modo, dove sono però tuttora ben vive varie forme di mecenatismo contemporaneo, dai libri finanziati dagli enti locali – cataloghi di mostre, studi di settore – a quelli finanziati dalle banche – splendidi libri d’arte – a quelli finanziati da imprese pubbliche e private – storia industriale, promozione dell’immagine aziendale. Sempre più prevale il quadro in cui occorre equilibrare costi e ricavi, e il lavoro editoriale assomiglia al lavoro di ogni altra industria: l’editore è un imprenditore che, come ogni altro, «mira al pareggio» del suo bilancio; cioè, senza eufemismi, persegue il profitto.
Come in ogni posizione realistica, tuttavia, tirando le somme si scoprono alcuni motivi di consolazione: il primo consiste nella elementare constatazione che una casa editrice economicamente prospera continua a pubblicare libri, e chi continua a pubblicare libri prima o poi potrebbe perfino pubblicarne di buoni; mentre una casa editrice fallita non pubblica libri né buoni né cattivi.
La seconda consolazione – meno lapalissiana – sta nell’osservare che la specificità del libro come prodotto si va assottigliando proprio a causa dell’evoluzione del pubblico: oggi anche chi acquista un’automobile o un elettrodomestico lo fa più per ragioni di cultura che di funzionalità. La soddisfazione dei bisogni materiali primari nella nostra società fa sì che la diffusione di un oggetto dipenda più che mai dalle idee che esso (libro o non libro) porta con sé agli occhi del pubblico.
Il libro non è più il veicolo privilegiato delle idee, e di qui deriva certo la crisi della sua diffusione (che non significa necessariamente la sua morte); ma di qui deriva anche l’allineamento del prodotto dell’industria culturale al prodotto tout court, cioè la minore specificità del libro, anche dal punto di vista dell’organizzazione produttiva. Oggi tutti i prodotti sono, più che in passato, prodotti culturali; il libro deve affrontare concorrenti che non sono il cd-rom o Internet, ma gli aspirapolvere, i frullatori, gli abiti. Tutti questi oggetti sono oggi anche strumenti di comunicazione, e sempre più spesso soddisfano esigenze culturali che il libro occupava in passato come proprio esclusivo campo d’azione.
Insomma: se è vero che il lavoro editoriale assomiglia sempre più, per graduatoria di valori e obiettivi, al lavoro industriale, è anche vero che il lavoro industriale ha sempre più la fisionomia del lavoro culturale. Il professor Kien ne sarebbe sconvolto; ma dall’apertura delle finestre da lungo tempo murate della sua biblioteca potrebbe entrare nel mondo dei libri parecchia aria fresca.
Profeti loro malgrado e ‘best seller’ per vocazione
Guardare al libro come a un prodotto orientato al mercato non significa metterne in ombra la carica culturale, anzi, aiuta a comprendere meglio i modi in cui oggi la cultura si diffonde. Osservare da vicino il lavoro editoriale...
Indice dei contenuti
- 1. Creazione o prodotto?
- 2. Ruoli e generi dell’editoria libraria
- 3. Bibliografia
- L’autore