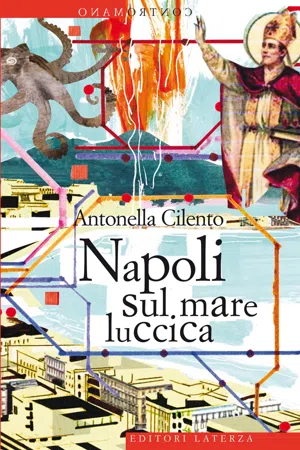
- 158 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Napoli sul mare luccica
Informazioni su questo libro
«Niente di più difficile che cercare di ricostruire unimmagine di Napoli, che di immagini e immaginario è satura, standoci dentro. La miopia impedisce, ostacola la visione. Si può arrivare a una città dal mare come dal cielo, da terra e, persino, da sotterra ma, una volta dentro, si è prigionieri. Napoli è un prisma e riflette tutte le descrizioni, le può restituire moltiplicate.» Un viaggio allinseguimento del fuoco che cova sotto il Vesuvio, dellacqua che luccica nel golfo, sopra e sotto la terra brulicante di traffici, con gli occhi al cielo in una città che è anche simbolo, atmosfera, idea. Con penna lieve, fantastica e pensosa, Antonella Cilento intesse un sortilegio per raccontare i mille volti di Napoli.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Napoli sul mare luccica di Antonella Cilento in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Personal Development e Travel. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Personal DevelopmentCategoria
Travel1. La Cirelonda
Cantavamo spesso da bambine, io e Iole, mia sorella, la celeberrima canzone Santa Lucia insieme alla sigla di un quasi altrettanto celebre cartone animato, Capitan Harlock: «Capitan Harlock zùmzùm, capitan Harlock zùmzùm» e poi, come un’eco, «Harlock... Harlock...».
Sopravvive, di questa sigla cantata a due voci, una vecchia audiocassetta, la prima registrazione ad aria della nostra vita, dove entrambe ci ascoltiamo cantare e poi Iole mi dice, seccatissima: «Non la sai! Non la sai!». Anche Santa Lucia non la sapevo e infatti i versi, cantandoli, si disfacevano grosso modo così:
Sul mare luccica
L’astro d’argento
La Cirelonda sospira il vento
Venite all’accide
Barchetta mia
Santa Luciiiiiiia.... Santaaaaaaaa Lucia!
La Cirelonda, insieme ai nomi di alcuni insetti esotici e alle mangrovie dei fumetti di Mister No, era uno dei nostri misteri d’infanzia. In effetti, non era di Cirelonda che si trattava, bensì di un conio improprio per «l’agile onda», per altro frutto d’invenzione, visto che il noto verso recita «placida è l’onda, prospero è il vento». E anche nel verso successivo nessun «accide» era previsto, piuttosto era la barchetta ad essere «agile». Però, siccome ripetavamo la canzone ascoltando nostro padre e non avevamo mai letto il testo, ecco che era nata, ed è rimasta in me per anni, anche quando l’età proprio non consentiva più certi svarioni, la certezza che Santa Lucia narrasse la storia della Cirelonda.
La Cirelonda era come uno di quei denti da latte che a certe persone non cadono mai, nemmeno con la vecchiaia. Era la nostra personale interpretazione del mare che cambiava, del paesaggio marino: cos’era, dunque, la Cirelonda? Uno scoglio al largo di Capri? Una roccia? Un particolare e prelibato tipo di pesce, come il coccio, che pure era un po’ misterioso come nome: che era? Un pesce di terracotta?
La Cirelonda, specie quando cantavamo a voce spiegata, viaggiando in auto, era una città misteriosa, un accesso proibito, solo nostro, un po’ com’era capitato alla moglie di Gioacchino Murat che si era così innamorata di Napoli da nominarsi duchessa di Lipona, duchessa di un anagramma. Allo stesso modo io e mia sorella eravamo, in qualche modo, cittadine senza titolo nobiliare della città invisibile di Cirelonda, nata da un pasticcio rodariano, da un inguacchio linguistico.
Mi è sempre, perciò, rimasta la sensazione di appartenere a un luogo che sbaglio a nominare, come le sue canzoni tradizionali, di una città che abito con distrazione, pur guardandola tutti i giorni e raccontandola, spesso, in articoli e libri.
Niente di più difficile, dunque, che cercare di ricostruire un’immagine di Napoli, che di immagini e immaginario è satura, standoci dentro. La miopia impedisce, ostacola la visione.
Si può arrivare a una città dal mare come dal cielo, da terra e persino da sottoterra ma, una volta dentro, si è prigionieri. Napoli è un prisma e riflette tutte le descrizioni, le può restituire moltiplicate.
Dei molti accessi che possiamo chiedere – perché va chiesto il permesso d’entrare, come sapevano bene gli antichi: Napoli non è città che si apra, a dispetto delle apparenze, a chiunque –, dobbiamo considerare, oltre ai più evidenti, gli accessi fantastici o gli ingressi che fioriscono per errore.
Se un posto fa paura possiamo entrarci scherzando, senza nostalgie, senza timori e senza pregiudizi.
O forse, dicendo parole magiche e prive di senso.
Cirelonda!
Può darsi che ci vada bene.
Cominciamo, allora, da casa mia.
Abito su una delle colline della città.
Napoli, vista dall’alto, ma anche dal mare, ha due spalle, il Vomero e Posillipo, un retro cui non guarda mai – come noi non possiamo, se non a fatica, vederci la schiena – che è Fuorigrotta, e un fronte marino, dominato in lontananza dal Vesuvio, che occulta a chi guarda interiora corpose, composte di molti quartieri, di cui si dice che si debba aver paura, come del resto noi temiamo di vedere i nostri intestini esposti. Ecco, quindi, che Napoli è un corpo piuttosto strano, somiglia forse a un primitivo organismo marino, tutto bocca, frange e organo escretore.
Può sembrare brutto e informe visto dalla sua periferia o dal buio di un angolo affollato, però non bisogna trascurare il fatto che questo vibrione-città sa essere seduttivo: lunghi capelli scendono dal vulcano verso spalle e seni, che emergono timidi dall’acqua.
Dunque, è una donna. Delle femmine, come di Napoli, qualcuno sostiene che la testa non l’abbiano e del resto, in natura, la testa non è necessaria per vivere, basta avere un centro nervoso che in alcune specie si ritrova anche in prossimità delle frattaglie.
Ma queste sono maldicenze.
Io, di notte, salendo via Orazio, per esempio, la vedo che sorge dalla terra, distesa su un fianco. Ha bracciali di corallo – gli stop delle auto nel traffico – e cinture di teschi alla vita, lunghe chiome corvine irte di antenne televisive, candide zanne, un sesso scuro di polpo e occhi che, per fortuna, non apre, perché sarebbero rossi di brace. È Kalì dalle molte braccia e dai molti seni. È la bellissima dea che uccide danzando a ritmo di reggae e sul suono delle tammorre. È una sirena dal canto mortale, mezzo greco e mezzo neomelodico, la versione cafona della bellissima Lighea che in un racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa parlava il dialetto ionico a un professorino siciliano su una spiaggia isolata.
Ma l’ombra è fugace, subito la sagoma torna a incarnare la sbiadita ma gentile cartolina di un golfo che la speculazione edilizia ha sfigurato. Oppure diventa la Napoli giapponese dell’inverno, con il vulcano imbiancato e le petroliere che prendono il largo, tante maru, come nelle pagine di Mishima.
O anche la Napoli estiva e deserta, la Napoli sfrenata e sporca che gli abitanti non guardano e non conoscono più, poiché ne sono prigionieri.
I napoletani sono condannati a non vedere mai la città tutta insieme: la vista li accecherebbe. Non concepirebbero una sola Napoli, così come la nostra mente non concepisce l’insieme dell’universo. E infatti i napoletani quasi mai lasciano il proprio quartiere, esistono varchi che non attraversano mai.
Della città rifiutata spesso ignorano persino i toponimi.
I dettagli, a Napoli, contano più dell’insieme.
Di fronte alla portineria del mio caseggiato, ad esempio, al termine di una ringhiera fiorita, baluardo incerto al cumulo di spazzatura che si forma quotidianamente sul marciapiede, in corrispondenza della fermata d’autobus, c’è un residuo di battiscopa in marmo bianco che chissà quale sbadato architetto ha lasciato proliferare indisturbato.
Il battiscopa si moltiplica in sei o sette gradini della misura delle scarpe di una Barbie, che riempiono il dislivello fra la fioriera e il selciato vero e proprio. Negli anni, i marmi della fioriera sono stati ripuliti e poi risporcati, l’ingresso al cortile del condominio è stato sbarrato da due piloni riccioluti per evitare che le moto vengano a parcheggiarsi dentro, i fiori sono stati curati e ora c’è una vegetazione molto varia. Fra le piante prospera una misteriosa creatura che fiorisce in rosso con escrescenze simili a spazzolini per pulire le bottiglie. Tutto è cambiato, quindi, ma i piccoli gradini sono ancora lì.
Quando ero bambina e avevo piedi minuti – ma non troppo inferiori agli attuali, porto il trentasei su un metro e settanta, e la domanda, continua, delle mie massaggiatrici è: come fai a reggerti in piedi? Bisogna compensare piedi così piccoli, mi dicono. E io penso: ancor di più occorre compensare in una città così instabile, che i terremoti smottano spesso. Così, rivolgo spesso pensieri incoraggianti ai miei piedi – quando ero bambina, dicevo, saltellavo cercando di far entrare le mie scarpe esattamente in quei misteriosi gradini.
Ma anche allora essi non erano adatti a me, erano stati costruiti per Esseri Invisibili che salivano mentre io non li vedevo, mentre nessuno dei condòmini li vedeva.
Erano forse scale bianchissime per i nerissimi scarrafoni di cui si lamentavano i miei genitori, che, come un mare scuro, la sera aspettavano chi rientrava, retaggio di un tempo in cui via Caravaggio era ancora campagna?
O erano per i topi, le zoccole, che pure si vedevano talvolta scorrazzare in strada? O forse, ancora, per le lucertole che si favoleggiava fossero comparse anche sotto la cappa della nostra cucina, al quinto piano, lucertole piovute dal cielo, dal terrazzo, lucertole volanti, che forse ascendevano fino a noi attraverso questi pochi gradini candidi e inutili?
L’inutilità delle architetture della mia città, persino delle architetture nuove, come quella del mio caseggiato, mi iniziò a colpire allora.
Le case napoletane somigliano ai denti di una vecchia, storti, raggruppati, caduti, sostituiti. O un complesso ingranaggio d’orologio medievale, con tutti i cardini e i meccanismi che s’inseguono e si perdono, un grosso orologio sfasato con fusi orari di diverse epoche e nazioni che vive come un grande corpo barocco, ma di un barocco immaginario, come le Carceri di Piranesi.
Ho impiegato molti anni a farmi una ragione del perché piccole scale inutili, finestre cieche, stradine morte, escrescenze architettoniche assiepate come fioriture selvatiche ed esotiche fossero parte della mia città alla pari dei grattacieli o delle facciate colorate e mediterranee esposte ai turisti.
Perché qui non ci sono esattezze, non ci sono calcoli che tengano. O, per lo meno, i matematici cabalisti che hanno calcolato Napoli si sono lasciati prendere la mano da algoritmi anatomici che ci sfuggono. Perché a noi abitanti, che viviamo al suo interno, accade come per il nostro corpo, che abitiamo tutta la vita e in realtà conosciamo così poco, anche se studiamo medicina, anche se abbiamo l’illusione di averne capito i meccanismi e i flussi e supponiamo di non riceverne più sorprese.
Sulla cima del Vomero, dal piazzale della Certosa di San Martino lo spazio ventoso si apre sulla città e mostra gli esiti di questo misterico progettare: con la sola eccezione dei pazientissimi Romani, che dappertutto costruivano dritti cardi e decumani, di cui Spaccanapoli e via dei Tribunali sono le sole tracce, la città ha rifiutato i tradizionali riordini geometrici.
Si è fatta un baffo della via Toledo aperta dagli Spagnoli o del Rettifilo che il Risanamento, voluto con l’Unità italiana, ha disegnato come una lunga ferita.
Siccome è corpo, soffre dei tagli chirurgici che i razionalisti hanno cercato di applicarle come di violenze allopatiche, reagisce a queste gorgogliando disordinata, come la giungla, che, hai voglia a potarla, ricresce sempre a modo suo.
E a guardarla oggi, specie considerando il denso viluppo di strati, cose e persone formicolanti intorno all’ordinato castrum romano, ci si rende ben conto che persino la linea degli antichi è ormai semi-invisibile e nemmeno è mai stata retta, come quelle segnate a Torino, ad Aosta, a Roma.
A causa del digradare della collina, i decumani napoletani sono frutto di geometria non euclidea, somigliano a una corda per panni troppo carica, alla tonda scriminatura dei capelli disordinati della città, che ora c’è, ora non c’è.
La testa di Napoli è nella sua pancia.
Il corpo della città è così caotico, se osservato dall’interno, guardato dall’età che la città ha oggi, a dispetto dei molti strati sezionati che gli scavi e gli studi ripropongono, delle apparizioni convesse e concave di fette d’epoca mescolate ad altre, che, se da bambina mi meravigliavo delle sorprese barocche della città, per statuto e nascita non lineari, lo stupore oggi è anche maggiore se si considera che persino i nuovi edifici, le architetture giapponesi del Centro Direzionale, non rispondono mai a un criterio uniforme.
Dovunque qualcuno ha costruito terrazzini abusivi, ha rifatto facciate, balconi, finestre, ingressi, stili e colori del caseggiato o del palazzo antico che abita. Anche i cementizi grattacieli rischiano picchi, enucleazioni. In fondo, persino le vele di Secondigliano hanno subito sostanziali modifiche abitative. I grattacieli cartacei di Monterusciello sono stati erosi e reinventati dagli abitanti, virus o par...
Indice dei contenuti
- 1. La Cirelonda
- 2. Fuchèra, fuchèra
- 3. Aquae
- 4. Terra, materia
- 5. In luce et in aere
- 6. A finale
- Ringraziamenti