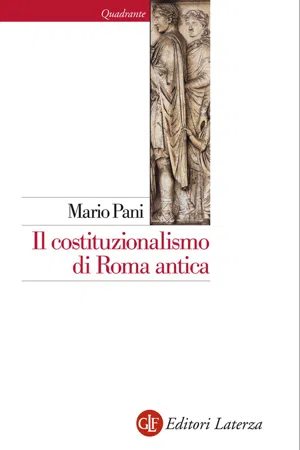
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il costituzionalismo di Roma antica
Informazioni su questo libro
Esiste un 'costituzionalismo' prima delle Costituzioni? Le origini di questo concetto possono essere rintracciate nella Roma antica? Mario Pani individua nelle fonti antiche un vasto repertorio di dati che si pongono nell'area concettuale del 'costituzionalismo' e riservano al lettore più di una sorpresa. Nella Roma repubblicana è possibile riscontrare molta materia che qualifica l'attuale dettato costituzionalistico del mondo occidentale. In una fase di dibattito storiografico sulle matrici, lungo un percorso fra nozioni antiche e moderne, emergono qui i germi della storia di un'idea.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il costituzionalismo di Roma antica di Mario Pani in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia antica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia antica1. La «pólis», la legge, la natura
1. Antigone e Socrate
All’inizio era Antigone. Ogni storia del costituzionalismo comincia dalla giovanetta che Sofocle pose come eroina della resistenza al potere costituito in nome di un’istanza superiore. La vicenda è nota. Creonte, crudele re di Tebe, ha disposto che il defunto Polinice, accusato di aver preso le armi contro la patria, sia lasciato insepolto, ma la sorella Antigone, spinta dall’amore fraterno, lo ricopre di terra. A Creonte che le chiede conto di questa trasgressione al suo pubblico divieto, Antigone risponde con frasi meritamente famose:
Non fu Zeus a imporre a me una tale norma: né Dike, che vive insieme con gli dèi sotterranei, ha stabilito tali leggi per gli uomini; né pensavo che i tuoi proclami avessero tale forza da permettere a un mortale di sovvertire le leggi non scritte, quelle incancellabili degli dèi: esse non vivono da oggi o da ieri, ma da sempre e nessuno sa da quando sono apparse1.
La contrapposizione qui è netta fra legge degli uomini e legge eterna degli dèi; una contrapposizione che avrebbe potuto portare a una frattura teorica in cui la legge stessa degli uomini, che fosse considerata in contrasto con la legge divina, fosse invalidata. Questo passaggio però nella pólis non si ebbe: la contrapposizione anzi non fu vista porsi. Le parole di Antigone restano alquanto isolate nella letteratura greca conservata2.
Il concetto di legge non scritta è per la verità presente e vitale in Grecia: esso, in una prima fase, è ancora rinviato alla razionalità divina, che ne spiega la diffusione fra tutte le genti; in un secondo tempo, in qualche modo laicizzato, il concetto rinvia piuttosto alla razionalità che dal divino trasferisce il protagonismo all’umano.
L’esempio più significativo della prima fase dell’idea di legge non scritta, a parte il caso di Antigone, è concentrato sul Socrate dei Memorabili di Senofonte. Nel dibattito fra Socrate e Ippia sulla giustizia si conviene che le leggi non scritte sono quelle che tutti gli uomini condividono, anche senza essersi accordati fra loro, né avrebbero potuto a causa della diversità delle lingue: dunque queste «leggi comuni» (ad esempio, venerare gli dèi, onorare i genitori, non unirsi fra genitori e figli) non possono essere state date agli uomini che dagli dèi3. Ma qui appunto, e negli altri casi dopo l’Antigone4, non v’è contrapposizione fra legge degli dèi e leggi degli uomini. Anzi Socrate ha, appena prima, concluso che «giusto è ciò che è conforme alle leggi», spiegando che il riferimento è alle leggi della città, quelle, fa dire a Ippia, che «i cittadini hanno scritto, accordandosi fra loro su ciò che si deve fare e ciò che si deve evitare»5.
La visione «laica» delle leggi non scritte la troviamo in Tucidide. È Pericle, nel suo discorso sulle glorie della democrazia ateniese, ad accennare, fra l’altro, alle «leggi che, anche se non sono scritte, per comune consenso minacciano l’ignominia a chi vi deroghi»6. Non ci si sofferma qui, però, sulla loro origine.
Aristotele infine nella Retorica7, in maniera organica, parla di una «legge comune», koinòs nómos, le cui regole, anche se non scritte, sono da tutti accettate. La «legge comune», a tutti nota, è vista ora conforme a natura (non più direttamente data agli uomini dagli dèi), e si accompagna alla legge «positiva», che Aristotele chiama la «legge particolare», quella dei singoli popoli, scritta o non scritta (cioè, in questo caso, consuetudinaria), con la quale si amministrano gli Stati. Anche in questi casi non v’è contrapposizione fra legge scritta e legge non scritta, ma completamento, sussidiarietà: la seconda è semplicemente data come ovvia, già nota a tutti, che non necessita di codificazione8.
Nel portarsi nell’ambito della concretezza dei processi e dell’opera dei giudici, peraltro, l’elaborazione di Aristotele è più tormentata. Egi riconosce delle manchevolezze nelle «leggi particolari» che non si adattino alle cause ovvero siano a volte in contraddizione fra loro; in questi casi il giudice può usare della sua discrezionalità per il miglior giudizio, non attenendosi totalmente alle leggi scritte, e ricorrere al concetto di equità che resta sempre uguale a sé stesso, così come può attenersi alla legge comune, sempre uguale in quanto conforme a natura. Se poi la legge scritta non corrisponde al giusto e all’utile, Aristotele non esita a dire che essa non è legge, in quanto non svolge la sua funzione; al giudice non resta dunque, in questo caso, che – come quando si saggia l’argento – distinguere la giustizia adulterata da quella sana: un primo segno di contrapposizione, questo fra natura e legge, da dover prevedere teoreticamente, ma poi subito abbandonato. Aristotele usa cautela. A volte, se la legge è amibigua, si può vedere come avvalersene adattandola alla situazione reale nel senso dell’utile e del giusto9. Quando sono infine considerate possibili modifiche alle leggi, avverte ancora Aristotele, anche qui si deve procede con «molta cautela»:
Quando l’utile è minimo, siccome è male abituare gli uomini a modificare le leggi alla leggera, è chiaro che bisogna tollerare qualche sbaglio e dei legislatori e dei magistrati, perché l’utile apportato dal mutamento non pareggerà il danno recato dall’abitudine di disubbidire alle leggi10.
In realtà, la legge della città è considerata il punto di riferimento ineliminabile per le coscienze civiche, e per questo la tendenza spontanea è a connetterla senz’altro, di fatto, con la legge di natura. Da questo punto di vista la definizione più incisiva la dà probabilmente Mario Talamanca quando parla per il mondo greco di «concezione più o meno giusnaturalistica del nómos», che collegava la legge «a un ordine dato delle cose»11. Un’interpretazione che si trova già anche in McIlwain quando osserva che, se vi sono negli autori greci naturalmente riferimenti a situazioni «per natura», la legge naturale, mai citata come tale, non è più appunto «che una parte della concreta legge dello Stato»12.
Il diritto di natura non è inteso quindi, di per sé, come un autonomo diritto che detta le regole; l’idea di natura legiferante, è stato detto recentemente, è introdotta solo dagli stoici13.
Se vogliamo capire questo passaggio che collega strettamente (e non contrappone) legge divina e legge di natura alla legge della città, dobbiamo rifarci alle origini dell’idea di legge, sia pure per momenti più rilevanti, da quando almeno si è passati dal thesmós, la legge senz’altro divina, al nómos, che significa insieme consuetudine e legge – questa, nella prima fase, riferita anche, si diceva, all’ispirazione degli dèi. La legge originaria è l’ordine cosmico che regge tutte le cose. Abbiamo a riguardo uno splendido frammento di Parmenide (fine VI/inizi V secolo) che, a proposito alla norma del non uccidere, parla della «legge che abbraccia tutte le cose e si estende attraverso il vasto dominio dell’etere in continuità e attraverso le sconfinate regioni della luce»14.
Qui, in sostanza, la legge divina che tutto abbraccia nutre evidentemente anche le leggi umane, che ne dipendono, legate a quell’ordine.
Ma è forse Pindaro che pose definitivamente il segno del legame fra legge degli dèi e leggi della città con la formula del nómos basileús detto «di tutti gli esseri, mortali e immortali»15, che alludeva quindi alla legge degli dèi, ma che è rimasta poi come definizione topica della concezione della legge della pólis. La trasposizione è già netta in Erodoto allorché fa spiegare dal profugo re di Sparta, Demarato, al re dei Persiani, Dario, che «i Greci non sono liberi del tutto; domina su di loro un padrone: la legge»16; nasce il concetto di nómos despótes che è un’accentuazione del nómos basileús, ciò che polemicamente, nella visione «antistatalista» propria dei sofisti, il sofista Ippia nel Protagora di Platone farà diventare il «nómos týrannos degli uomini»17.
La formula pindarica sulla legge come sovrano incontrò notoriamente fortuna18. Qui vorrei fermarmi su un’espressione di Aristotele che mi pare chiarisca infine concettualmente il passaggio all’assimilazione fra legge divina e legge della città. «Chi raccomanda il governo delle leggi [e chiaramente il riferimento è a quelle della città] sembra raccomandare esclusivamente il governo di Dio e della ragione»; egli si contrappone a chi raccomanda «il governo degli uomini», che obbediscono facilmente alle passioni19. Peraltro, come abbiamo visto, l’idea di ragione porta più espressamente Aristotele a porre la legge non scritta come data per natura.
Il concetto di razionalità della legge aveva essenzialmente il suo padre in Platone che vedeva la legge come realizzazione del lógos orthós, della retta ragione che convince e ordina, ispirata a moderazione e giustizia, immagine della stessa armonia del cosmo, unico signore anzi despótes dei governanti, garantita dalle persone più sagge ed esperte per anzianità; il cittadino perfetto è dunque quello che non deroga dalla sua obbedienza alla legge. Tutto ciò, insieme alla fondamentale continua presenza del livello pedagogico più ancora di quello giuridico, già qualificava, notoriamente, lo Stato platonico come estrema realtà etica20.
L’idea di «retta ragione» avrà anche fortuna, e per primo la fa propria appunto Aristotele che aggiunge, fra gli altri, un elemento di concretezza rilevante. La legge, individuata come una norma razionale che proviene da saggezza e intelletto, ha in sé forza coercitiva21. Nasce il tema della necessità di una forza, quindi un’autorità che abbia la forza di far rispettare le virtù e il giusto insiti nelle leggi, un’idea che ritroveremo nei teorici dello «Stato moderno» come Bodin e Hobbes o nei positivisti come Bentham. Stato etico dunque e Stato anche che non fa sconti neppure alla democrazia, intesa come potere dei più, quando si tratta di affermare la legge; quando non è sovrana la legge non c’è Stato: imperano i demagoghi; un popolo che non è governato dalla legge diventa dispotico; sicché una tale democrazia sarebbe in realtà una tirannide22.
A questo punto, al di là del pensiero – che detta comunque o rispecchia, a suo modo, la percezione comune –, bisogna ricordare le modalità e i contesti fattuali della nascita della legislazione «laica» in Grecia. Essa si forma fra VII e VI secolo come apparato di regole scritte per porre fine alle lotte interne, agli squilibri sociali (siamo nel periodo delle grandi colonizzazioni), e contrastare il sorgere del potere personale tirannico garantendo libertà e uguaglianza. L’isonomía, la legge uguale per tutti, è l’essenza della democrazia nel discorso di Pericle in Tucidide23. La legge dunque contava, oltre che su un potere sanzionatorio, su una forte motivazione solidaristica comunemente sentita, frutto della mediazione sociale per la quale anche era sorta; nello stesso tempo, era posta sotto una sorta di avallo e protezione divina. La legge rassicurava gli dèi «che la comunità avrebbe dato loro quanto dovuto»24. Si giurava sull’osservanza delle leggi25; contravvenire alle leggi significava andare contro la comunità, danneggiare la...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- Introduzione. Il costituzionalismo moderno
- 1. La «pólis», la legge, la natura
- 2. Le strade che portano a Roma
- 3. Il controllo istituzionale
- 4. Lo Stato e l’individuo
- 5. I fondamenti teorici costituzionalistici
- Epilogo
- Riferimenti bibliografici