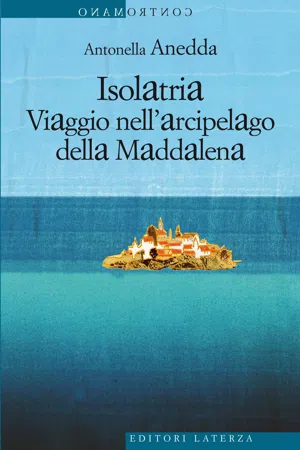1. Avvicinamento
La prima lezione delle isole è che non puoi andartene a piedi. Acqua, aria, vento, onde, corde, bitte, sartie. Devi prendere una nave o un aereo. Devi correre in cerchio come un cane. Conosci la protezione ma anche il massimo dell’esposizione. Circondata da un elemento instabile, il mare, l’isola coincide con le forze opposte del rifugio e della minaccia. Respira con il tempo atmosferico, continuamente disorientata da nuvole, uccelli, traghetti che per una tempesta improvvisa rischiano di naufragare sugli scogli e non riescono ad attraccare nei porti se non dopo lunghe manovre.
La costrizione dello spazio lo dilata, lo spalanca per tutti i quattro punti cardinali, non smette di farci sognare quello che c’è oltre il mare. Da un’isola si immaginano i continenti, le terre distese, percorribili. La costrizione aumenta il desiderio della distanza. Da un’isola il Continente rappresenta la salvezza. Si tocca davvero la terra, una terra ampia che non ha conosciuto lo slittamento, la separazione, ma ha resistito. Non si è sbriciolata.
Avevo questo sentimento quando prendevo il battello da Dover a Calais e arrivavo in Francia. Volendo da lì sarei potuta andare ovunque, solo con i miei piedi: verso Santiago di Compostela e a Finisterre, più a sud in Andalusia, a nord in Bretagna, raggiungere a oriente la Russia e poi, fantasticavo, la Mongolia, il Tibet, la Cina.
L’ammaestramento del paesaggio di un’isola coincide con lo spezzarsi di ogni abitudine. L’orizzonte deve essere ogni volta ridefinito, ogni volta il corpo deve modularsi su uno spazio e un tempo senza certezze. Ogni volta siamo in balia di elementi diversi, di diverse condizioni. Alcune parole che a volte usiamo per la meteorologia possono applicarsi agli stati d’animo: calmo, agitato, sereno. È un ammaestramento di solitudine e, attraverso il vento, di modestia. Il vento ci dice che siamo instabili, che basta una raffica a scardinarci e non siamo al centro di nulla.
Il desiderio dell’isola è proporzionale all’angoscia. È un recinto. Possono colpirti o proteggerti. Lo so, quando sei sul Continente puoi struggerti per quel brandello di pietre sul mare ma quando arrivi, soprattutto dopo una sola notte di tempesta, pensi solo a come andartene. L’isola dice la verità, cioè che torni, ma il tuo luogo non è ancorato a nulla e per scappare devi metterti in acqua o salire nell’aria.
«Sognare delle isole» – scrive Gilles Deleuze – «poco importa se con angoscia o gioia, è sognare che ci si separi, che si è già separati, lontano dai continenti, che si è soli e perduti». Questa solitudine, comune a tutti gli isolani, è inseparabile dalla perdita, dallo sperdersi. La spina è che per quanto ci si perda nell’isola ci si ritrova, si è perduti per gli altri, ma nell’isola non ci si perde, si è, si sta. Vuoi nasconderti? Devi andare all’interno, cercare una macchia, un bosco, una caverna, hai perduto l’orizzonte.
Rileggo queste parole a distanza di due anni e mi accorgo che non bastano a raccontare le isole a cui è dedicato questo libro. Le dipingono soltanto, come una di quelle marine fiamminghe in cui la burrasca e le navi sono immobili. La Maddalena, con il suo arcipelago, ha continuato a sfuggirmi finché non ho deciso di guardare, fotografare, ripercorrere le sue spiagge e le sue strade, finché, anche da lontano, non l’ho ripensata davvero di nuovo. Allora, come succede nelle mattine molto nitide, è apparsa.
Non c’è nulla di più onesto di un resoconto di viaggio. Il procedimento somiglia a una traduzione di servizio. Si traduce il luogo perché qualcun altro si orienti e usi quelle parole per decifrare quanto basta. Anche la noia è contenuta. Non c’è una trama da inventare, non ci sono personaggi memorabili. Quando appaiono, sono semplici comparse, cosa che in fondo corrisponde alla nostra vera realtà. Ci sono gli occhi, i passi, la memoria. Si percorrono di nuovo strade o se ne prendono altre, ma tutto resta attaccato alla terra. Il viaggio basta a se stesso e restituisce chi lo compie abbastanza cambiato da evitare l’arroganza. Viaggiare ci insegna, o almeno insegna a me, che non sappiamo nulla, capiamo poco e avremo sempre da imparare.
La traversata dal Continente alla Sardegna continua a emozionarmi come quando era più lunga e io più giovane.
Anche ora il tempo della nave è lento rispetto al tempo contratto degli aerei, così simile a quello delle anestesie totali. Ci si addormenta e ci si risveglia a New York o a Seoul così come nelle operazioni ci si addormenta e ci si sveglia con il corpo modificato. La nave, invece, concilia il dormiveglia e proprio per questo – soprattutto se il mare è agitato – costringe a prendere coscienza del nostro essere in balia dell’universo, della nostra realtà scossa, non immobile come ci piace credere.
Quando il mare è calmo non c’è nulla di paragonabile allo scivolare del metallo sull’acqua, a quel suono di risalita e affondo. Quando il porto scompare ci sono solo il cielo e il mare uno rovesciato sull’altro.
Con le navi veloci ormai si parte dal Continente all’ora di pranzo e si arriva sulla costa sarda prima delle sette, ma per raggiungere La Maddalena da Roma ci vogliono circa dieci, undici ore – compreso il tratto Roma-Civitavecchia, poi Olbia-Palau e infine, con un altro traghetto, Palau-La Maddalena. È un viaggio lungo, frammentato e abbastanza scomodo, soprattutto se fa caldo e si hanno bambini e bagagli. Forse proprio per questo, anche se sono stata in luoghi molto più lontani, ai miei occhi questa traversata è davvero un viaggio legato a un addio, a un distacco, a un solco che fa percepire, con un misto di esaltazione e smarrimento, l’andare al largo, l’essere al largo.
La trasparenza dell’acqua nei porti sardi fa venire sete. Di tuffo e di nuoto. L’istinto è buttarsi di testa, inghiottire il verde e l’azzurro, percepire le alghe, sentire l’onda provocata dal tuffo nelle orecchie. In quello scendere il tuo io diventa ciò che è: non è importante, sta solo dentro la candela del corpo. Ho delle immagini, non so se è davvero una mia memoria, di tuffi, forse anche allora proibiti, nel mare del porto: si prendeva la rincorsa dal molo e poi, tappandosi il naso, si cadeva nell’acqua arricciando le gambe come rane. Ricordo o credo di ricordare il tonfo del corpo, le onde dure, color lavagna.
Oggi il mare è meno mosso del previsto, dormo dentro una delle sdraio sul ponte, sogno il passato remoto intrecciarsi a quello prossimo, di ieri e su tutto, all’improvviso e senza avviso, l’aria si tinge di minaccia e l’acqua, che sembrava amica, lentamente sommerge la realtà. È pomeriggio, nessuno o pochi, in genere quelli con bambini, prendono la cabina. Si sentono delle grida contente quando qualcuno avvista i delfini. La traversata vera e propria da Civitavecchia a Olbia dura circa quattro ore e mezzo, se il mare è buono.
Quando eravamo piccoli prendevamo il piroscafo per Cagliari, il viaggio iniziava alle quattro del pomeriggio e finiva alle nove dell’indomani. A bordo si veniva ricevuti dal capitano e accompagnati in cabina da camerieri in livrea (le donne in nero e crestina bianca, come usava allora) e tutta la nave aveva l’aspetto di un condominio borghese anni Sessanta. Si cenava (chi non soffriva il mare, come mio padre) in un vero ristorante con i tavoli apparecchiati. A noi la cena era vietata, mia madre veniva colta dalla nausea appena metteva piede sulla nave. Temeva il viaggio. Era convinta che al ristorante avremmo mangiato qualcosa che ci avrebbe avvelenato e l’antidoto era un panino imbottito di acciughe. Inoltre il nostro pediatra le aveva consigliato di somministrarci una supposta (per non rovinarci lo stomaco) che probabilmente evitava la nausea solo perché bruciava tanto da distrarre chiunque e ci costringeva a stare immobili e seduti per attutire quel fuoco. Stremati, a un certo punto ci addormentavamo crollando vestiti sui letti delle cuccette e solo la mattina, svegliati dai rumori dell’attracco, capivamo di essere in salvo. Potevamo andare sul ponte a vedere la città. Era un bel momento. Guardavamo il piccolo rimorchiatore che trascinava la grossa nave verso il molo e il porto, brutto e vivo, con i treni pronti sui binari, poco distanti dai portici. Cagliari allora era ancora segnata dai bombardamenti alleati, c’erano ancora case sventrate e il lungomare non era curato come oggi. Per noi però era il posto delle vacanze, la tregua dei giochi e delle passeggiate al Giardino pubblico e al Buon Cammino, nella parte più alta della città. Esiste ancora una foto in cui io e mio fratello avanziamo tra i piccioni di piazza Martiri presi per mano dalla domestica Micheledda, a servizio da mia nonna fin da quando, ragazzina, era stata sedotta e abbandonata con un figlio che poi le era morto. Vestiva sempre di nero, con una crocchia grigia piena di forcine d’osso. Veniva dal Capodisopra, cioè dal Nuorese, e credo di dovere a lei se capisco il logudorese e un po’ lo parlo.
I piccioni facevano parte della nostra passione per tutto ciò che volava e poteva essere addomesticato. Una volta, non ricordo più in che anno, avevamo portato in viaggio un verdone catturato nella veranda di casa dove era entrato per sbaglio. Forse era fuggito da una gabbia perché si era lasciato prendere senza opporre resistenza ed era entrato docilmente nella nuova gabbia che io e mio fratello eravamo corsi a comprare. Per trasportarlo con noi da Roma alla Sardegna lo avevamo messo in una scatola di scarpe bucata in molti punti per lasciare entrare l’aria, legata con lo spago perché non si aprisse. Lo avevamo sistemato vicino alla cuccetta e ci eravamo sdraiati fiduciosi perché il mare, come aveva detto uno dei marinai, sembrava olio. Sembrava. All’alba, in vista della costa sarda le onde avevano iniziato ad allungarsi e a sollevarsi, le pareti della cabina si inclinavano talmente da scaraventare gli oggetti da un angolo all’altro. Per fortuna non durò moltissimo ma quando arrivammo in porto ci ricordammo di Picchio, così avevamo chiamato il verdone, e aprimmo piano piano la scatola temendo che la traversata lo avesse ucciso. Era invece vivo, ma con le penne arruffate e bagnate. I suoi piccoli occhi neri ci fissavano con un odio talmente schietto da farci ridere, e vergognare.
La Maddalena allora era solo il posto dove era nato, ma mai vissuto, mio padre e dove era nata e vissuta fino a diciotto anni la mia nonna paterna. Immaginavamo quegli scogli come covi di legioni straniere. Sapevamo che dall’arcipelago era facile scappare in Corsica dove non «chiedevano i documenti» ai banditi. Avevo nove anni quando ho visto l’arcipelago per la prima volta. Fino ad allora eravamo andati sempre al sud o sulla Costa orientale. Le scuole iniziavano a ottobre e prima di imbarcarci da Cagliari facevamo sempre un ultimo bagno in un’acqua che non avremmo ritrovato sul Continente. Per anni il distacco dalla Sardegna, dove peraltro non sono nata, è stato traumatico. Tornare a Roma significava: prigionia in casa e a scuola. E poi: vestiti femminili e le regole militari dei miei nonni paterni. In Sardegna invece trionfava una vita più anarchica e libera. Al mare, ma soprattutto nella casa di campagna, potevo girare in pantaloni e maglietta e con una mia amica di allora ci lanciavamo in bicicletta giù da una discesa all’uscita del paese tra il cimitero e il Nuraghe, che è la gloria del luogo. Io guidavo e se ci facevamo male stavamo zitte, disinfettandoci segretamente, perché mostrare graffi e ferite significava essere punite per la disattenzione. «Siete maschi o femmine?» chiedevano le donne del paese, e noi rispondevamo: «Ancora non lo sappiamo».
La Maddalena, insieme al nord della Sardegna, sembrava lontanissima, difficile da raggiungere. Da Cagliari bisognava attraversare tutta l’isola e poi imbarcarsi da Palau. Allora i traghetti non erano frequenti. Le navi erano piccole e fragili. Le poche macchine venivano imbracate e legate con delle corde che sembravano sempre sul punto di sciogliersi, rendendo il viaggio avventuroso e precario. Per noi e in base alle testimonianze di mia nonna, maddalenina di origine corsa, quell’isola non era sarda, ma francese, raffinata e allo stesso tempo democratica, molto diversa dall’aristocrazia hidalga di Cagliari e da quella barbaricina di Nuoro.
A un certo punto, i miei decisero che le vacanze le avremmo d’ora in avanti trascorse alla Maddalena. Non fu data alcuna spiegazione, ma era il periodo dei sequestri, la famiglia aveva fama (infondata, ma tenace) di ricchezza. Se ci avessero rapiti, dicevano, non saremmo riusciti a pagare il riscatto. Mio nonno, che allora aveva più di settant’anni e come avvocato aveva difeso anche molti banditi, aggiungeva che il codice d’onore barbaricino era cambiato e ora rapivano anche donne e bambini. La sera, appena imbruniva, chiudevamo il portale, mettevamo un ferro pesante ai due portoni di casa e mio nonno caricava il fucile. Anche io avevo un fucile (di plastica) che portavo in spalla e puntavo sui passanti pensando di incutere terrore. Esiste un filmetto, così si chiamavano le riprese con la cinepresa di allora, girato da mani inesperte perché le immagini oscillano o si incantano sull’oggetto ripreso con ostinazione, in cui io e mio fratello ci spariamo a vicenda cadendo a turno morti sull’erba.
Arriviamo a Olbia che c’è ancora luce. L’afa sembra temperata dal vento e provo uno stordimento legato all’odore dell’erba santamaria e all’accento delle voci. È una sensazione che dura un momento ma che contiene un’intuizione di gioia, un brandello di promesse irrealizzate ma confusamente ancora presenti a dispetto del tempo che mi resta. Siamo venuti senza macchina perciò prendiamo la corriera che effettivamente corre per la Gallura passando per San Pantaleo, sfiorando villette a schiera in stile moresco e spiagge già deserte, su fino al porto di Palau da dove si prende il traghetto per La Maddalena. Abbiamo sbagliato autobus, cioè io ho sbagliato autobus perché ho scelto quello che fa il percorso più lungo. Anche i gatti nei loro contenitori protestano, sono stati quieti per tutta la traversata, ma soffrono la macchina e anche l’autobus. La strada è piena di curve ma il paesaggio gallurese, soprattutto nel tratto finale prima di Palau, è davvero bello, verde, orizzontale, quasi volesse riposarsi prima di scattare nelle falesie di Bonifacio nella Corsica poco distante. Peccato che Arzachena, come Olbia, sia un paese dall’architettura casuale, come se tutto fosse stato messo insieme in fretta per obbedire all’affare (non per i sardi) della Costa Smeralda. Oltrepassiamo il bivio con su scritto appunto «Costa Smeralda». Sono anni che non andiamo. È un luogo posticcio, non è Sardegna, mette tristezza. Sembra non ci sia stata una via di mezzo fra la bruttezza e la falsa opulenza. Mi concentro sul colore delle rocce: sta passando adesso, a furia di ombre, dal rosso al viola.
Che stiamo arrivando a Palau lo capisco dal fatto che abbiamo superato il bivio per Porto Rafael, con un ingresso discreto, circondato da oleandri. C’è ombra, ma non è ancora buio. Stiamo per arrivare, scende una grande pace. Anche i gatti hanno smesso di miagolare e si sono addormentati nel loro trasportino.
Fino a metà del secolo scorso Palau era un paese di pastori che i maddalenini, fieri della loro «piccola Parigi», come La Maddalena veniva chiamata anche da mia nonna, guardavano con superiorità. Allora la Marina garantiva un’ombra di vita mondana. Oggi invece Palau è un centro turistico ben organizzato, con una sua dignità. Benché le spiagge siano meno belle di quelle della Maddalena, la gente preferisce andare nell’isola dalla mattina alla sera senza fermarsi, in una gita di un giorno che prevede: un picnic a Caprera, in una delle aree attrezzate, il cibo – vietato – ai cinghiali, un bagno, il giro in paese e il ritorno. Di anno in anno alla Maddalena per la crisi i turisti stanno diminuendo e di questi tempi l’isola a luglio è semideserta. Gli americani sono andati via. Ho firmato perché la base Nato, di stanza nella piccola isola di Santo Stefano, fosse smantellata. Molti però la rimpiangono perché portava soldi, nonostante lo scandalo del sottomarino naufragato che secondo un’indagine francese conteneva scorie radioattive. Quando la base è andata via, racconta Michela Murgia, molti hanno scritto per il paese «Ci mancherete». Mi viene sempre in mente la frase di Machiavelli nel dodicesimo capitolo del Principe: «gli uomini dimenticano più facilmente la morte del padre [e in questo caso anche la perdita della salute] che la perdita del patrimonio».
Arrivati a Palau la prima cosa da fare è verificare qual è il prossimo traghetto e a che ora parte. C’è un tempo, dieci, quindici minuti tra il momento in cui si fanno i biglietti e quello in cui si sale a bordo, che per me vale tutto il viaggio. Mi siedo su una delle gomene e guardo il traghetto che attracca o che ha già attraccato, ancora vuoto come oggi. È illuminato perché ormai sono le nove. Dobbiamo solo aspettare, salire, farci portare da una sponda all’altra. Ogni anno assaporo questa tregua e il suo silenzio. So che a metà della navigazione il traghetto spegne le luci e avanza nel vento e nel buio con i suoi passeggeri, che tacciono come se si fossero messi d’accordo in segreto.
In genere questi traghetti vengono da lontanissimo. Fantastico sempre sui loro viaggi dal Nord Europa a qui. La loro pancia, che si apre come la bocca di una balena a inghiottire e vomitare macchine, sembra obbedire a un meccanismo superiore che trascende i viaggi e ci libera dai destini.
Due anni fa avevo notato un traghetto danese che si chiamava Erik: bianco, piccolo, compatto. Immaginavo il suo passato, i passeggeri di allora, le piogge, le burrasche ed era come se le loro ombre ci fossero ancora, o meglio come se quel passato avesse fatto corpo con il traghetto e fosse diventato consustanziale ai ponti, al salone, allo scafo.
Il traghetto su cui saliamo oggi è nuovo, nel senso che deve essere stato comprato quest’anno, ma viene dall’Inghilterra e ha una sua trattenuta eleganza nei sedili di legno del bar e delle sale, che culmina nell’immagine del faro di St. Catherine nell’isola di Wight: è la riproduzione di una stampa color seppia con rovine e querce scosse dal vento. Un trapianto di sublime in un’isola mediterranea.
La luce di questa sera si adatta alla patria del traghetto. Se la nebbia che lo avvolge fosse fredda lo si potrebbe immaginare in un paesaggio scozzese. Fotografo le querce della stampa. Le mie sono foto senza alcuna pretesa, scattate con il cellulare, ma servono a ricordare velocemente e ho sempre di più la convinzione che servano meglio delle parole.
Spesso ho filmato il mare, sempre con il cellulare, solo per rivedere i colori passare da un blu quasi ruggine al verde chiaro vicino al bianco delle spiagge, fino al celeste più raro in qualche insenatura senza cespugli. Da un po’ di tempo ho iniziato a fotografare anche i dettagli del paesaggio circostante ma dimentico di inserire le didascalie e capita che mi chieda a quali luoghi si riferiscano le foto. Le faccio scorrere sul vecchio cellulare, che risale al 2010, e mi fermo su una che raffigura solo acqua. È tanto trasparente da sembrare bianca e le increspature grigie le danno un aspetto marezzato...