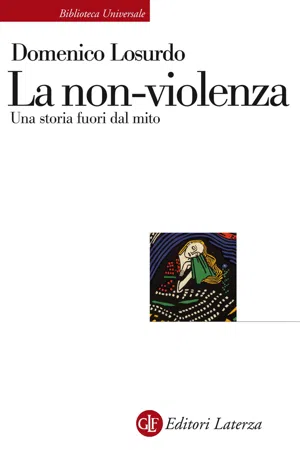VI. Martin Luther King quale «Gandhi nero» e il radicalismo afroamericano
1. La non-violenza dal Sudafrica agli Usa
Al di là del Sudafrica e dell’India, che lo vedono operare ed emergere come leader, Gandhi esercita la sua influenza in primo luogo negli Usa. In ciò non c’è nulla di stupefacente. Storicamente, il regime di segregazione razziale affermatosi in Sudafrica ha avuto come modello la white supremacy imposta dai bianchi negli Stati Uniti dopo il dileguare delle speranze suscitate dall’abolizione della schiavitù e dal varo (tra il 1868 e il 1870) del 14° e 15° Emendamento, che avrebbero dovuto sancire la fine della discriminazione razziale. Arrivando in Sudafrica nel 1893, Gandhi deve fronteggiare umiliazioni e tribolazioni simili a quelle che contrassegnano la vita dei neri nel Sud degli Stati Uniti: è scaraventato giù dal marciapiede e allontanato dal vagone del treno riservato ai bianchi, è costretto a prendere atto che i membri delle razze inferiori non possono «uscire di casa dopo le 21 senza un permesso» e che anche negli alberghi ci sono spazi a loro preclusi (A, 173-74, 186-87 e 191/113, 128-29 e 134). Ritornato per qualche tempo in India, nel 1896 Gandhi riferisce ai suoi connazionali:
L’uomo della strada odia [l’indiano], impreca contro di lui e spesso lo spinge giù dal marciapiede [...] I tram sono vietati agli indiani. Gli ufficiali delle ferrovie possono trattarli come bestie. Non importa se è pulito, la sua sola vista rappresenta per ciascun uomo bianco della colonia una tale ingiuria che si rifiuterebbe di sedere, anche per poco tempo, in uno scompartimento insieme a un indiano. Anche i bagni pubblici sono chiusi agli indiani, a prescindere da chi essi siano (CW, 1; 360).
È un rapporto che avrebbe potuto benissimo descrivere la condizione dei neri nel Sud degli Stati Uniti. D’altro canto, abbiamo visto che, a partire soprattutto dalla rivolta dei sepoys, gli indiani sono assimilati a niggers dai governanti britannici; e come «uomo ‘di colore’» Gandhi è accolto e trattato in Sudafrica. C’è persino un momento in cui, accusato di aver diffamato i bianchi del Natal (A, 173, 191 e 231-36/113, 134 e 181-85), egli rischia il linciaggio, conformemente ancora una volta alle tradizioni del regime di white supremacy, vigente e infuriante anche nel Sud degli Usa.
È in questo contesto che va collocata la tendenza di Martin Luther King a presentarsi come il «Gandhi nero» invocato dalla comunità afroamericana, che da un pezzo guardava con ammirazione al «piccolo uomo di colore» protagonista in Sudafrica e in India di un’epica lotta contro la white supremacy britannica (in Kapur 1992, pp. 158-59).
2. Il «pacifismo realistico» di Martin Luther King
Al di là delle analogie, occorre non perdere di vista la diversità delle situazioni e delle piattaforme ideologiche. Sul piano oggettivo, man mano che gli afroamericani cessano di essere concentrati su un’area ristretta del territorio nazionale, l’aspirazione a costituirsi in Stato nazionale indipendente, per qualche tempo nutrita da certi ambienti della comunità nera, viene a perdere qualsiasi significato. Si tratta di conquistare l’emancipazione all’interno di un paese nel quale la larga maggioranza della popolazione è costituita da bianchi.
Sul piano soggettivo, diversamente che in Gandhi la non-violenza in King non è una religione «nazionale» da recuperare, non presuppone il culto e la pratica del vegetarianesimo, inteso come forma di rispetto incondizionato per ogni essere vivente. Tanto meno essa s’intreccia con l’ideale della castità: se il leader indiano si espone alle critiche dei suoi discepoli a causa degli esperimenti da lui condotti di controllo totale dei sensi nonostante la condivisione del letto con questa o quella discepola, il leader afroamericano si espone ai ricatti dell’Fbi in conseguenza della sua vita sessuale ricca e non sempre ortodossa. Anche a volersi concentrare esclusivamente sul problema della violenza contro gli esseri umani, le differenze non appaiono meno nette. In King sarebbe impossibile leggere dichiarazioni come quelle in cui Gandhi esorta gli ebrei (e le altre vittime del Terzo Reich) a non opporre alcuna resistenza armata alla genocida violenza hitleriana, o invita i suoi seguaci ad affrontare la bomba atomica senza turbamenti e senza neppure cercar scampo in un rifugio. Ecco in che termini il leader afroamericano riferisce del suo processo di formazione negli anni del seminario:
Avevo l’impressione che la guerra, pur non potendo mai essere un bene positivo o assoluto, potesse servire come bene negativo nel senso di impedire la diffusione e la crescita di una forza malvagia. Per quanto orribile sia, la guerra potrebbe essere preferibile alla resa a un sistema totalitario: nazista, fascista o comunista (K, 22-23/24-25).
Ci troviamo qui dinanzi a una franca legittimazione di un certo tipo di guerra, dalla quale invece rifugge Gandhi, nonostante la disponibilità a fornire il suo appoggio alle guerre dell’Impero britannico.
King così chiarisce il senso della sua ulteriore evoluzione: «Dopo la lettura di Niebuhr, cercai di arrivare a un pacifismo realistico» (K, 27/29). Esplicito è dunque il rinvio al teologo protestante che già nei primi anni Trenta aveva criticato il profeta dell’ahimsa; nell’espressione qui utilizzata, l’aggettivo suona come una presa di distanza dal pacifismo di principio del leader indiano. Se in determinate circostanze può essere legittima la violenza dispiegata da un esercito nel corso di una guerra, tanto più legittima può essere l’azione intrapresa sul piano interno dalla polizia (e dall’esercito) al fine, ad esempio, di stroncare la violenza delle bande razziste: «Sono un fermo assertore della non-violenza, ma nello stesso tempo non sono un anarchico. Credo nell’uso intelligente delle forze di polizia» (K, 109/111).
La Guerra di secessione era stata giustificata da molti militanti dell’American Peace Society come una gigantesca azione di polizia contro i malfattori secessionisti e schiavisti. King va oltre: nell’identificarsi con Lincoln e nel rendere omaggio ai soldati che avevano combattuto contro il Sud, egli riprende l’inno di battaglia dell’esercito dell’Unione e la celebrazione in esso contenuta del «lampo fatale» che promana dalla «terribile e fulminea spada» dell’Onnipotente (K, 359, 286 e 289/366, 291 e 294). La violenza ha qui una consacrazione teologica: siamo ricondotti alle guerre del Signore dell’Antico Testamento che suscitano, come sappiamo, la ripugnanza di Simone Weil.
King riferisce di aver letto da studente, prima ancora che Gandhi, la Disobbedienza civile, «e fu proprio allora che ebbi il primo contatto con la teoria della resistenza non-violenta» (K, 14/16). In realtà, Thoreau non respinge incondizionatamente il ricorso alla violenza: l’abbiamo visto guardare a John Brown, il protagonista del tragico tentativo di stimolare la rivolta armata degli schiavi del Sud, come a un modello. E a sua volta il leader afroamericano non si limita a legittimare la violenza dall’alto esercitata dall’Unione nel corso della Guerra di secessione. Ci sono casi in cui può essere giustificata anche la violenza dal basso. Così, ad esempio, nel Sudafrica dell’apartheid: qui – osserva King nel 1964 – il potere razzista reprime anche «la forma più mite di resistenza non-violenta» in modo decisamente sproporzionato; «possiamo allora capire che in tale situazione la gente si sente così disperata da far ricorso ad altri metodi quali il sabotaggio» (in Fredrickson 1995, p. 275).
Anche per quanto riguarda la lotta negli Usa da lui condotta e guidata, King raccomanda la disobbedienza civile in nome del «pacifismo realistico» e della valutazione realistica dei rapporti di forza, piuttosto che del rifiuto incondizionato del ricorso alla violenza:
La semplice e inesorabile realtà era che qualunque tentativo da parte dei negri americani (American Negro) di rovesciare l’oppressore con la violenza non sarebbe mai andato a buon fine. Non c’era bisogno che ce lo dicesse il presidente Johnson, ricordandoci che essi sono in proporzione di uno a dieci rispetto all’insieme della popolazione. I coraggiosi tentativi dei nostri fratelli insurrezionisti, come Denmark Vesey e Nat Turner, dovrebbero costituire per noi un perenne memento del destino nefasto a cui è votata ogni ribellione violenta [degli afroamericani]. Chi guida una ribellione violenta deve essere disposto a fornire una onesta valutazione del numero di vittime probabilmente destinate a cadere in una popolazione minoritaria che si sollevasse contro una maggioranza ricca e ben armata, in cui è compresa una fazione di fanatici di destra, pronti a cogliere con gioia l’occasione di sterminare migliaia di uomini, donne e bambini neri (K, 329/337).
Come si vede, l’opzione non-violenta non impedisce l’omaggio ai «fratelli insurrezionisti», agli schiavi neri che avevano comunque cercato di spezzare le loro catene. È una presa di posizione che rientra nell’ambito di una filosofia della storia. Si spiega così la dichiarazione in base alla quale, se Dio gli avesse concesso la possibilità di scegliere il periodo storico in cui vivere, King avrebbe scelto la «seconda metà del XX secolo» in cui per l’appunto viveva, il periodo storico nel quale – sottolineava il leader nero – «io vedo l’azione di Dio» (K, 359-60/365-66). I decenni in cui il colonialismo e il regime di white supremacy a livello planetario subivano colpi decisivi (spesso di natura tutt’altro che non-violenta) costituivano una sorta di plenitudo temporum agli occhi di King, il quale non sembra mai perdere di vista la configurazione concreta dei rapporti di forza e le modalità concrete dei grandi rivolgimenti politici:
Nessuna rivoluzione interna è mai riuscita a rovesciare un governo con mezzi violenti, se non quando il governo stesso aveva già perduto la fedeltà e il comando effettivo delle proprie forze armate, e chiunque sia sano di mente sa che negli Stati Uniti questo non accadrebbe (K, 330/338).
Peraltro, neppure la netta sproporzione nei rapporti di forza costituisce una garanzia assoluta di sviluppo pacifico della lotta:
I negri potranno ancora percorrere la via della non-violenza e dell’amicizia tra le razze se l’America bianca verrà loro incontro con un’onesta determinazione a eliminare dalla società le ineguaglianze e la disumanità (K, 314/321).
Alla luce di tutto ciò si comprende la lettura che alcuni studiosi fanno della tendenza di King a presentarsi come il «Gandhi nero», da lungo tempo auspicato e invocato dalla comunità afroamericana, come un’accorta operazione di public relations. È da aggiungere però che anche nel Gandhi propriamente detto il sincero omaggio all’ahimsa non è disgiunto dal calcolo politico.
3. Segregazione, intervento dello Stato e violenza
Resta il fatto che la denuncia della «spaventosa condizione dei neri» e degli «indicibili orrori della brutalità poliziesca» di cui essi continuano a essere vittime va di pari passo in King con un’appassionata professione di fede non-violenta: «Non dobbiamo consentire che il nostro progetto creativo degeneri in violenza fisica. Dobbiamo sempre di nuovo innalzarci a un’altezza maestosa per fronteggiare la forza fisica con la forza dell’anima» (in Hofstadter 1982, vol. III, pp. 450-51). L’ultima espressione (soul force) fa pensare al Satyagraha di Gandhi, al quale implicitamente ci si richiama.
E, tuttavia, non mancano le accuse di incoerenza a King rivolte da due contrapposti punti di vista. Cominciamo con le critiche da «destra». In primo luogo: quali bersagli deve colpire e quali obiettivi deve perseguire la lotta degli afroamericani, se veramente vuole essere non-violenta? Intervenendo nel dibattito, Arendt si preoccupa di piantare dei paletti. Ci si doveva battere perché fosse rispettato il principio dell’eguaglianza politica e dunque non fosse ostacolato in alcun modo il diritto elettorale attivo e passivo dei neri. Per quanto riguarda l’ambito sociale, tuttavia, non doveva essere persa di vista una distinzione essenziale:
Mentre il governo non ha alcun diritto di interferire nei pregiudizi e nelle pratiche discriminatorie della società, esso ha invece non solo il diritto, ma anche il dovere di far sì che queste pratiche non siano sancite per legge (Arendt 1959, p. 53).
Occorreva dunque che fosse abolita la legislazione (ancora vigente in numerosi Stati) che vietava la miscegenation (la contaminazione derivante da rapporti sessuali e matrimoniali interrazziali) e fossero cancellate le norme giuridiche che imponevano la segregazione razziale in questo o quell’ambito, ma non era lecito intervenire là dove tale segregazione era espressione delle scelte, degli orientamenti, del costume della società civile. A questo livello il potere politico non aveva alcun diritto di interferire. In sintesi: «L’integrazione coatta non è migliore della segregazione coatta» (ivi, p. 49); l’integrazione delle scuole sancita per legge e ottenuta mediante l’intervento nel Sud delle truppe federali non era meno violenta della segregazione che per decenni era stata imposta dalle norme giuridiche varate dagli Stati del Sud. I neri avrebbero dovuto accontentarsi dell’abolizione di quella legislazione. L’oltrepassamento di questo limite provocava una reazione legittima: «L’attuale massiccia resistenza che si manifesta in tutto il Sud è la conseguenza della desegregazione coatta, non della consacrazione giuridica del diritto dei neri al voto» (ivi, p. 48).
Il movimento per i diritti civili era in qualche modo chiamato ad accontentarsi del passaggio da una segregazione sancita a livello giuridico dai singoli Stati a una segregazione promossa (o imposta) dalla società civile bianca ovvero egemonizzata dai bianchi: ma ciò non significava avallare la continuazione, sia pure sotto forma diversa, della violenza razzista? Non era di questa opinione Hannah Arendt, secondo la quale, rivendicando e imponendo una legislazione (federale) di segno contrapposto, gli afroamericani soffocavano la libera espressione della società civile, esattamente come sino a quel momento avevano fatto i razzisti bianchi. Già in questa fase il movimento per i diritti civili era accusato o sospettato di essere incline alla prevaricazione e alla violenza. Tanto più che l’intervento del potere e dell’esercito federali, invocato e promosso dai neri guidati da King, finiva per calpestare «i diritti degli Stati», un elemento essenziale dell’ordinamento costituzionale e della libertà americana.
4. L’azione diretta come sinonimo di violenza?
Al di là degli obiettivi politici, il dibattito e le critiche investivano anche le forme di lotta. Il 12 aprile 1963, i ministri di culto bianchi di Birmingham chiedevano a King di metter fine alle manifestazioni di massa contro la segregazione, da essi definite «imprudenti e intempestive»; sul versante opposto erano elogiate le forze di polizia «per aver mantenuto ‘l’ordine’ e ‘impedito atti di violenza’» (K, 188 e 203/190 e 204). Dal carcere King rispondeva:
Nel vostro documento dichiarate che le nostre azioni sono da condannare perché, sebbene pacifiche, determinano lo scoppio della violenza. Ma una simile asserzione è davvero logica? Non è un po’ come condannare l’uomo rapinato perché il fatto di possedere del denaro ha determinato l’azione malvagia della rapina? (K, 195/198).
Il paragone non era calzante: il rapinato non commette alcun reato né tanto meno fa appello a una disobbedienza civile di massa. L’argomento dei ministri di culto bianchi si comprendeva agevolmente: una violazione della norma giuridica esistente, effettuata su larga scala e propagandata con ogni mezzo, e dunque configurantesi come una sfida pubblica e persino come una provocazione all’autorità esistente, non poteva non provocare l’intervento delle forze dell’ordine. Agli organizzatori delle manifestazioni di Birmingham non era lecito ignorare le conseguenze dell’azione diretta di disobbedienza civile da loro promossa ed essi erano dunque da considerare corresponsabili delle violenze che ne erano scaturite.
E, tuttavia, dal punto di vista di King, la critica a lui rivolta aveva il torto di esigere il rispetto superstizioso di ogni legge, anche di quella più ingiusta:
Ci sono due tipi di legge: giuste e ingiuste. Sarei il primo a invocare l’osservanza delle leggi giuste [...] Di converso, abbiamo anche la responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste: io concorderei con Sant’Agostino nel ritenere che «una legge ingiusta non è legge» (K, 193/195).
Stando così le cose, ben lungi dall’essere moralmente illecita, la violazione della ramificata legislazione che continuava a discriminare, ...