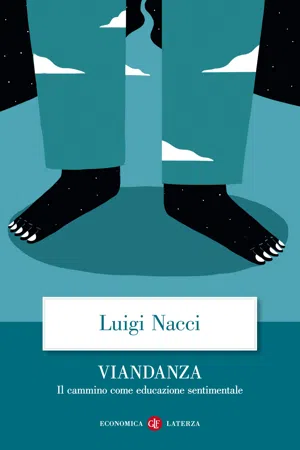Arroganza.
Fino alla fine del mondo: Finisterre
Linea d’ombra
Ti ricordi quel passaggio, in La linea d’ombra di Joseph Conrad, in cui il giovane capitano, snervato per il mare in bonaccia, «levigato come una lastra d’acciaio nell’aria senza vento», rimasto quasi solo a causa della ciurma in preda alle febbri, riporta alcune righe del suo diario? Dice: «è come trovarsi legati mani e piedi, in attesa che qualcuno ci tagli la gola. E ciò che più mi sgomenta è che non ho il fegato di andare sul ponte e affrontare la situazione. È un dovere salvare la nave, è un dovere verso gli uomini che sono là in coperta – alcuni di loro pronti a tirar fuori l’ultimo rimasuglio di energie a una mia parola. E io che mi tiro indietro. Solo a immaginarmi la scena. Il mio primo comando. Ora capisco lo strano senso di insicurezza nel mio passato. Ho sempre sospettato che non sarei stato all’altezza. E questa ne è la prova certa. Non ho fegato. Non sono all’altezza».
Come erano possibili quello sconforto e quella rassegnazione? All’inizio della storia lo vediamo capace di prendere una decisione importante: abbandona la sua vecchia nave in un modo «irragionevole», d’emblée, come un uccello, dice, che «vola via da un ramo dove sta comodo», rischia tutto, e poco dopo gli viene offerto il comando di un’altra nave, senza aver fatto gavetta, un grande colpo di fortuna, l’occasione di una vita. Com’è possibile che un giovane così sicuro di sé, dopo solo qualche giorno si trovi a commiserarsi? A non sentirsi all’altezza?
Ecco il mio stato d’animo, tornato a casa. Forse ti chiedi perché anch’io, d’emblée, senza preavviso, abbia cambiato rotta. Perché stia iniziando a parlarti di me. Socrate, ti ricordi come è morto? La cicuta, certo. Ma ti ricordi cosa fa subito dopo averla bevuta? Si copre con un velo. Poi se lo ritoglie ed esclama (così perlomeno riferisce Platone): «O Critone, noi siamo debitori di un gallo ad Asclepio: dateglielo e non dimenticatevene!». Si rimette il velo, e muore. Sulla ragione per cui abbia fatto quella richiesta, in tanti, e autorevolmente, hanno detto la loro. Ma quel che conta qui, per noi, è il velo: se lo mette per entrare nel mondo del sacro, dei morti e degli dèi, se lo toglie quando per un istante torna nel mondo dei vivi, se lo rimette per non levarselo più. Socrate, in sostanza, segnala con il gesto del velo/disvelo che ci sono due parti in lui: una che va verso la vita, ed è quella della parola, che lo fa essere, secondo Nietzsche, il più saggio chiacchierone mai esistito; l’altra che va verso la morte, ed è una parte che non ha più bisogno di argomentare, che non usa le parole: fa.
Questo preambolo è per dirti che non potevo più aspettare. Arriva il giorno, e di solito è alla fine del proprio secondo o terzo lungo cammino, che ci si trova come Socrate, o Galileo, di fronte a una scelta. Abiurare e vivere, o resistere e morire. Non so quale delle due sia la migliore, però so che è una scelta che tutti siamo costretti a fare. A me accadde. E ora che sei tornato da Santiago e da Roma sono certo che puoi comprendermi. Per questo ho deciso di prendere la parola. Sappi che da questo momento in poi a parlarti saranno due voci, che partono da me ma che non posso controllare: una è quella sedentaria, sociale, che passa le giornate di ufficio in ufficio, tra i vivi, o coloro che lo sono in apparenza, l’altra è quella nomade, asociale, che cammina con i propri spettri, che cerca il silenzio e il sacro, che camminerebbe fino al suo ultimo respiro. Sono voci che si confondono l’un l’altra e l’una dentro l’altra. Spetterà a te capire quando il velo c’è e quando si toglie.
Dovrai tenere presente, inoltre, come dice Zeno in La coscienza, che ogni confessione fatta per iscritto è menzognera. Non ti fidare di me, e diffida più che puoi delle confessioni. Confessare significa “dichiarare spontaneamente”, non è che un mettere le mani in avanti, l’atto naturale di chi ha commesso un delitto e si costituisce per sperare in una riduzione della pena. Un’ultima cosa: dovrai anche ricordarti, come fa Aleksandr Puškin all’inizio del suo Eugenio Onegin, che la confessione delle proprie buone e cattive azioni si dà laddove ci sono vanità, orgoglio, sentimento di superiorità. Per cui, se leggerai una mia dichiarazione di resa, un «non sono all’altezza», non dovrai scambiarla per umiltà. Se fossi umile, non starei scrivendo questo libro. La linea d’ombra è una fune sottilissima che a tutti noi capita di incontrare nella vita. Se la si varca, difficilmente si fa ritorno a casa. Chi ci riesce, salpa per mari battuti da venti favorevoli, e non ha bisogno di scriverlo.
Al culmine
È assurdo
dice la ragione
È quel che è
dice l’amore
È infelicità
dice il calcolo
Non è altro che dolore
dice la paura
È vano
dice il giudizio
È quel che è
dice l’amore
È ridicolo
dice l’orgoglio
È avventato
dice la prudenza
È impossibile
dice l’esperienza
È quel che è
dice l’amore.
(Erich Fried, È quel che è)
Prima ho scritto che la scelta si presenta alla fine del secondo o terzo lungo cammino. Intendiamoci, “lungo” è quanto di più soggettivo possa esserci. Tre giorni, trenta o trecento, o di più. Tre ore. Sia tu che io ci intendiamo: è lungo quel cammino che ha origine da un sentimento tragico della vita. Ero andato a Santiago e a Roma molte volte, per diverse vie. Quante volte, quante vie? Non ricordo. Però so che tutti quei cammini erano sorti dalla frustrazione, dalla nostalgia, dalla rivolta. Erano emozioni sferzanti, come refoli di bora, ma di una bora chiara, quella che obbliga ad aggrapparsi ai pali della luce o alle bitte, che spazza via le melanconie dai vicoli, non il turbinio che abbatte i palazzi.
Un sabato d’estate, nella mia stanza, nella stanza cioè di quella che mi ostinavo a chiamare casa, mi svegliai di soprassalto ed ebbi il pensiero chiaro, distinto, poderoso, dell’assurdità della vita. Fu un pensiero ventoso, la cui sostanza era fatta di bora scura. È un vento che non perdona, non risparmia niente e nessuno. Mi chiesi: «a che punto della vita mi trovo?». Non seppi rispondere. Ero dentro la vita? Non la vedevo. Ciò che vidi nitidamente dinnanzi a me fu il tempo: una voragine buia che risucchiava la stanza, un grande vuoto che aspirava ogni cosa, e quando se le prese tutte, si fermò. Era come se dicesse «manchi tu».
Sul mio comodino c’era un libro di Emil Cioran, intitolato Al culmine della disperazione, nel quale sostiene che in alcuni momenti cruciali, come nella sofferenza e nell’amore, diventiamo “lirici”, cioè esseri in grado di toccare il fondo originario dell’esistenza, di provare un sentimento che mette in moto tutte le nostre risorse, una vertigine inaudita. A tutti noi, al di là delle nostre sensibilità, capita. Però ad alcuni capita di essere in uno stato lirico pressoché costante, di avere cioè un eccesso di interiorità, e questo può essere molto pericoloso. «La vita è troppo limitata, troppo frammentaria per resistere alle grandi tensioni. Tutti i mistici non ebbero forse, dopo le grandi estasi, il sentimento di non poter più vivere?».
Cioran termina il libro affermando che solo l’amore può salvare l’uomo. È un’affermazione banale, secondo lui, soltanto per quegli uomini che non hanno mai amato veramente. Dice che «i raggi del tuo amore che non sono potuti penetrare negli altri per illuminarli o rendere la loro tenebra più misteriosa si rifrangeranno per ritornare in te, perché nell’istante dell’ultimo abbandono il loro fulgore ti faccia luce e le loro vampe ti riscaldino». Ma – e questa è l’ultima frase – «chi può essere capace di tanto amore?». Mi aveva tolto le parole di bocca. Anch’io – pur non considerandomi affatto un mistico – sentivo un eccesso di interiorità che non trovava sfogo nella mia vita quotidiana. E intuivo che l’amore mi avrebbe salvato. Quale amore? Non quello per una persona, o per un luogo, men che meno per un oggetto.
Ciò che mi avevano lasciato i miei cammini, oltre ad una ragguardevole mole di domande imponenti, era l’idea che lì, sulla strada, fosse possibile una forma di amore più ampia, non tanto verso se stessi e il prossimo, ma verso la vita in quanto tale. Come se la vita, proprio come il vuoto che una mattina si materializzò davanti agli occhi, in cammino acquisisse una geometria visibile, una massa e un peso specifici. Non si trattava più della nostalgia per la sensazione di libertà, per la condivisione, per la semplicità e per tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. Era un sentimento smisurato. Fu il pensiero di quel sentimento a farmi reagire al vuoto. Credo che soltanto al culmine della disperazione si possano prendere le decisioni più drastiche. Non le più giuste, bensì le univoche: quelle da cui non si fa ritorno. E se lo si fa, lo si fa con la testa di un’altra forma.
A perdifiato
Avevo soltanto due giorni. Il lunedì sarebbe stata una giornata campale. Uno di quegli intervalli temporali che la vita ci riserva e ai quali non possiamo sottrarci. C’era una grande X sul calendario. Strappai i fogli che seguivano, perché in un modo o nell’altro nulla sarebbe più stato come prima. Acquistai il biglietto dell’aereo, pagandolo un’eresia, imbastii lo zaino in dieci minuti, mi vestii e corsi all’aeroporto. Poco prima del tramonto arrivai all’aeroporto di Santiago. In Galizia tutto era iniziato, lì tutto sarebbe dovuto finire. Dovevo arrivare a Finisterre, o a Fisterra, come dicono i galleghi, al faro sull’oceano, bruciare i miei vestiti, dire addio al mio nome. Quella era la linea d’ombra. Avevo a disposizione un giorno per fare novanta chilometri. Troverò le risposte, pensai, sono pronto.
A darmi man forte c’era la convinzione di avere appreso molto dai cammini precedenti, di essermi, come dire, evoluto. Pensavo di avere introiettato una sorta di saggezza ancestrale. Avrei potuto sperimentarla sul campo. Grazie ad essa non avrei avuto bisogno di camminare per settimane. Avrei dilatato il tempo, lo avrei soggiogato, stracciato, ridotto in poltiglia e gettato a mare. Sbarco, sortita, vittoria. Me ne sarei bellamente fregato del sentiero affollato, del marketing selvaggio, della parola «moda» sulla bocca di tutti. Avrei fatto il cammino in me e per me, non giudicando quello altrui. Se mi fosse stata rivolta qualche domanda, avrei risposto soppesando ogni sillaba. Sarei stato sapiente e implacabile.
Ti ricordi Bartleby, lo scrivano di Herman Melville? Viene assunto come copista in uno studio di Wall Street. I primi tempi esegue metodicamente il suo lavoro, con zelo certosino, fino a quando il suo titolare gli chiede se può esaminare con lui un documento, e Bartleby fa, con voce soave: «preferirei di no». La stessa risposta, declinata anche in «preferisco di no», «preferisco non rispondere», «preferirei non fare cambiamenti» e così via, la darà tutte le volte che gli verrà rivolta una richiesta. Veniamo a noi. Qual è il punto di rottura nel racconto? L’arresto. Bartleby viene prelevato dall’ingresso di fronte al suo ex ufficio in cui bivacca e arrestato per vagabondaggio. Lo portano alle Tombe, il carcere giudiziario. Proprio come il signor Mead del racconto di Ray Bradbury, Il pedone: cammina di notte per la città, lo ferma la polizia, gli chiede ripetutamente perché stia camminando e lui risponde «per camminare». Come va a finire? Viene condotto al Centro di Ricerca Psichiatrica sulle Tendenze Regressive. Gilles Deleuze dice che «Bartleby “ribalta la lingua” degli altri». Insistono affinché dica sì o no, ma sia che dica sì o no «sarebbe sconfitto». Egli è «l’uomo senza referenze, senza possessi, senza proprietà, senza qualità», che si è guadagnato il diritto di «essere in quanto essere e nient’altro».
Bartleby e Mead incarnano entrambi la figura del viandante: non si oppongono al sistema difendendosi o giustificandosi, perché così facendo sarebbero costretti a usare il linguaggio della società dominante, entrando nelle dinamiche del potere ad esso sotteso. La loro opposizione non ha bisogno di sofismi o di arringhe. Essi, in quanto tali, per quel che sono, rappresentano una minaccia all’ordine costitui...