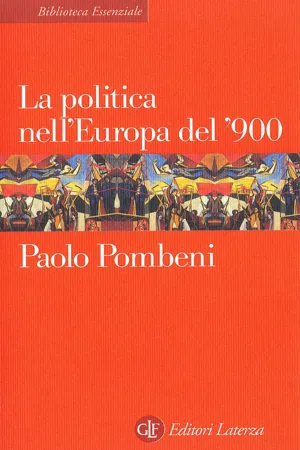
- 20 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La politica nell'Europa del '900
Informazioni su questo libro
La storia politica di un'Europa in bilico tra civiltà e barbarie.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La politica nell'Europa del '900 di Paolo Pombeni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e 21st Century History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
HistoryCategoria
21st Century HistoryLa crisi di fine secolo e il sistema liberale
Quella del sistema politico liberale di fine Ottocento può essere considerata, da molti punti di vista, come una crisi annunciata da molto tempo: da ultimo nel 1890 un noto scrittore liberale belga, Emile De Laveleye, aveva preconizzato in un suo libro una crisi in agguato contro la stabilizzazione costituzionale, crisi che sarebbe
giunta per l’azione combinata del declino delle culture religiose e del montare della «questione sociale»: a suo giudizio senza religione e senza costumi una cultura politica costituzionale sarebbe stata semplicemente impossibile. Non si trattava che di una voce fra le tante. Nel gennaio del 1898 sulla prestigiosa rivista inglese che era stata portavoce del progressismo positivista, la «Nineteenth Century Review», il pubblicista J. Guiness Rogers si chiedeva addirittura se il partito liberale non fosse ormai al «collasso» considerando anche che «da ogni parte si sente dire che il paese è ormai soggetto ad una forma di apatia politica così intensa che niente è abbastanza forte per scalfirla». E tutto questo per limitarsi ad autori che erano simpatetici col sistema liberale, perché se ci si fosse rivolti ai suoi critici, fossero questi gli scrittori cattolici intransigenti o gli intellettuali socialisti più radicali, le tinte avrebbero assunto tonalità ancora più pesanti.
Era del resto difficile pensare in maniera differente nel pieno di un periodo di tensioni e difficoltà che in seguito sarebbe stato ricordato come «la crisi di fine secolo», una fase che in tutt’Europa sembrava svolgersi all’insegna di una radicale rimessa in discussione degli equilibri acquisiti. Quel sistema politico che si era imposto quasi ovunque tra il 1848, l’anno della grande ondata rivoluzionaria che avrebbe spazzato via il sogno della Restaurazione, e la metà degli anni Ottanta, quando si era conclusa in tutt’Europa la fase dell’allargamento del corpo elettorale, veniva guardato con sospetto quanto alla sua capacità di superare indenne le tensioni che percorrevano la società europea e le sue istituzioni.
1. Un sistema fra governo dei notabili e «popular government»
Il costituzionalismo europeo, nella versione che si era affermata dopo i ripensamenti indotti dai radicalismi di alcune fasi della Rivoluzione francese e dalle vicende di Napoleone Bonaparte, era uno strano oggetto, la cui descrizione è tutt’altro che semplice. Esso si fondava essenzialmente su tre principi: l’origine rappresentativa del potere di decisione politica, un sistema di poteri articolato e bilanciato, lo «stato di diritto». Essi erano variamente utilizzati (e talora aggirati) nel concreto delle differenti organizzazioni statali, ma nessuno aveva più l’ardire di mettere in discussione il loro posto fondamentale.
L’origine rappresentativa del potere di governo rimandava alla generica asserzione che il potere discendesse dal popolo e che si esercitasse nel suo nome. Poiché il popolo è una realtà un po’ sfuggente e ancor meno organica, la teoria politica poteva discutere a lungo su chi realmente lo «rappresentasse». Nel concreto, però, tutti i sistemi politici vigenti alla fine del XIX secolo finivano per riconoscere che la rappresentazione pubblica di questa «partecipazione» del popolo all’esercizio del potere avveniva grazie a un sistema elettorale che coinvolgesse un rilevante numero di cittadini. Il suffragio universale maschile, cioè l’ammissione al voto di tutti i maschi adulti (un’età difficile da definire, ma che in genere variava fra i 25 e i 30 anni), era presente dal 1848 in Francia (salvo alcune interruzioni), dal 1870 in Germania, mentre venne introdotto in Belgio, dove già una legge del 1848 aveva concesso un primo, seppur limitato, allargamento del diritto di voto, nel 1894. La Gran Bretagna, a cui tutti guardavano come al modello di ogni sistema parlamentare, non aveva un suffragio particolarmente «largo», anche se la riforma del 1867 prima e quella del 1884 poi avevano consentito l’accesso al voto a tutte quelle componenti dei ceti popolari che si erano manifestate più attive nella lotta politica. L’Italia nel 1882 aveva abbandonato un sistema di suffragio assai limitato per concedere un significativo allargamento (l’elettorato era passato da poco più di 2 milioni a 6 milioni di iscritti). L’impero asburgico, che era una roccaforte delle concezioni politiche più arretrate, introdusse anch’esso nel 1882 sotto il governo del conte Taaffe un allargamento del censo, che suscitò la reazione dei ceti conservatori inorriditi per «l’irruzione del pizzicagnolo nella politica». In controtendenza si collocava la Spagna, che aveva introdotto il suffragio universale nel 1868 al termine di una fase rivoluzionaria, ma che dieci anni dopo era tornata a un sistema di suffragio censitario e in più con una gestione delle elezioni ampiamente manipolata, sicché in questo caso si poteva parlare di sistema rappresentativo solo con molta approssimazione. Né la situazione era cambiata quando nel 1890 si era riaffermata una forma di suffragio universale, perché il tasso di manipolazione elettorale era rimasto altissimo.
Dunque, pur con limiti e disparità di situazioni, la politica era in tutta Europa ormai un fatto «popolare»: a rendere i meccanismi elettorali qualcosa di efficace avevano pensato sia gli sviluppi della stampa (che per la verità si avviava ora a una fase di depoliticizzazione) sia quelli delle organizzazioni politiche, i «nuovi partiti» che cominciavano ad essere definiti «di massa», vuoi sul modello di quelli americani vuoi sul modello di quelli operai.
Quanto al sistema della «divisione dei poteri», la situazione era meno limpida di quanto avrebbe lasciato supporre la lettura dei manuali costituzionali dell’epoca. Secondo questi a far da riferimento avrebbe dovuto essere un mitico «modello inglese». Esso vedeva non soltanto la divisione fra il potere di rappresentanza verso l’esterno, che rimaneva formalmente assegnato al re, e l’effettivo potere di governo, che veniva invece esercitato in proprio dal suo Cabinet, all’interno del quale diveniva dominante la figura del primo ministro, ma anche un controllo da parte del Parlamento nei confronti del governo mediante l’istituto della fiducia (un governo non poteva rimanere in carica se un suo provvedimento qualificante era bocciato dal Parlamento) e un’articolazione del Parlamento su due piani, uno legato alla Camera espressa dal voto popolare (la House of Commons) e uno legato alla Camera che raccoglieva i rappresentanti dei grandi servitori del Regno (la House of Lords), fossero questi gli eredi della tradizionale nobiltà o i personaggi che venivano creati nobili per i servizi resi alla nazione. La dialettica fra una rappresentanza che registrava gli umori dell’opinione pubblica e una rappresentanza che avrebbe dovuto riferirsi al profondo patrimonio storico della nazione in materia di sapienza governativa era ritenuta essenziale.
Questo schema era stato nobilitato nei dibattiti da una presunta somiglianza che esso poteva vantare con il grande sistema romano, così come era stato interpretato dallo storico greco Polibio. Questi aveva sostenuto che la grandezza dell’antica Roma stava nel non avere avuto solo uno dei tre tipi di poteri classici individuati dal filosofo greco Aristotele (la monarchia, la oligarchia e la democrazia), ma nell’averli avuti tutti e tre insieme (il consolato rappresentava il potere monarchico; il senato quello oligarchico; il tribunato della plebe quello democratico). La Gran Bretagna moderna avrebbe ripercorso quell’itinerario.
Se a parole tutti si dichiaravano ammiratori del sistema britannico, in pratica esso risultava difficilmente esportabile in contesti storici diversi. Innanzitutto non ovunque si avevano sistemi monarchici e questo non poneva solo una questione nominale. Il presidente degli Stati Uniti aveva più poteri di un re costituzionale (assommava nella sua persona il potere di rappresentanza verso l’esterno e l’effettivo esercizio del governo), ma al presidente della Repubblica francese non si era disposti a riconoscere nessun potere, se non quello di una rappresentanza che tendeva a ridursi al solo lato cerimoniale. I monarchi per contro non erano tutti disponibili ad accettare tranquillamente il loro ruolo di persone che «regnano, ma non governano»: quelli inglesi si erano trovati costretti a farlo da una classe politica molto gelosa del suo ruolo di potere indipendente; quelli italiani accettavano il principio a parole, ma nei fatti cercavano di forzare la mano almeno su alcuni aspetti (in materia militare o di politica estera, soprattutto); quelli tedeschi, risiedessero a Berlino o a Vienna, non ne volevano sapere di cedere realmente ai loro ministri le redini del comando, così come era assai riottoso (anche se con risultati più modesti) il monarca spagnolo.
Al di là di questo aspetto vi era comunque la grande spaccatura fra stati che accettavano il principio della fiducia parlamentare e stati che non lo riconoscevano. In quest’ultima categoria vi erano l’impero tedesco e quello asburgico, i quali rifiutavano la possibilità che «il governo del re» dovesse essere automaticamente considerato finito se fosse incappato in una bocciatura parlamentare su una materia significativa: la questione era assai complessa sul piano teorico e pratico, sicché non era sempre chiaro dove finissero le affermazioni di principio e dove si fosse in presenza di una reale prassi di conflitto (anche in questi stati, infatti, un governo che non ottenesse l’assenso del Parlamento ai propri atti non avrebbe potuto poi tradurli in leggi). Un secondo problema concerneva la struttura stessa del governo: era questo una semplice riunione dei ministri, ciascuno indipendente nelle sue competenze (ed eventualmente responsabile per esse direttamente verso il sovrano), o si trattava di un vero e proprio istituto collettivo? E, in questo secondo caso, la figura del suo presidente (si chiamasse primo ministro, o presidente del Consiglio, o cancelliere dell’impero) doveva avere una preminenza particolare? Se la questione sembrava già risolta in Gran Bretagna a favore di quest’ultima ipotesi, in Francia la resistenza a considerare sovraordinato il presidente del Consiglio fu piuttosto forte, mentre in Germania il problema venne complicato col ritenere ad un tempo che il cancelliere avesse una posizione particolare e che però i singoli ministri potessero avere un accesso diretto all’imperatore.
Una questione particolarmente difficile da risolvere si era rivelata quella del bilanciamento interno al sistema parlamentare, tra una rappresentanza di tipo elettorale e una fondata su una selezione dei «migliori». Il principio del bicameralismo era universalmente accolto, ma la sua messa in pratica si rivelò assai difficoltosa. Se lasciamo da parte il caso del tutto particolare dell’impero tedesco, dove la seconda Camera, il Bundesrat, era formata dai rappresentanti dei governi degli stati federali (con un meccanismo di rappresentanza che rendeva la Prussia facilmente dominante, per di più in un contesto politicamente «omogeneo» visto che i governi erano ovunque nelle mani dei soli partiti d’ordine tradizionali), negli altri paesi la seconda Camera era un istituto dalla fisionomia incerta. L’Italia aveva optato per una Camera di senatori a vita, scelti teoricamente dal re (di fatto dal governo e solo in parte minima direttamente dalla Corona), che era rapidamente diventata un cimitero degli elefanti politici, parlamentari o alti funzionari che venivano elevati al «laticlavio» (come pomposamente si diceva), ma che non avevano né credibilità né strumenti per porsi in concorrenza con la Camera. In Francia e in Belgio si optò per scegliere anche la seconda Camera attraverso meccanismi elettorali, resi solo più difficili e più selettivi per puntare ad avere (in teoria) rappresentanti che rivestissero maggiormente la qualità di uomini «notabili» delle loro comunità di riferimento. Senza entrare qui nei tecnicismi di queste forme di selezione, possiamo dire che anche in questo caso il risultato in termini di «bilanciamento» della rappresentanza di estrazione popolare non fu particolarmente felice.
Dove invece si era quasi ovunque raggiunto un risultato notevole era nell’affermazione della terza componente del sistema costituzionale, che abbiamo etichettato con la formula tedesca dello «stato di diritto» (Rechtsstaat). Questa ovviamente non ha nulla a che fare con il presupposto che questi sistemi fossero in grado di garantire ai propri cittadini la «giustizia» in un senso etico-morale. Si vuole invece attirare l’attenzione sul fatto che ormai la legittimità di tutti i sistemi passava attraverso il riconoscimento della produzione del comando statale come un comando generale, eguale per tutti, applicato da organismi specializzati (i tribunali) in cui sedevano funzionari selezionati per il loro sapere tecnico. Alle spalle di questa rivoluzione stava una storia ben più lunga di quella dello stato costituzionale, ma certo era con esso che si era avuta la stabilizzazione definitiva del sistema giuridico fondato su un corpus di leggi che regolavano ambiti generali, che non riconoscevano giurisdizioni particolari (il giudice era lo stesso per tutti) e che sottraevano le decisioni alla libera volontà dei vari poteri pubblici per ricondurle invece alla «volontà della legge». Rientrava appunto in quest’ambito una professionalizzazione sempre maggiore delle procedure di applicazione della legge: giudici e avvocati erano adesso delle persone particolarmente formate nelle discipline giuridiche che si muovevano rispondendo solo alla dinamica interna del sistema legislativo.
Certo nella pratica c’erano disfunzioni e abusi: l’indipendenza della magistratura dal governo era spesso relativa, la possibilità di far valere in concreto gli strumenti di difesa giuridica poteva essere modesta, le vecchie tradizioni dei governi «di polizia» erano dure a morire. Però è indubbio che nel complesso il sistema era mutato profondamente, a dispetto di qualche caso di ingiustizia molto evidente: proprio a cavallo fra i due secoli si sarebbe avuto il famoso «affare Dreyfus» in Francia, in cui un capitano ebreo, ingiustamente accusato di spionaggio a favore della Germania, avrebbe penato quasi quindici anni per vedersi riconosciuta la propria innocenza di fronte a un sistema giudiziario e militare che si chiudeva a riccio per non ammettere i propri errori.
La parte più cospicua della rivoluzione giuridica si sarebbe però quasi ovunque realizzata nel campo di quello che con linguaggio «continentale» si chiama diritto amministrativo (il sistema britannico non conosceva questa branca del diritto). Si tratta di quell’ampia fascia di leggi che riguardano il campo di attività della pubblica amministrazione (cioè in definitiva il braccio operativo del governo) sia nei suoi rapporti con i privati che all’interno dei poteri dello stato. Sempre più i governi agivano, decidevano, si occupavano di tutto, dalla scuola alla sanità, dal commercio all’agricoltura (oltre naturalmente ai grandi ambiti tradizionali come la difesa, l’ordine pubblico, le poste e le comunicazioni), e sempre più i governi agivano proponendo leggi e regolamenti. Ciò creava un enorme corpus giuridico che non era più né «diritto privato» (essendo anzi prodotto da e diretto a enti pubblici), né diritto «costituzionale» o «pubblico» (in quanto non riguardava competenze esclusive dello stato). Esso venne dunque definito come «amministrativo», e ben presto richiese che le controversie che la sua interpretazione generava fossero risolte da organi giudiziari specializzati in questo settore. Proprio quasi alla fine del secolo in Italia, con le riforme promosse da Francesco Crispi nel 1888-89, vennero istituiti tribunali amministrativi particolari; ma si tratta di un episodio all’interno di un trend europeo.
Questo era, a grandi linee, il sistema politico dell’Europa alla fine dell’Ottocento e questo era il sistema che sembrava avere più contraddizioni che punti d’equilibrio.
La nozione di cittadinanza su cui esso si fondava era infatti invecchiata. Il sistema liberale classico aveva guardato a una sorta di repubblica idealizzata, composta da cittadini-produttori tutti indipendenti, con un buon livello di cultura, attivi a determinare le scelte politiche e ideali all’interno di comunità in cui questi membri si conoscevano e interagivano. Al contrario, nel corso del secolo era diventato sempre più evidente che una larga parte di cittadini non esercitava più attività che garantissero una indipendenza economica certa, che essi non avevano livelli culturali particolarmente raffinati, che non erano in grado di esercitare scelte individuali in materia di consumi sia materiali che culturali, che erano spesso inseriti all’interno di ampie comunità in cui si rimaneva sostanzialmente estranei gli uni agli altri. Con una certa enfasi ed esagerazione alcuni scrittori cominciarono a parlare di una «età della folla» o di una «età della massa».
Però questa massa non era affatto amorfa e indolente come ci si sarebbe potuto aspettare: al contrario, essa premeva per giocare un ruolo politico. Non solo era ormai evidente che i partiti operai o comunque i sindacati operai avevano portato sulla scena un proletariato attivo e consapevole dei propri diritti, ma l’organizzazione politica veniva scoperta come risorsa utilizzabile per il negoziato col potere pubblico da vari segmenti della società, fossero questi connotati dalla loro appartenenza religiosa (come nel caso dei movimenti politici cattolici) o dalla loro collocazione sociale (come nel caso dei movimenti legati al mondo rurale). A rimanere ai margini sembravano essere proprio quei ceti medio-alti che erano stati la spina dorsale della prima rivoluzione liberale e che ora pensavano di avere maturato una tranquilla posizione di rendita politica.
Il vivace dibattito che si era av...
Indice dei contenuti
- La crisi di fine secolo e il sistema liberale
- La crisi del sistema liberale e la prima guerra mondiale
- Liberalismi in transizione
- La sfida dei fascismi
- La risposta del costituzionalismo liberale alla sfida dei fascismi
- La definitiva vittoria del modello liberal-democratico e le sue trasformazioni
- Bibliografia