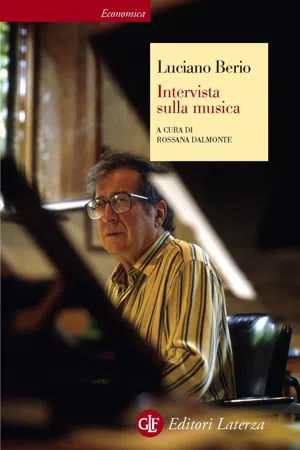
- 174 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Intervista sulla musica
Informazioni su questo libro
«Cercare di definire la musica è un po' come cercare di definire la poesia: si tratta cioè di un'operazione felicemente impossibile. La musica è tutto quello che si ascolta con l'intenzione di ascoltare musica».
Un grande maestro racconta le proprie idee ed esperienze e, in pagine di grande suggestione, tratteggia un panorama della musica postdodecafonica fino alle elaborazioni elettro-acustiche ed elettroniche, in un grande invito alla libertà di ascolto.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Intervista sulla musica di Luciano Berio,Rosanna Dalmonte in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Media & Performing Arts e Music History & Criticism. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Media & Performing ArtsCategoria
Music History & Criticism1.
Cos’è oggi la musica
D. Dal momento che la nostra conversazione si intitola Intervista sulla musica, mi pare che per prima cosa convenga chiarire cosa intenda tu per musica.
R. Sarei tentato di risponderti che la musica è l’arte dei suoni, ma rischierei di farmi domandare che cos’è l’arte e allora sarebbe peggio. Temo che mi sia impossibile risponderti. È una domanda difficile e, tutto sommato, un po’ indiscreta. Difficile perché la musica, sia per chi la produce che per chi la riceve (ammesso che una tale divisione dei ruoli sia possibile), è un insieme di tanti fenomeni diversi che prende forma in tante zone e livelli diversi della nostra coscienza e della realtà: temo sia impossibile rinchiudere questo insieme di esperienze in una definizione. Suppongo che per la stessa ragione risulterebbe altrettanto difficile a uno scienziato dirti che cos’è la scienza, a un poeta dirti cos’è la poesia e a un pittore, ma non ne sono sicuro, dirti cos’è la pittura. La tua domanda è anche indiscreta, oltre che difficile, perché mi invita a tracciare in due parole il senso del mio lavoro musicale, cioè della mia vita. È una cosa che mi procura un certo imbarazzo e che preferisco lasciar fare agli altri. Ci ho provato, qualche volta, in interviste meno importanti di questa e me ne sono sempre pentito perché non riuscivo mai a riconoscermi in quello che avevo detto: ne mancava sempre un pezzo. E poi non ho la vocazione dell’oracolo. Lo spettacolo di chi vuol spiegare il senso ultimo del suo lavoro e fa l’esegesi delle proprie opere musicali tracciandone la «filosofia», l’«ideologia», la «sociologia» e la «politica» si risolve troppo spesso in deliranti elzeviri verbali, che possono dirci cose anche molto interessanti sulla personalità e sulle nevrosi dell’autore ma poco su quello che fa o che ha fatto. Mi sembra che un musicista possa coerentemente parlare di se stesso soprattutto parlando degli altri e di quanto gli sta intorno e alle spalle. C’è sempre una zona di irrealtà nell’opera musicale che può essere avvicinata solo attraverso la mediazione di opere assimilate e di esperienze fatte, con le quali non dobbiamo necessariamente identificarci, ma che noi avviciniamo e osserviamo – cioè amiamo – perché a noi sembra che su di esse più che su altre si sia incollata la storia e perché siamo portati a investire in esse, più liberamente, forse il meglio non realizzato di noi stessi e, più scopertamente, il nostro inconscio musicale. Schumann che scriveva di Chopin completava e immaginava se stesso, Berlioz che scriveva di Beethoven proiettava se stesso, Debussy che scriveva di Mussorgskij descriveva se stesso, così per Schoenberg che scriveva di Brahms e Boulez che scrive di Berg. Con un po’ di buona volontà non è poi tanto difficile accettare l’immagine di un Bach che, seduto al cembalo, parla di Couperin o l’immagine di Mozart e Beethoven che, seduti al forte-piano, fanno una conferenza su Bach. È invece grottesca e addirittura ripugnante l’immagine di Bach che spiega le sue Partite per violino solo, di Mozart che parla dei suoi quintetti per archi e di Beethoven che fa un’analisi della sua Quarta Sinfonia per i dignitari di corte. Nessuno si sarebbe sognato di domandare a Beethoven che cos’è la musica. Oggi invece lo si fa. L’ho fatto anch’io, parecchi anni fa, quando – introducendo una serie di trasmissioni televisive – ho chiesto a una decina di musicisti da Boulez a Cage, a Milhaud, Stockhausen e Bernstein: perché la musica?
D. Sarebbe interessante capire perché, a partire dalla morte di Beethoven, si è cominciato a parlare e a scrivere tanto di musica.
R. Forse perché la musica ha cessato di essere un’attività obiettiva volta ad assolvere specifiche funzioni sociali ed è diventata, almeno nelle intenzioni, il veicolo di espressioni e di idee personali. La musica si è consapevolmente trovata coinvolta nell’universo dei segni, si direbbe oggi, e delle idee. Il compositore, come il pittore e il poeta, è diventato un «artista» i cui ideali e la cui visione del mondo sembravano snobbare la chincaglieria artigiana della professione musicale. Si è creata una distanza fra idea e pratica musicale e il musicista consapevole ha dovuto spiegarla e colmarla, questa distanza, a un pubblico diverso, a un pubblico che pagava e che voleva riascoltarla una sinfonia, non solo ascoltarla. È apparsa quindi l’Estetica che è corsa in aiuto di chi parlava e scriveva di musica e di arte, allora come oggi. Il compositore ha cominciato a parlare del suo lavoro e delle sue visioni da quando si è staccato dal far musica in maniera diretta, da quando ha cessato, o quasi, di essere un musicista pratico e ha cessato di essere esecutore e di doversi tenere quasi quotidianamente in esercizio su uno strumento. Chopin e Brahms, grandi pianisti, non ci hanno lasciato scritti. E neppure Messiaen, grande organista, ci lascia scritti (il suo Technique de mon langage musical è imbarazzante anche nel titolo). Invece Schumann (che si era accidentato a un dito e non poteva più suonare il pianoforte), Berlioz (che suonava malamente la chitarra), Wagner e Schoenberg (che non erano certo virtuosi dei loro rispettivi strumenti, il pianoforte e il violoncello), ci hanno lasciato una quantità significativa di scritti. Penso che sull’argomento (che a conti fatti verte sulla distinzione capitalistica fra lavoro intellettuale e lavoro manuale) varrebbe la pena di farci almeno una tesi di laurea in una facoltà di Sociologia – senza dimenticare che a partire da Beethoven tutti gli aspetti del processo creativo, anche i più infimi, hanno cominciato ad avere un prezzo: i manoscritti del compositore, gli occhiali del compositore, la cartolina postale del compositore, il letto del compositore, la sua pagella, la sua casa, la sua sedia, le abitudini e, naturalmente, le sue interviste.
Cercare di definire la musica – che in ogni caso non è un oggetto ma un processo – è un po’ come cercare di definire la poesia: si tratta cioè di un’operazione felicemente impossibile, considerando la futilità di voler sancire ove sia il confine fra quello che è musica e quello che musica non è, fra la poesia e la non-poesia. Con la differenza, però, che nella poesia la distinzione, implicita, fra lingua e letteratura, fra lingua parlata e lingua scritta, rende più agevole la definizione di quel confine. Forse la musica è proprio questo: la ricerca di un confine che viene continuamente rimosso. Nei secoli scorsi, per esempio, il «confine» tonale delimitava territori precisi e profondi. Oggi i territori sono vastissimi, i confini quanto mai mobili e di natura diversa. Anzi, l’oggetto della ricerca musicale e della creazione, spesso, non è neppure la definizione di un confine percettivo, espressivo e concettuale ma, piuttosto, la rimozione in se stessa: cioè l’azione «avanguardistica» del rimuovere. E in questo caso, paradossalmente, diventa facile rispondere alla tua domanda: la musica è tutto quello che si ascolta con l’intenzione di ascoltare musica.
D. Pensi che questa definizione, ritagliata dall’esperienza di un musicista europeo di oggi, possa essere allargata ad altre epoche e a culture diverse?
R. In altre culture i confini sono più stabili e spesso il problema del confine non si pone neanche perché neppure si pone il problema dei rapporti culturali, dei rapporti di produzione musicale e della musica come arte: non ci sono territori da separare e non esiste neanche l’idea di musica. Per i Banda-Linda dell’Africa centrale, per esempio, esistono solo attività concrete e specifiche (il battere, il soffiare, il cantare e il danzare) definite da funzioni sociali e religiose. Le loro attività sonore sono cioè parte di un contratto sociale ovvio e – che i Banda-Linda e i loro amici etnomusicologi mi perdonino – piuttosto elementare. Quello che non è riconducibile a un ritmo di base, battuto con le mani e condiviso da tutti in modo esplicito, per loro non ha senso. A me interessa capire il funzionamento di questi linguaggi collettivi, unanimi, che permangono (di solito fino all’arrivo dissacrante della radio o di qualche trauma socio-economico) indipendentemente dagli individui che li parlano e li agiscono, come dei fenomeni naturali. Osservando e ascoltando questi comportamenti ho l’oscura sensazione, talvolta, di assistere a uno spettacolo remoto e originario della natura che diventa faticosamente cultura, del «crudo» in procinto di essere «cotto». Comunque, fuor di metafora, è certo che talvolta si ha l’impressione di mettere gli occhi su alcuni nodi fondamentali, su alcuni universali delle vicende musicali dell’Occidente – com’è il caso, per esempio, delle tecniche prepolifoniche, degli «hochetus» dell’Africa centrale, immobili nei loro confini. Il nostro compositore, invece, l’artista creatore sempre young man e sempre intento a dar forma all’«increata coscienza della sua razza», è come un navigatore che passa attraverso confini diversi iscritti nella sua storia: attraversa arcipelaghi sconosciuti ed approda a isole misteriose che crede d’essere il solo a conoscere e che descrive agli altri in suoni. Più consapevole è la rotta e più difficile è la navigazione.
Quando dietro il fare e l’ascoltare musica non c’è un contratto sociale unanime ed omogeneo – come c’era nell’epoca barocca e, chiedo scusa, fra i Banda-Linda di Bokassa – allora ci sono tanti modi di intendere la musica quasi quanti sono gli individui che le si avvicinano. Ognuno di questi modi può essere più o meno semplice e più o meno consapevole, ma in sé sarà sempre corretto: può essere descritto in maniera relativamente precisa, se ne possono isolare i parametri d’ascolto e questi, con un po’ di pazienza, possono anche essere iscritti in un codice. Resta però il fatto che l’insieme di questi modi, che questo pullulare di modi d’ascolto, non sarà mai sufficiente a comunicare un’immagine globale e sintetica dell’esperienza musicale. È un po’ come voler comunicare il senso della Vita, di Dio e dell’Umanità. Se io fossi credente e tu mi domandassi che cosa io intenda per Dio, ti risponderei che non lo so e che Dio deve necessariamente configurarsi negli uomini, ma quello che gli uomini fanno e pensano non è Dio. Lo stesso può valere per la musica nel mondo: si configura in tanti modi e ha tante funzioni diverse, ma questi modi e queste funzioni non sono, da soli, la musica. Si tratta di una contraddizione molto importante e salutare ch’è poi il motore del mondo umano, di un mondo dove spesso il senso è irriducibile alla conoscenza e viceversa. Se si potesse rispondere in maniera esauriente e definitiva alla tua domanda, significherebbe che un certo processo umano molto complesso e anche un po’ misterioso, quale è l’espressione musicale, è giunto a compimento e, poveri noi, potremmo veramente celebrare, con gli avventurieri, la morte della musica e, con gli idioti, il silenzio. E questa morte diventerebbe il segnale di tante altre morti perché sarebbe come rispondere in maniera definitiva al quesito, sempre aperto, del rapporto dell’uomo col mondo, attraverso i suoi segni e i suoi simboli e significherebbe rinunciare a una visione creativa di quel rapporto che è sempre da fare e che è, come il mare di Valéry, toujours recommencée. Te lo immagini un mondo – il nostro, non quello dei Pigmei – dove non si pone più il problema della ricerca e dell’osservazione di un’azione sociale della e sulla musica, della dimensione spirituale, estetica, tecnica, intellettuale e affettiva dell’esperienza musicale perché, come in un’analisi di mercato, s’è trovata una risposta a tutto, non c’è più nulla da cercare all’infuori di qualche suono nuovo? Oppure te lo immagini un mondo che si riempie improvvisamente della musica di Eisler – posto che ne avesse scritta abbastanza – perché lui sapeva tutto, aveva una risposta per tutto ed era capace di dirti, con due parole perentorie, che cos’è e a che cosa serve la musica?
Forse si potrebbe dire della musica quello che si dice d’ogni altra esperienza umana – ma non sono poi tante – che, armonizzando e trasformando natura e cultura, è insieme pratica ed empirica, ma allo stesso tempo coinvolge le zone più profonde del nostro essere. Nella musica, cioè, la dimensione empirica e sensibile da una parte e la dimensione intellettuale e spirituale dall’altra — il corpo e l’anima, come dicevano gli antichi – si identificano in sistemi di relazione che noi mettiamo sempre alla prova, con pazienza, anche quando appaiono oscuri alle orecchie della nostra mente. Scusa la retorica, ma da una domanda terribile come la tua forse se ne può uscire solo con una formula paradossale e spiritosa alla Umberto Eco o con una risposta giusta e pacata alla Massimo Mila: loro, in fondo, possono permettersi di fare un passo fuori della musica e guardarla come una gallina che fa l’uovo...
D. Qual è, secondo te, il modo più corretto per avvicinarsi a un’esperienza tanto vasta e complessa?
R. Penso che tutte le maniere di fare, di ascoltare la musica e anche di parlarne siano a loro modo corrette. Quando una musica è dotata di sufficiente complessità e di un sufficiente spessore semantico, allora può essere avvicinata e compresa in modi diversi. La maggior parte delle canzoni commerciali, così come le tappezzerie sonore che si autoproclamano d’avanguardia e la traduzione in musica del gioco della tombola, hanno un solo livello d’ascolto: ma c’è la musica che ha molti livelli d’ascolto e che è produttrice continua di senso musicale. Più semplice e monodimensionale è il discorso musicale e più diffuso e immediato è il suo rapporto con la realtà quotidiana. Più concentrata e complessa è la struttura musicale, più concentrato e selettivo è il suo rapporto sociale, mentre molteplici sono i suoi significati. Una canzone, insomma, può esprimere un momento del lavoro e delle affettività umane ed è uno strumento immediatamente «utile» all’uomo, nei momenti diversi della giornata e dei mesi dell’anno: ma si tratta comunque di uno strumento sostituibile. Le opere musicali complesse, invece, sono momenti insostituibili di un processo storico. Basta pensare a Beethoven e a Schoenberg: i loro processi musicali, il loro pensare musicale, sembrano spesso dotati, addirittura, di un eccessivo spessore semantico. Ce n’è sempre per tutti e ne avanza sempre un po’ che rimane nell’ombra, in attesa di un approccio diverso. Non credo a chi mi dice: «questa musica non la capisco, me la spieghi?». Vuol dire che non capisce se stesso e il luogo che occupa nel mondo e che non sospetta che la musica è anche un prodotto della vita collettiva. Qualche volta ho la curiosa sensazione che i processi musicali possano essere più intelligenti degli uomini che li producono e li ascoltano, questi processi; che le cellule di questi processi musicali, come i cromosomi di un codice genetico, possano essere più intelligenti degli organismi percettivi che dovrebbero dar loro un senso e ho l’impressione che la musica mimi uno dei più incredibili processi naturali: il passaggio dalla vita inanimata alla vita animata, dalle forme molecolari alle forme organiche, da una dimensione astratta e immobile a una dimensione vitale ed espressiva. La musica deve poter educare gli uomini a scoprire e a creare relazioni fra dimensioni, caratteri ed elementi diversi (la musica «è tutta relativa», diceva Dante), e così facendo parla della storia dell’uomo e del suo apparato musicale con le sue vicende acustiche, sociali, intellettuali, espressive. Mi interessa la musica che crea e sviluppa relazioni fra punti molto lontani tra loro, su un percorso di trasformazioni molto ampio (come le Variazioni Diabelli di Beethoven, per esempio). Chi ascolta deve rendersi conto che ci sono modi diversi di cogliere il senso di questo percorso così come ci sono modi diversi di sperimentare un incontro, sia pur passeggero, fra la vita dei comportamenti pratici e la sfera più profonda dell’individuo. La musica, insisto, non può staccarsi dai gesti, dalle tecniche, dai modi di dire e di fare – eppure non si esaurisce in essi, e per il fatto di essere allo stesso tempo pratica e pensiero realizza un’unità che trascende, appunto, l’opposizione del sensibile e dell’intelligibile. È per questo che la musica è uno strumento prezioso e, spesso, difficile anche per chi deve solo ascoltarla.
D. Rivolgendo a un compositore queste domande ci si aspetta una risposta orientata in qualche modo sul versante della produzione. Tu invece ti sei soffermato piuttosto sugli effetti della musica sull’uomo. Si potrebbe dire che, pur essendo un «produttore», hai scelto per definire la musica il punto di vista del «fruitore».
R. È probabile. Ma non credo che quella del «produttore» e del «fruitore» siano entità molto separabili. Tra un’opera musicale e chi l’ascolta c’è meno distanza storica che tra un quadro e chi lo guarda. Le opere musicali non si coprono di quella «vernice dei maestri», di quella «vernice di vecchio violino», di quella vernice del tempo, insomma, che colloca la grande pittura del passato a una certa distanza da noi. Le grandi opere musicali del passato vanno «rifatte» e reinterpretate continuamente, anche a costo di trascriverle e di farle risuonare su strumenti completamente diversi. È nella loro stessa natura che questo avvenga. Basta non dimenticare che le necessità industriali della musica hanno feticizzato e formalizzato i suoi mezzi. Una volta le orchestre erano raggruppamenti piuttosto «aperti» di musicisti. Nello stesso anno, una sinfonia di Haydn poteva essere eseguita con cinquanta violini a Londra e con dodici violini a Dresda. La musica ha insomma bisogno di interpreti e già questo fatto, da solo, rende pressoché inestricabile il rapporto fra «produzione» e «fruizione» musicale. Delle illustri dame come Gisèle Brelet e Susan Langer si sono occupate del problema che a me, francamente, non interessa molto. Posso solo confessarti che quei due termini («produzione» e «fruizione») non mi piacciono perché suggeriscono l’idea di una fabbrica che produce beni di consumo musicale e di gente che li compra e se li mangia. La mia avversione per questi termini è forse eccessivamente istintiva e viscerale; come la mia avversione per un altro termine di uso frequente: «operatore culturale». Un termine sociologicamente, antropologicamente e culturalmente demente. Mi piace pensare che gli uomini facciano delle cose e dei mestieri precisi e mi piace pensare che un pescatore o un contadino siano produttori di cultura almeno quanto un burocrate o un mezzobusto televisivo. Il musicista e l’ascoltatore non appartengono a due diverse categorie socio-culturali. Sono un compositore ma sono io stesso un ascoltatore, anzi, per quel che mi riguarda, sono il miglior pubblico che io conosca. Sono l’incarnazione di un pubblico ideale.
D. Questa tua visione del pubblico di cui ti senti un’«incarnazione» toglie alla vasta categoria degli ascoltatori una fascia che certamente non si può non dico identificare, ma neppure assimilare al pubblico-Berio.
R. Non lo so, forse. È comunque certo che il termine pubblico è un po’ astratto e generale: come dire i turisti, le mogli, i pazienti e gli ariani. Mi preme solo insistere sul fatto che il processo creativo musicale implica l’ascolto, sia individuale che pubblico, e che parlare e scrivere di musica, come appunto stiamo facendo noi adesso, implica sempre una storia degli ascolti possibili. Vorrei però aggiungere che per me il pubblico ideale è quello che ha tante facce e che si avvicina alla musica con tante diverse motivazioni. Un pubblico che ha una fisionomia opposta a quello, poniamo, di Bayreuth vecchia maniera, che riprenderà certamente il sopravvento dopo la Tetralogia di Chereau-Boulez, oppure il pubblico degli abbonati di qualsiasi grande Teatro d’Opera (dalla Scala al Teatro Comunale di Firenze) di qualsiasi grande istituzione di concerti (dalla Filarmonica di New York a Santa Cecilia di Roma). La distinzione del pubblico in categorie non riguarda necessariamente la musica ma l’industria musicale che vive, appunto, di categorie definite dal loro reale virtuale potere d’acquisto. A parte i problemi dell’educazione musicale, che meritano un discorso a parte e che, pur nei loro aspetti negativi, non hanno un’influenza così immediata e diretta sul vasto pubblico degli ascoltatori come invece ce l’hanno le operazioni industriali, vorrei insistere ancora sul fatto che, secondo me, tutti capiscono, a loro modo, la musica. Penso addirittura che non ci sia un modo giusto e un modo sbagliato di ascoltarla: ci sono modi più semplici e modi più complessi. Per esempio, ci può essere una lettura solamente armonica ed erotica di...
Indice dei contenuti
- 1. Cos’è oggi la musica
- 2. Da Oneglia agli Usa
- 3. L’esperienza «seriale»
- 4. I giovani musicisti
- 5. Il mestiere di compositore
- 6. In margine alle note