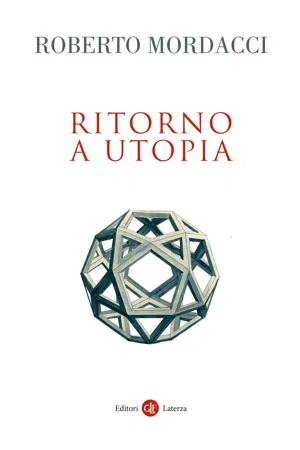1.
Sul concetto di utopia
1. In principio era il nome
L’utopia ha inizio da un nome. Originariamente, infatti, Utopia non è un concetto. È solo una parola evocativa, frutto di una brillante quanto semplice invenzione linguistica: è un luogo (-topia) chiamato non-luogo (ou-topia) che è, a un tempo, un buon-luogo (eu-topia). La parola originaria dà il nome all’isola dove Sir Thomas More, nel 1516, immagina la sua repubblica ideale, contro-specchio critico della sua Inghilterra e proiezione del sogno umanistico di una società giusta e armonica. Si sa che un luogo simile non esiste, ma è proprio per questo che esso è un’insuperabile obiezione contro l’ingiustizia, il sopruso, l’inimicizia e l’odio. Nessuno immagina la società ideale come una comunità in perenne conflitto, ostile, iniqua e infelice. Quest’ultima è piuttosto la triste realtà che ci si presenta ogni giorno nell’esperienza, mentre l’altra immagine, quella di armonia e felicità, è viva solo nella fantasia. Eppure, la nostra mente la considera non meno reale, o almeno altrettanto possibile, se solo non fossimo così stolti. Perciò, Utopia è a un tempo il luogo che non c’è e il luogo felice, buono, dove è consentito essere realmente umani. Quest’ambiguità del nome non è casuale, bensì il frutto di una precisa scelta, che More compie solo dopo molti tentativi e al prezzo di fraintendimenti che egli – come vedremo – volge infine genialmente a suo favore.
Fin dall’inizio, infatti, il nome della nuova isola che More andava vagheggiando si basa sulla negazione di ciò che rappresenta. Lo si vede nel carteggio con Erasmo da Rotterdam, il grande umanista amico di More e spesso suo ospite in Inghilterra. Pochi mesi prima della pubblicazione del suo racconto (torneremo sulla questione del genere letterario), More chiama ancora la sua repubblica Nusquama, derivando il nome dal latino nusquam, letteralmente «da nessuna parte»: ciò che in inglese si dice con nowhere e che infatti tornerà più volte nella letteratura utopica. Ma poco dopo, avendo optato per il greco come una delle radici dell’immaginaria lingua degli utopiani, More ricrea i toponimi in base a termini greci e anche il nome dell’isola diventa U-topia, la cui interpretazione più immediata è appunto quella di non-luogo.
Già nel titolo latino completo dell’opera, tuttavia, More lascia apparire il vero senso della sua scelta. Il titolo recita, infatti: De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, ovvero «della miglior forma di Stato e della nuova isola Utopia». È evidente che More intende descrivere una condizione ideale dello Stato, o più precisamente (in base al significato letterale) «lo stato ottimale della cosa pubblica», e che quindi il nome della «nuova» isola (che nuova non è, come vedremo, se non nel senso di essere appena stata scoperta) non può essere ridotto alla sola indicazione della sua non esistenza. Fin dal titolo dell’opera, dunque, l’isola chiamata «Non-luogo» è dichiarata esistente e di recente rinvenimento, al punto che nel frontespizio dell’edizione definitiva, quella del 1518, il nome Utopia è omesso dal sottotitolo e si dice solo che l’opera tratta De optimo reipublicae statu: il racconto di viaggio è in realtà un trattato politico in piena regola.
D’altra parte, intorno al nome è sorta ben presto una disputa (vi fu addirittura chi scrisse un Antimorus): in greco antico, infatti, il prefisso ou- vale come negazione davanti ai verbi, ma non davanti ai sostantivi; per questi ultimi è invece richiesto a- (alfa privativo). Perciò, a rigore, More avrebbe dovuto chiamare la sua isola A-topia. Tuttavia, certamente un fine umanista come More non poteva commettere un errore così grossolano. Si trattava dunque di una scelta, dettata proprio dall’ambiguità fra ou- ed eu-. Scrivendo U-topia More lasciava deliberatamente aperta la doppia interpretazione del nome.
È certamente per questo che, sempre nell’edizione del 1518, si trovano come esergo alcuni versi dal tono ironico, che si suppongono pronunciati dall’isola stessa (sono in realtà dell’amico Pieter Gilles), rivolti probabilmente proprio a chi non aveva compreso l’intento dell’autore. I versi sono i seguenti:
Gli antichi mi chiamarono Utopia per il mio isolamento; adesso sono emula della repubblica di Platone, e forse la supero (infatti, ciò che quella a parole ha tratteggiato, io sola lo attuo con le persone, i beni, le ottime leggi), sicché a buon diritto merito di essere chiamata Eutopia.
È significativo che l’Utopia di More rivendichi per sé la realizzazione degli ideali platonici di società giusta e armonica, che ha la sua concretezza nelle persone, nei beni e nelle leggi, non solo nella fantasia di un filosofo. More sottolinea così il carattere eminentemente possibile e non solo ideale della società che tratteggia. Ou-topia si è meritata il nome di Eu-topia proprio realizzando sé stessa, uscendo dall’isolamento ideale e prendendo corpo nella vita sociale.
Proprio questo è uno dei marchi fondamentali del pensiero politico moderno: pensare la realtà sociale come realmente plasmabile secondo un ordine ragionevole e giusto, non limitarsi a contemplare l’ipotesi astratta di un mondo perfetto. Pensare in modo sistemico, tenendo conto della complessità della socialità umana, pur non rinunciando a indicare un dover essere, saldamente ancorato al reale ma non di meno proiettato verso come ha da essere il nostro vivere civile.
Per questa ragione, l’utopia e il pensiero utopico sono esclusivamente moderni, mentre l’archetipo platonico – come vedremo – ha una natura totalmente differente. L’utopia pretende la propria realtà, la promuove nel momento stesso in cui descrive sé stessa come un’opzione possibile, in radicale opposizione all’esistente e non come mero modello ideale. Anzi, a ben vedere Utopia non è affatto pensata come un prototipo universale: è una realizzazione unica, contingente, favorita da condizioni storiche particolari. Essa, tuttavia, dimostra che un diverso ordine sociale è possibile. Dunque, More usa il doppio volto dell’ironia per dire che l’ottimo, ovvero l’elemento ideale-platonico, è non-esistente ma possibile e anzi vi sono testimoni oculari della sua esistenza, come il marinaio-narratore Raffaele Itlodeo. Ma perché esso si realizzi, un insieme di condizioni si devono realizzare, e queste sono diverse nel tempo non meno che nello spazio. Tuttavia, dall’osservazione di una comunità politica ben funzionante si possono inferire i principi che ne stanno alla base. È questo l’esercizio di Utopia: osservare la realtà di una società giusta e felice e comprenderne le basi, invece che piantare queste ultime nel cielo e farne discendere un castello inabitabile.
L’elemento ideale è sempre presente, ed è frequentemente richiamato nelle scelte dei nomi. I nomi, infatti, indicano cose reali, realtà individuali. Ma esse contengono nondimeno l’ideale. Esso è esplicitamente presente nella denominazione che More assegna alla penisola che già esisteva prima di Utopia e che il mitico fondatore Utopo conquistò in tempi ormai lontani: Abraxa. Questo nome significa letteralmente «non bagnata da pioggia». Ma non solo: infatti, quando More vuole semplicemente giocare sul paradosso della mancanza d’acqua, egli sceglie di chiamare il fiume che bagna Utopia Anidro («fiume senz’acqua»), con il consueto ricorso alla negazione. Qui c’è qualche cosa che va oltre la mancanza di precipitazioni. Nella scelta di Abraxa come nome originario di Utopia vi è il rimando a qualcosa di più profondo e più complesso.
Abraxas è, infatti, un termine di etimo incerto che si trova nei testi gnostici. Esso indica il divino che media fra l’umano e il cielo, benché il significato sia ampiamente discusso perché legato a rituali misterici e a pratiche magiche. L’origine rimanda al culto di Mytra, che non a caso è il nome assegnato al divino in Utopia, ma che si ritrova anche nell’induismo, nella religione persiana (zoroastrismo) e nell’ellenismo. In quest’ultima tradizione, in particolare, Mytra ha figura umana e sconfigge un toro (tauroctonia) con l’aiuto di uno scorpione e di un serpente. Aiutato da forze più ingegnose che potenti, Mytra piega la forza brutale della natura. È dunque anch’esso una figura di mediazione fra umano e divino. Ora, se consideriamo che, in alcuni te...