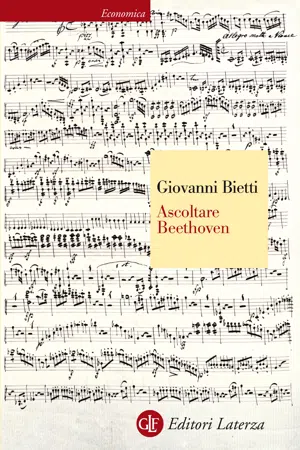1.
Il “Primo stile”:
due opere a confronto
Sonata op. 2 n. 3, 1795
Sonata op. 13 (Patetica), 1798/99
Le strategie di ampliamento e di estensione della forma musicale impiegate da Beethoven nel cosiddetto “Primo periodo” sono essenzialmente due, in qualche caso ben distinte ma più spesso strettamente intersecate: da una parte la proliferazione del materiale, il moltiplicarsi di gruppi tematici, di episodi secondari; dall’altra l’uso senza precedenti di “parentesi” drammatiche che lasciano sospesa una risoluzione prolungando lo stato di tensione e ampliando il respiro della composizione.
Beethoven è chiaramente consapevole della differenza radicale tra i due procedimenti, e infatti in alcuni casi accosta deliberatamente due composizioni costruite sui due diversi principi, realizzando quindi alcune delle “coppie contrastanti” che come si è visto caratterizzano l’intera sua carriera. (Consiglio ad esempio al lettore di ascoltare le due bellissime Sonate per violoncello e pianoforte op. 5, che illustrano i due diversi modi di organizzare la forma in modo davvero paradigmatico.)
Sonata in Do Maggiore, op. 2 n. 3
Un esempio eclatante del primo tipo di procedimento sopra menzionato, la moltiplicazione dei materiali musicali, si può osservare nel primo movimento della Sonata in Do Maggiore op. 2 n. 3. Qui Beethoven inserisce alcuni “materiali” chiaramente identificabili che hanno con ogni evidenza lo scopo di estendere l’arcata formale, di prolungare i momenti salienti di accumulo della tensione e di ritardarne lo sfogo; insomma, di “dare più spazio” al movimento. Tali materiali, molto diversi tra loro, sono:
1) un episodio ricorrente dal carattere virtuosistico (quasi “alla Clementi”) in arpeggi e ottave spezzate;
2) un tema lirico in minore, che si presenta dove ci aspetteremmo invece il Secondo tema;
3) una ampia cadenza “solistica”, che conduce all’ultima ripetizione del Primo tema e alla Coda conclusiva.
La cadenza appare una sola volta, ma gli altri due elementi sono invece ricorrenti, e proprio la loro riapparizione “simmetrica” accentua la sensazione all’ascolto che essi abbiano essenzialmente la funzione di ampliare le dimensioni temporali del brano, anche perché Beethoven li utilizza in alcuni momenti nodali della forma. L’episodio in arpeggi/ottave appare ben due volte nell’Esposizione, tre se consideriamo anche la Chiusa; nella Ripresa manca la prima enunciazione, mentre la seconda si presenta nel punto corrispondente all’Esposizione, così come la Chiusa. Nell’articolazione della forma, è facile osservare come questi episodi siano situati subito dopo l’affermazione dei due temi principali: il primo di essi prende le mosse dalla fine del Primo tema e conduce verso la prima – provvisoria – affermazione della Dominante; il secondo si allaccia direttamente al Secondo tema e conduce verso la perorazione della cadenza e la successiva chiusa. È chiaro che i due episodi servono a prolungare il percorso che conduce, rispettivamente, dalla Tonica alla Dominante e poi dal Secondo tema alla chiusura.
La presenza di un tema in tonalità nuova, in genere minore, prima dell’affermazione della Dominante e del Secondo tema è ricorrente nelle opere giovanili di Beethoven (troviamo lo stesso procedimento, ad esempio, nei movimenti iniziali delle Sonate op. 2 n. 2, op. 10 n. 3, op. 13). La ricorrenza di questi episodi è stata spesso osservata, e le sono stati attribuiti vari significati; per conto mio, sono convinto che essi abbiano essenzialmente la funzione di ritardare l’affermazione della Dominante, creando nell’ascoltatore maggiore attesa verso questo momento cruciale nell’articolazione della forma-sonata. Nell’op. 2 n. 3 questa apparente “asimmetria” formale è a ben vedere riequilibrata proprio dalla presenza dei due episodi in arpeggi e ottave spezzate: l’enunciazione del semplice tema in minore prima del Secondo tema vero e proprio avrebbe rischiato di far apparire la forma troppo rapsodica, e si sarebbe pertanto rivelata controproducente rispetto all’intenzione del compositore che, come si è visto, era quella di dare maggiore risalto all’affermazione della Dominante. Beethoven sceglie quindi di inserire altri materiali, dal carattere volutamente più “neutro” e convenzionale, per equilibrare la forma dandole più continuità e scorrevolezza.
Beethoven abbandonò quasi del tutto questo procedimento – l’introduzione in un brano di semplice “tessuto connettivo”, per estendere lo spazio di una composizione – nelle opere del cosiddetto “Secondo periodo”; tuttavia, alcune opere tarde mostrano un nuovo interesse verso questo tipo di pensiero, sia pure notevolmente raffinato e integrato nella struttura del brano. Un esempio celebre sono gli arpeggi che compaiono nel corso del primo movimento della Sonata op. 110: anche in questo caso gli arpeggi nella loro completa atematicità appaiono “aggiunti”, e servono con ogni evidenza ad ampliare il percorso del brano. La differenza rispetto agli esempi giovanili consiste nel fatto che Beethoven evita con grande abilità che gli arpeggi costituiscano una sorta di “corpo estraneo”, inserendoli in un processo di progressiva accelerazione ritmica (dai valori larghi delle prime battute, all’accompagnamento in semicrome della seconda frase tematica, fino alle biscrome degli arpeggi) che li fa quindi percepire, ad un ascolto attento, come naturali e conseguenti. Il compositore fa poi cominciare la Ripresa sovrapponendo il bellissimo tema cantabile proprio all’accompagnamento degli arpeggi, e quindi mostrando a posteriori la conciliazione di elementi ritmici tanto diversi, rivelandoci come le diverse figurazioni ritmiche siano in realtà le diverse facce di un unico oggetto musicale.
Sonata in do minore op. 13, “Patetica”
Un esempio classico del secondo procedimento – l’uso di ampie “parentesi” di sospensione drammatica – possiamo trovarlo nella più celebre delle sonate del “Primo periodo”, la Patetica. A dire il vero, sarebbe possibile citare molte altre composizioni di questo periodo in cui l’uso di parentesi drammatiche e di artifici quali il “crescendo interrotto” è particolarmente significativo – una per tutte, la Sonata op. 10 n. 3, nei due movimenti estremi e per alcuni aspetti anche nel celebre Largo e Mesto. Nella Patetica, però, questi artifici si presentano in modo addirittura paradigmatico, e sono senza dubbio uno dei motivi principali della meritata fama del brano.
Ho già parlato della notevole “spazialità” dell’Introduzione lenta, dell’uso originalissimo di “pieni e vuoti” di grande impatto drammatico: densi accordi forte, a cui segue una enunciazione più rarefatta, piano; e questo procedimento viene ripetuto più volte, con un progressivo accumulo di volumi (le battute 5 e 6 “riempiono” tramite violenti fortissimo le pause delle corrispondenti battute 1 e 2, mentre la rapida volata discendente viene ripetutamente riecheggiata e ampliata nella seconda parte dell’Introduzione). Contrasto, tensione, spazio: si tratta di una delle Introduzioni lente più drammatiche e più memorabili mai scritte fino ad allora, talmente potente e originale da lasciar presagire all’ascoltatore che qualcosa di questa potenza, di questa tensione, di questa spazialità nuova debba trasferirsi nel successivo Allegro di molto e con brio. Fin dal celebre “gesto” ascendente iniziale, Beethoven ci dice che è proprio così, che la drammaticità dell’Introduzione era destinata a sfociare in un brano ancor più possente ed energico.
Osserviamo nelle prime battute dell’Allegro il dispiegarsi del “crescendo interrotto” per ben due volte: gesto ascendente, crescendo, poi proprio in corrispondenza della cadenza (batt. 19 e 26), dell’atteso punto di risoluzione, un piano improvviso che lascia accumulata la tensione; un artificio che si ritrova in molti altri punti del brano.
Il movimento verso il relativo Maggiore, la tonalità del Secondo tema, è chiaramente affermato; eppure Beethoven ritarda questa risoluzione. Ci presenta infatti un’idea tematica mossa (batt. 51), quasi danzante, dapprima in minore, poi modulante; la risoluzione nell’attesa tonalità di Mi bemolle Maggiore viene rimandata di oltre trenta battute.
Come succede spesso nelle opere di questo periodo, Beethoven ci fa attendere a lungo l’arrivo della nuova tonalità, quella del Secondo tema; per renderla più risolutiva? In questo caso, al contrario, l’attesa serve a dare maggiore tensione a questo apparente punto di arrivo: ciò che ascoltiamo ora, infatti, non è un “tema”; il ritmo accelera di colpo trasformandosi in un incessante ostinato di crome, e il tessuto musicale realizza un movimento regolare, contemporaneamente ascendente (nella mano destra) e discendente (nella sinistra), mentre la dinamica passa dal piano a un graduale ma inesorabile crescendo, fino a un forte sul quale si articola la cadenza. Questa, almeno, è risolutiva? Ancora una volta, no: la Tonica arriva con un nuovo piano improvviso, e riprende per la seconda volta il movimento ascendente/discendente, il crescendo, e una nuova cadenza risolve, finalmente, su quel Mi bemolle risolutivo (batt. 113) che abbiamo atteso per oltre sessanta battute.
La descrizione di questa straordinaria Esposizione è volutamente incalzante, proprio come lo è la musica; l’ascoltatore ha bisogno di riflettere a fondo sulla potenza e l’efficacia del procedimento beethoveniano (e Beethoven gli offre la ripetizione dell’Esposizione per fissare nella memoria queste strabilianti “linee di tensione”). Quattro volte Beethoven utilizza il “crescendo interrotto”, e in ognuno di questi casi il risultato è quello di proiettare in avanti la tensione del brano, di estenderne l’arcata drammatica. Dove aspettiamo una risoluzione giunge invece un’impennata, dove aspettiamo un tema giunge invece un’intensificazione ritmica e dinamica. Lo spazio e il ritmo dominano questo processo: le “folate”, dapprima ascendenti e quindi ascendenti/discendenti che conquistano le regioni estreme della tastiera per poi ripartire sempre dal registro centrale innalzando nuove ondate, si appoggiano ai “battimenti” di crome, che nella prima parte dell’Esposizione accompagnano in vari modi il moto ascendente, e nella seconda – dopo trenta battute di calma apparente – vi si contrappongono, creando con il moto contrario una tensione ancora maggiore, parossistica. Siamo già, con questo capolavoro profetico, in piena “forma come processo”...
Segue a questo punto, all’inizio dello Sviluppo, la prima, sorprendente riapparizione degli accordi con cui cominciava l’Introduzione: il gesto è magnifico, la sorpresa squisita, ma Beethoven non intende forse dirci che Introduzione e Allegro rappresentano, in un certo senso, le due facce di una stessa medaglia? Che in realtà tutto questo primo movimento esplora lo stesso gesto, potente e drammatico, basato sul contrasto, sullo spazio, sull’accumulo incessante di tensione?
È forse per questo che Beethoven, nell’offrirci l’ultima e più stupefacente sorpresa di tutto il brano, accosta nuovamente nelle ultime battute Allegro e Grave. Il movimento sta terminando, fortissimo, ma Beethoven lo lascia per l’ultima volta sospeso su un accordo dissonante, di settima diminuita (batt. 293-294). Riappare a questo punto il gesto dell’Introduzione lenta, ma senza gli accordi iniziali in forte: il contrasto tra Allegro e Grave è di per sé assoluto, e Beethoven ha bisogno di far sentire la riapparizione dell’Introduzione non come un ulteriore momento di tensione, ma al contrario come una sospensione totale – e allo stesso tempo come un’eco, una reminiscenza. Proprio questa assenza di moto, di drammaticità, è il colpo di genio di questo passo: l’accordo di settima su cui l’Allegro si era bruscamente interrotto resta accumulato nella nostra memoria, in attesa di risoluzione; attendiamo di riascoltarlo, e soprattutto di sentirlo finalmente risolvere. L’ultima ripetizione del tema iniziale, che sembrerebbe il punto finale del processo, non è invece che un nuovo ritardare la risoluzione, un nuovo estendere lo spazio del brano – a Beethoven serve, per realizzare appieno la sua idea strepitosa, il gesto ascendente del tema, che riconquista ancora una volta di slancio lo spazio della tastiera verso l’acuto – fino al ritorno dello stesso accordo di settima diminuita (batt. 305), nella stessa identica posizione (acutissimo nella destra e gravissimo nella sinistra) della battuta 293.
La potenza sconvolgente di questo procedimento si comprende appieno se si prova a suonare il passo senza la sospensione, ossia agganciando direttamente le battute 293 e 305: il percorso è coerente e risolutivo. Ma manca quel qualcosa in più di memoria, di visionarietà e soprattutto di senso di risoluzione che la versione completa, con la sua straordinaria sospensione, è in grado di comunicarci.
Questo è uno dei passi più importanti di tutte le opere giovanili di Beethoven, talmente efficace che il compositore riutilizzerà lo stesso principio per realizzare alcune delle più note e drammatiche sospensioni dell’intera sua opera, come quella – già esaminata – che precede la Ripresa nel primo movimento dell’Eroica o quella celeberrima, basata come in questo caso sulla memoria, sulla riapparizione trasformata di qualcosa che l’ascoltatore già conosce, nel ...