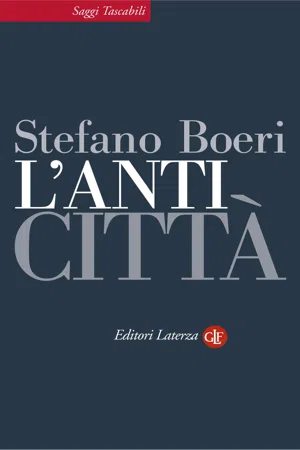
- 176 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'Anticittà
Informazioni su questo libro
Dallalto lItalia è un corpo maculato, un paesaggio a macchie sfumate.I suoi antichi connotati geografici sono stati ritoccati da una grana liquida di materia urbana che ha scavalcato selle, invaso pianure, colmato vallate.Generata da unenergia molecolare che cancella i confini tra città e campagna, annulla le differenze tra centro e periferia e frammenta le società urbane, lAnticittà si sta espandendo ovunque, trasfigurando un territorio ereditato da secoli di storia. Questo libro ci aiuta a conoscere e ad arginare la potenza di un fenomeno politico e sociale che ci riguarda tutti. Perché lAnticittà, ci piaccia o no, siamo noi.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
ArchitetturaCategoria
Architettura generaleIII. Uno sguardo diverso
1. Atlanti eclettici
1.1. I temi dello sguardo
Alcuni anni fa, riflettendo sulle caratteristiche dei testi di letteratura fantastica, il critico letterario Tzvetan Todorov distingueva tra i «temi dello sguardo» e i «temi del discorso»[30]. Secondo Todorov, i temi dello sguardo sono quelli che abitano le regioni più profonde del pensiero individuale, dove si annidano i paradigmi della soggettività e dove riposano le strutture dell’inconscio, prima di venir sottoposte all’obbligo della comunicazione e ai codici della verbalità, della trascrizione. Vedere è un atto fondativo del nostro rapporto individuale con il mondo, è una presa di distanza dalle cose e insieme un atto di possesso verso di esse, che stabilizza la posizione del soggetto e decide l’angolatura da cui può prendere parola. Quando sono condivisi, quando diventano cultura, tradizione, abitudine, i modi di vedere costituiscono dunque un denominatore fondamentale nelle relazioni sociali. I «modi di vedere» rappresentano una convenzione stabile di una collettività, proprio perché nascono dalla condivisione di un pensiero individuale e comandano i temi del discorso, ne fissano i codici[31].
Anche nell’evoluzione delle discipline scientifiche, i «temi dello sguardo» sono di solito più duraturi e conservatori di quelli del «discorso»: nelle tecniche della visione, negli strumenti della rappresentazione, si depositano infatti le convenzioni più durature di un paradigma scientifico, quelle meno permeabili al cambiamento. Quando entro una comunità scientifica le parole del vocabolario tecnico cominciano a tremare, a slittare sulle cose, a fluttuare indecise o frivole tra più significati, sappiamo di assistere a un temporale; passeggero anche se ricorrente. Quando invece una turbolenza si avvicina ai nostri occhi, quando minaccia di cambiare le nostre convenzioni visive, il nostro modo di posizionarci e di guardare il mondo, allora sappiamo che sta avvicinandosi un cataclisma.
Le parole vibrano, sanno aspettare, ricollocarsi provvisoriamente; i modi di vedere sono rigidi, radicati nella soggettività, strategici; quando cambiano provocano sommovimenti radicali.
L’architettura e l’urbanistica europee sembrano oggi dentro uno di questi sommovimenti. Le tecniche di rappresentazione e gli strumenti di modificazione del territorio fisico registrano da molto tempo uno stato di instabilità cronica del loro vocabolario, che si è quasi del tutto logorato; e non è un caso che le parole che più slittano sulle cose, perché troppo vaghe o troppo ridotte, siano quelle che chiamano in causa un procedimento di lettura e misurazione visiva del territorio fisico: termini come «parti di città», «bordo», «luogo centrale», «periferia»[32].
L’instabilità non si ferma dunque alle parole; da qualche tempo sentiamo avvicinarsi il dubbio che anche le nostre tradizionali forme della visione siano logore, che i nostri occhi non siano più in grado di vedere lo spazio che ci circonda e che abitiamo. Come accade per le rivoluzioni annunciate, anche i sommovimenti che investono il paradigma visivo dell’architettura e dell’urbanistica hanno un andamento oscillatorio, girovago, e soprattutto producono delle controtendenze provvisorie, delle reazioni impetuose che in certi momenti sembrano riacquistare le energie per annichilire il mutamento.
Ma non c’è dubbio che qualcosa di irreparabile sia ormai accaduto.
1.2. Distanza e caos
I satelliti hanno intaccato una convinzione profonda nell’architettura e nell’urbanistica: quella che per capire di più del territorio bisognasse vedere di più del territorio.
Grazie alla moltiplicazione dei rilevamenti satellitari oggi vediamo grandi porzioni di spazio ridotte in piccole immagini sintetiche; e vediamo anche più tempo: immagini in «diretta», in sequenza, per fasce stagionali, notturne. Grazie alle riprese in infrarosso vediamo finalmente anche alcuni dei comportamenti vitali che la topografia non sa catturare: i flussi del traffico, le grandi concentrazioni di folla, le migrazioni stagionali. Vediamo riunite in immagini sintetiche immense porzioni del nostro territorio, ma possiamo anche esplorare – grazie alla potenza dell’ingrandimento digitale – dettagli e particolari minuti.
I nostri occhi hanno conquistato un punto di vista che l’aerofotogrammetria e la cartografia tematica non erano mai state capaci di offrire loro, se non in modo posticcio, tramite procedure di montaggio.
E così, finalmente, siamo riusciti a vedere, congelata in una rappresentazione istantanea, la condizione delle metropoli europee. Che improvvisamente ci è sembrata irriconoscibile: molte delle grandi aree urbanizzate europee (la grande città diffusa di Milano e del Nord-est italiano, la conurbazione Amsterdam-L’Aja-Rotterdam, le regioni urbane di Zurigo e Basilea, le città-territorio di Madrid e Atene, la megalopoli parigina...) ci sono apparse come delle figure amorfe e bizzarre, prive di chiari confini con il loro esterno, senza più un centro evidente e una distinzione netta tra le loro parti. Non più le grandi aree urbane dotate di un profilo netto che avevamo imparato a distinguere nei testi di geografia, ma piuttosto delle entità indefinite e smarginate, disperse sul territorio.
D’improvviso, di fronte all’immagine trasfigurata delle città che abitiamo, la conquista tecnica si è trasformata in un trauma epistemologico.
Vedendo svanire quelli che un tempo erano i bordi dei quartieri periferici, spappolati entro un pulviscolo di oggetti edilizi che si diffonde in quella che una volta era la campagna; guardando i centri urbani di corona annegati in nebulose smarginate; osservando lo spazio aperto che un tempo li separava dall’area centrale delle metropoli spezzettarsi in mille piccole radure circondate dalla crescita di una rete irregolare di nastri edilizi, abbiamo di colpo capito che le immagini con le quali continuavamo a rappresentare la geografia del nostro territorio erano diventate inutili, al pari delle parole binarie e rigide che le nominavano (centro/periferia, città/campagna, interno/esterno, spazio pubblico/spazio privato...).
La democratizzazione di una potente tecnologia per l’osservazione del territorio ha avuto l’effetto paradossale di diffondere un senso di impotenza nelle discipline che studiano lo spazio abitato; al punto che per spiegare i fenomeni urbani contemporanei i ricercatori più attenti hanno spesso dovuto chiamare in causa la natura «caotica» del territorio e l’impossibilità di costruirne delle rappresentazioni aggregate. La retorica del caos è in realtà proprio un prodotto della potente innovazione che ha investito le tecniche della visione; un’innovazione che ci ha messo di fronte a immagini stupefacenti e insieme inquietanti, perché indecifrabili con i concetti della nostra enciclopedia e le parole del nostro vocabolario. «Metapoli», «nebulosa urbana», «città diffusa», «città della dispersione», «habitat a bassa densità» sono alcuni dei neologismi con i quali abbiamo a fatica provato a nominare l’entità caotica che finalmente riuscivamo a vedere; a vedere, ma non a spiegare.
Così, i satelliti hanno realizzato e insieme ridicolizzato il sogno di una visione globale: li abbiamo mandati lassù a vedere qualcosa che di colpo ci è apparso indecifrabile. Forse perché il codice inscritto nel punto di osservazione che abbiamo comandato loro di assumere non ha niente a che vedere con la natura effettiva delle cose che finalmente vediamo.
1.3. Tracotanza zenitale
Eppure sarebbe bastato percorrere una qualsiasi delle grandi strade che escono o entrano nelle nostre città per accorgersi che il territorio europeo negli ultimi vent’anni era radicalmente cambiato: in quantità e soprattutto in qualità.
Avremmo capito che a trasformare i nostri territori non sono stati nuovi quartieri, grandi palazzi, infrastrutture (strade, viadotti, binari, gallerie), bensì una moltitudine di edifici solitari e ammassati: villette, capannoni, centri commerciali, palazzine, box, officine[33]. Una ridotta gamma di manufatti addossati l’uno all’altro in modo incongruo. Costruzioni modeste eppure preoccupate di distinguersi da ciò che le circonda; gruppi sparsi ed eterogenei di edifici, espressione di piccoli frammenti della nostra società (la famiglia, la piccola impresa, l’azienda, il negozio, il club) volutamente isolati dallo spazio pubblico e indifferenti alle sue regole.
Avremmo capito che in pochi anni, nell’indifferenza della politica e dell’architettura colta, un pulviscolo di oggetti isolati ha letteralmente scompaginato il nostro territorio, spargendosi lungo le strade e i bordi della città compatta, unendo centri urbani distanti, arrampicandosi lungo i declivi e arrivando a lambire il mare e i fiumi.
Il ritardo con il quale l’urbanistica e l’architettura europea hanno registrato il caos estetico prodotto da questa impetuosa ondata di sussulti individuali e non sincronizzati ha spinto molti studiosi e ricercatori a descrivere le unità minime, le origini, l’evoluzione, le regolarità nascoste di questa nuova città fatta da una moltitudine di oggetti solitari.
Ma questo affanno descrittivo (che in molti casi ha prodotto solo dei mesti campionari del kitsch urbano contemporaneo) è spesso rimasto prigioniero di un antico ordine del discorso: quello della morfologia zenitale, che attribuisce senso solo alle figure che sanno esprimersi con una forma compiuta ed entro una superficie visibile e bidimensionale; e che auspica una forte «distanziazione» tra l’osservatore e il territorio, come se questa «presa di distanza» fosse una condizione necessaria per la conoscenza dei fenomeni territoriali, riducendo così la dimensione soggettiva dell’osservatore a un’entità impersonale e comunque esterna al suo campo di osservazione.
Il fatto è che il codice della visione zenitale, che ha costruito il vocabolario dell’urbanistica moderna, è un paradigma resistente e prepotente, che tende ad annullare gli altri e che interpreta come caos l’irriducibilità dei codici locali.
Ma c’è di più: quello zenitale è anche un paradigma ingannevole perché induce l’osservatore a «prendere distanza» dal territorio e a illudersi di disporre della stessa angolatura impersonale e potente delle tecniche di rappresentazione che utilizza. E ipocrita, perché rifugge dalle sue responsabilità; ci mostra da lontano la superficie del territorio, eppure di continuo ci dice che le leggi e le regole dei fenomeni che vi appaiono stanno altrove, dietro o «sotto» lo spazio visibile: nell’economia, nella società, nelle strutture soggiacenti e profonde[34].
Eppure, non è certo accostando alla rappresentazione zenitale della nuova «città diffusa» alcune descrizioni aggregate della società, delle relazioni economiche e istituzionali del territorio che riusciremo a uscire dalla retorica del caos. Montando le une sulle altre delle rappresentazioni aggregate del territorio, come se quest’ultimo fosse una stratificazione di livelli piatti e specializzati, non arriveremo mai a cogliere l’essenza dello spazio abitato contemporaneo: le energie verticali e mobili e i paesaggi fisici e psicologici che in esso affondano le loro radici. Potremo sovrapporre delle «mappe» tematiche zeppe di inutili e ordinatissime informazioni, ma incapaci di afferrare la natura pluridimensionale e dinamica dei fenomeni urbani.
Cercando affannosamente strutture invisibili e soggiacenti, capaci di ordinare i fenomeni visibili sulla superficie del territorio, avremo infatti trascurato di riflettere sul fatto che il territorio contemporaneo è plasmato da tensioni che stanno tra lo spazio e la società e non si danno alcuna pena di esprimersi entro il codice della morfologia zenitale; e da configurazioni che spesso sono proprio quello che appaiono e non pretendono di essere null’altro che quello che appaiono.
Insomma, per spiegare il caos, un paradigma potente nei mezzi visivi, ma povero nei codici di interpretazione, non può bastare. Perché non possiamo chiedergli di risolvere il problema che lui stesso ha creato.
1.4. Il pensiero laterale
Per nostra fortuna, un atteggiamento minoritario e scettico si sta muovendo da qualche anno a ridosso della grande potenza visiva del paradigma strutturalista e «zenitale». Convinto che la città non sia solo una stratificazione di «livelli di realtà», ma anche un modo collettivo di pensare lo spazio; persuaso che ogni stadio di evoluzione della città implichi e richieda anche un «salto» nelle forme della sua rappresentazione, questo atteggiamento minoritario cerca di intromettersi con piccole azioni di sabotaggio tra le file del paradigma che combatte. Stando sulle spalle di un gigante, gli tira di continuo sassolini nell’occhio.
In alcune parti d’Europa questo atteggiamento sta producendo degli «atlanti eclettici»[35], che propongono nuovi modi di scrutare le corrispondenze tra ...
Indice dei contenuti
- — dedica
- Prefazione
- I. Stati di case
- II. Parole che slittano
- III. Uno sguardo diverso
- IV. Territori in transizione
- V. Argomenti per fare città
- Bibliografia essenziale
- Fonti
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a L'Anticittà di Stefano Boeri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architettura e Architettura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.