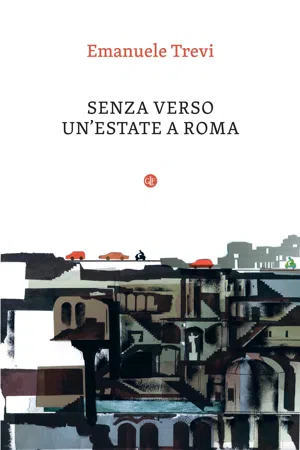
- 132 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Roma, vista dal basso, luglio-agosto
«Quella di cui godevo in quei giorni afosi, camminando sui larghi marciapiedi di viale Manzoni e di via Merulana al riparo del fogliame dei platani, era indubbiamente una felicità partorita da un'illusione: l'illusione di un piccolo numero di strade e incroci capace di suggerirmi la sensazione, razionalmente insana, che esistesse per me, come per chiunque altro, un luogo capace di farmi sentire a casa, qualunque disastro fosse in corso o mi pendesse sulla testa...»
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Senza verso di Emanuele Trevi in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Editore
Editori LaterzaAnno
2021Print ISBN
9788858146538eBook ISBN
9788858146552Senza verso.
Un’estate a Roma
Di scale che portano in basso – strette e larghe, famose e sconosciute, puzzolenti di muffa o di fogna, illuminate o buie, pubbliche o private, molto vecchie o molto nuove – in città ce ne sono così tante che nessuno ha mai nemmeno tentato di contarle. Come bocche di una sterminata, oscura, subdolamente tiepida balena: e per ognuno di noi, c’è sicuramente anche un Geppetto, lì in fondo alla sua scala, che aspetta il bambino perduto, mentre l’ultimo moccolo di candela si spegne, inesorabilmente – o se è per questo, è già spento da secoli. Pretesti apparenti per una scala, capaci di nascondere il puro, lineare, disinteressato, compulsivo amore per il basso, il cunicolo, la viscera, ammantandolo di qualche finalità pratica, di qualche ragion d’essere, come si dice, se ne trovano sempre. In fondo alle scale ci sono cripte, catacombe, corridoi, grotte naturali e artificiali, sistemi di fognatura, cisterne, ossari, necropoli, templi pagani e chiese cristiane, parcheggi, letti di fiumi carsici, linee della metropolitana, prigioni, passaggi segreti. Altre cose che, al momento di farne l’elenco, fatalmente sfuggono alla memoria – e saranno anche, ovviamente, le più importanti...
(Il fatto, incontestabile, che queste scale servano in genere anche a risalire in superficie, sembra puramente accidentale, una funzione del tutto secondaria, una qualità parassitaria, un corollario).
Varrebbe la pena di parlarne almeno per un po’, tirando fuori esempi opportuni e sagge considerazioni, di queste ambigue e forse in buona parte immaginarie virtù curative, e particolarmente ansiolitiche, dello scendere in basso, dell’inoltrarsi sotto il manto, giù nell’ombra umida della pietra, nell’informe. Di sicuro, c’è conforto nell’informe. Ma è un conforto difficile anche solo da pensare. Pensata, l’informità aggredisce il pensiero, aggroviglia ulteriormente la matassa, già di per sé abbastanza ingovernabile, della lingua. Semmai, tutti conoscono il prepotente movimento in direzione contraria, la fobia dei luoghi chiusi e sotterranei, e il senso di soffocamento mortale che ne deriva: fino al momento della risalita, se e quando la risalita è ancora possibile. Ma è la storia di ogni paura: che è sempre un bozzolo, la scorza di qualcosa d’altro. Al centro della paura, dunque, come l’occhio del ciclone o il calice del fiore, è fin troppo facile intuire un benessere, una forma efficace di felicità. Custodita, difesa, nutrita dalla paura che la circonda e la avvolge.
Così almeno ragionavo tra me e me, se questo si può definire “ragionare” quando, all’inizio dell’estate del 2003, memorabile per il clima asfissiante, il peggior clima dal 1765, diceva il «Messaggero», quotidiano romano degnissimo di fede in questi paragoni storici, sempre più spesso uscivo da casa, una casa minuscola e orribile, oltre che progressivamente, inesorabilmente lurida, dalle parti del Colosseo, e camminando per poche decine di metri entravo a San Clemente passando dalla porta laterale. Il 1765 e il 2003 rimbalzavano da un angolo all’altro della mente, mentre la mia pelle avvolta in una pellicola uniforme di sudore accoglieva con un brivido di piacere il fresco della chiesa. Anche nel 1765, qualche passante sarà sicuramente entrato qui per scampare alla vampa della canicola che infuocava il tracciato di via Labicana: sempre lo stesso, perché la forma e la direzione delle strade non hanno mai bisogno di cambiare, affiancato dai muri delle vigne e da qualche sparsa cascina. Pur rimanendo dentro il tracciato delle mura antiche, questa zona di Roma era decisamente un pezzo di campagna, come si può vedere in tutte le vecchie mappe, poco raccomandabile soprattutto d’estate, a causa delle zanzare. Daisy Miller, una delle più famose eroine di Henry James, muore di malaria perché, assieme a un suo cinico e spregevole corteggiatore romano, passa una sola sera ad ammirare il chiaro di luna all’interno del Colosseo. Lei è americana, ricca e di buon carattere, cresciuta nel solito clima salubre e spensierato, in un posto tipo il Maryland, e in pochi giorni la sua vita si consuma, percossa senza scampo da un chiaro di luna.
Attraversando in diagonale l’antico pavimento della chiesa non degnavo di uno sguardo né il mosaico dell’abside, con l’albero della vita e i cervi che si abbeverano ai piedi del crocifisso, né gli affreschi con le storie di santa Caterina d’Alessandria, salvata dall’angelo la prima volta che era finita nei guai, e decapitata la seconda, perché mai nulla, nel bene e nel male, si ripete identico. Non ero lì, io, per rinfrancare o corroborare il mio rudimentale senso estetico. Né le esecuzioni capitali né gli alberi della vita mi hanno mai troppo commosso. Io cercavo direttamente la salvezza, una salvezza abbastanza facile, tutto sommato, da raggiungere: il rifugio di un particolare rumore – un rumore per il quale, sembra strano anche a me, avevo sviluppato una specie di dipendenza psicologica. Devo anche aggiungere che la dipendenza, psicologica o meno, è qualcosa che, in generale, mi viene facile, diciamo una mia vecchia specialità. Aperta la porta a vetri della sagrestia, percorrevo la stanza, dominata da un gigantesco contenitore in legno per cartoline, un oggetto di per sé normale reso grottesco dalla sua mole, fino al bancone in fondo, anche questo di legno scuro, dove trovavo sempre due donne giovani, dall’aspetto allegro e cordiale, in strano contrasto con la loro funzione di addette alla biglietteria, e, per così dire, di guardiane dei sotterranei. Non ero mai sicuro, dirigendomi verso il bancone e tirando fuori i soldi per il biglietto, che le due donne in effetti fossero sempre le stesse. Poteva anche darsi che una fosse la stessa dell’altra volta, e un’altra no: non riuscivo mai a memorizzarle, conservandone una pur vaga immagine che mi permettesse di riconoscerle al momento di entrare nella sagrestia. Per quanto ne sapevo io, i turni di permanenza di queste donne, due o trenta che fossero, dietro il bancone potevano essere conformi a qualche segreta dottrina, calendario astrale, linguaggio cifrato che non ero in grado di intendere. In qualche modo, queste donne gentili, e dotate di grandi seni, questo lo ricordo perfettamente, seni così grandi da suggerire immediatamente un’idea di maternità, partecipavano dell’informe sotterraneo, ormai letteralmente a portata di mano, oltre una seconda porta a vetri che conduceva all’inizio di una scala. L’obolo per scendere giù, tre euro, non era affatto simbolico, bisogna dire: però, a ben pensarci, con un solo biglietto si aveva il diritto di imboccare ben due scale verso il basso – la prima dal livello della sagrestia alla basilica sotterranea, sopra la quale, una volta interrata, nell’undicesimo secolo si cominciò a costruire la chiesa attuale; e la seconda, molto più antica, dalla chiesa sotterranea fino ai locali del tempio di Mitra, il misterioso dio venuto dalla Persia, il cui culto era molto diffuso tra gli ufficiali e le truppe dell’esercito romano. Non sfruttavo il mio biglietto, in pratica, che per esercitare il diritto, implicito, di scendere giù: al primo, e poi al secondo livello. Ogni tanto, durante il percorso, già invaso dal benessere dei sotterranei, mi fermavo a osservare qualche particolare degli affreschi sbiaditi di stile bizantino, frammenti di pittura che emergono di tanto in tanto dalle pareti spoglie della vecchia basilica interrata: Cristo che scende nel Limbo a liberare le anime dei Giusti, o la storia di sant’Alessio vissuto diciassette anni in povertà, non riconosciuto da nessuno della famiglia, nel sottoscala della casa di suo padre, che lo aveva ospitato per carità credendolo un mendicante sconosciuto. Tanto era derelitta la vita di questo santo a casa sua in incognito, che a volte i servi gli buttavano in testa, dall’alto delle scale, la sciacquatura dei piatti. Tra questi affreschi, ce n’è uno in cui san Clemente gioca un brutto tiro ai suoi persecutori, che pensano di averlo catturato con corde e pali e invece, vittime di un’illusione, trascinano al posto del santo un pesante pezzo di colonna. Questa condizione di affatturati, di persone che insomma scambiano un pezzo di marmo per un uomo in carne e ossa, coinvolge sia il nobile Sisinnio, il nemico di Clemente, sia i suoi due servitori, incaricati di disfarsi del santo, o meglio di ciò che loro ritengono essere il santo. In maniera nemmeno tanto sottile, la scenetta comica nasconde un nucleo, un sentimento tragico: suggerisce, attraverso gli effetti grotteschi dell’incantesimo, la dolorosa verità secondo cui tutta la vita dei peccatori e dunque in qualche modo tutta la vita senza ulteriori specificazioni, è un’illusione, un prendere fischi per fiaschi, un inutile e stolido affannarsi intorno a pesi morti ed eccessivamente ingombranti. Ma non sta nella sua opinabile, ma tutto sommato convincente, verità morale l’interesse di questo affresco così sbiadito che di solito, al suo posto, se ne riproduce una copia dell’Ottocento, fatta ai tempi dei primi scavi. La relativa celebrità dell’affresco, anzi di questa particolare scena dell’affresco, è dovuta alle parole, ordini e imprecazioni, che Sisinnio rivolge alla coppia dei suoi servi, di nome Gosmar e Albertel, parole che appaiono sospese nell’aria, in bizzarre linee di lettere maiuscole perpendicolari che ricordano le parole crociate. Questi fumetti di Sisinnio rappresentano una forma antichissima di dialetto italiano, tra le più antiche che esistano e forse la più antica che, oltre a documentare qualcosa, come scambi e possessi di terre e di case, abbia anche intenzioni di espressività e rappresentazione umana, sia insomma collegabile al concetto di “letteratura”. E questa letteratura, nella quale ancora il latino e il dialetto convivono, come in una generazione lunga e incerta, un andirivieni più che una genealogia, questa lingua bastarda e contaminata di emozioni e paure esplode con un insulto: fili dele pute, dice Sisinnio ai suoi servi, tirate figli di puttana; è una maniera normale di rivolgersi a dei servi da parte di un padrone antico, e se è per questo anche moderno, e non esprime particolare crudeltà d’animo; quei due, Gosmar e Albertel, immortalati dalla pittura, con la loro aria da Stanlio e Ollio, o meglio da Franco e Ciccio, hanno tutta l’aria dei figli di puttana, dei fili dele pute. E non se la prenderanno certo, da qui all’eternità, se il padrone gli ricorda quello che, a tutti gli effetti, sono. Lo stesso si può dire di un terzo servo che si affanna dall’altra parte della colonna, un tipo chiamato Carvoncelle, e come altro si potrebbe chiamare, al quale si rivolge (a giudicare dalla posizione) Albertel, incitandolo a fare leva da dietro con un palo. Ovviamente non vengono a capo del sortilegio e così il pittore li ha consegnati all’eternità, inchiodandoli al loro fallimento, che io, come ho già detto, in quei giorni dell’estate del 2003, ero molto incline a interpretare come un simbolo, una trasparente rappresentazione dell’umano fallimento di ogni progetto, aspettativa, filosofia, impresa umana. Perché tutto quello che riesce a suscitare il nostro interesse addormentato, nel momento stesso in cui ci risveglia e scuote la nostra attenzione, non sta facendo in realtà che rimandarci un’immagine, eloquente e deformata, di noi stessi. Noi non riusciamo mai a pensare veramente qualcosa d’altro da noi stessi, io credo. Clemente, il vincitore, osserva quella scena di demenza, quei tre uomini affaccendati intorno a una pietra scambiata per un uomo, e ha tutta l’aria di godersela; il suo fumetto è in latino in caratteri maiuscoli, è una sentenza irrevocabile, senza distinzione tra padrone e servi sciocchi – per la durezza del vostro cuore vi siete meritati di trascinare i sassi
Ma se è vero che ogni incantesimo del tipo di quello escogitato da Clemente per sbarazzarsi dei suoi nemici, ogni sbandamento della percezione, ogni scambio erroneo dell’animato e dell’inanimato dovrebbe rappresentare una storia sommamente interessante e commovente per tutti noi, poveri servi sciocchi e vaneggianti, patetici Gosmari e Albertelli e Carvoncelli agli ordini di padroni non meno vaneggianti, raramente ho perso molto tempo davanti all’affresco. Già gratificato dal clima insano, da cantina abbandonata, della basilica sotterranea, ero impaziente di affrontare la seconda scala. Giù nel Mitreo, sede di antichi e in buona parte incomprensibili riti misterici, i benefici della discesa si manifestavano in maniera molto più radicale. Il flusso dei turisti, in quelle giornate asfissianti, seguiva ritmi del tutto imponderabili. A volte i locali sotterranei erano deserti, tanto da permettermi di ascoltare l’eco dei miei passi, un’eco molto particolare e non gradevolissima, simile a un fruscio come di ali di pipistrello; a volte invece gruppi di spagnoli, francesi, americani, giapponesi, tutti di aspetto mite e sudato, uniformemente bovino, irrompevano sulle scale al seguito di una guida, spesso armata di una bandierina. Queste guide, uomini e donne, avevano tutta l’aria di quelle divinità che nelle religioni antiche si incaricano di condurre le anime dei morti, una per una o a gruppi, verso gli spazi opachi e indistinti, pieni di rimpianto per la vita e la luce del sole, dell’aldilà. Per me, comunque, la presenza o l’assenza di altre persone non cambiava nulla. Il rumore di cui andavo in cerca era sottile e tortuoso, e si lasciava cogliere solo al termine di un atto di reale concentrazione. Non c’era silenzio e non c’era chiasso in grado di esaltarlo o di nasconderlo. Si trattava di percorrere un ultimo cunicolo dei locali consacrati al culto di Mitra, relativamente stretto, chiuso in fondo da una grata di ferro. Quell’angolo di sotterraneo non interessava nessun visitatore, la grata era fissata da un pesante lucchetto, oltre non si vedeva nulla. Poggiavo la fronte alle sbarre, fredde come durante una notte d’inverno, e fissavo lo sguardo in quell’oscurità proibita. Il rumore più evidente, quello immediatamente percepibile, era regolare, ronzante, artificiale. Un’autoclave, o un generatore elettrico. Ma anche quel rumore, invece di essere l’ultima tappa, il...
Indice dei contenuti
- Senza verso. Un’estate a Roma
- Materiali
- Ringraziamenti
- «Colpi d’occhio»