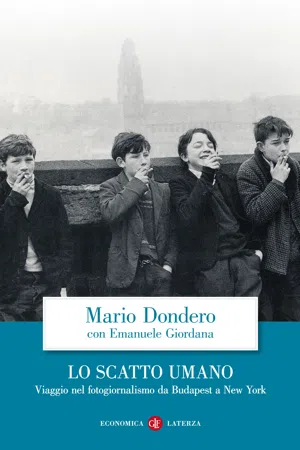1. Budapest
La madre del fotogiornalismo
«Se dovessi raccontare la storia del fotogiornalismo pensando alle città dove è nato, mi verrebbe in mente Budapest, che fu il punto di partenza di grandi fotoreporter come Robert Capa – che in realtà si chiamava Endre Ernő Friedmann – o “André” Kertész, ma anche di creatori del giornalismo fotografico, artefici delle prime agenzie di distribuzione di immagini, mediatori per eccellenza tra il mondo dei fotografi e il pianeta dell’editoria».
C’è un tempo avverso sulle colline di Fermo, la città marchigiana dove Mario vive da più di quindici anni. C’è una nebbia autunnale che fatica a disperdersi così che, forse, è più facile immaginarsi la bruma che si leva dal Danubio, mentre attraversa Budapest.
«I nomi sono tanti anche se, a cercare nelle enciclopedie, trovi scritto che Capa e Kertész erano americani perché poi lavorarono molto negli Stati Uniti e lì si naturalizzarono. Kertész morì in quel Paese». In Ungheria, evidentemente, c’era un’atmosfera propizia a quella che è poi stata una grande stagione creativa nel campo del fotogiornalismo: forse c’è una venatura tzigana in tutto questo, uno spirito vagabondo, zingaresco, nomade, tipico del fotoreporter.
«Certo l’Ungheria aveva i suoi limiti, soprattutto politici: tra gli anni Venti e il ’44, il reggente del Regno d’Ungheria era l’ammiraglio Miklós Horthy, che come modello aveva Mussolini. I nazisti alla fine gli preferirono un uomo ancora più duro e relegarono Horthy a Cascais, in Portogallo. Ma a parte la repressione del regime, c’era anche un problema di diffusione, dato che era un Paese che stampava solo in ungherese e aveva quindi un pubblico molto limitato. Questi due fenomeni sono probabilmente all’origine della grande migrazione dei fotografi, o di coloro che aspiravano a praticare un giornalismo libero e creativo fuori dai confini troppo stretti del loro Paese».
I nomi importanti in effetti sono tanti: Kertész, Gyula Halász, conosciuto con lo pseudonimo di Brassaï, László Moholy-Nagy, Martin Munkácsi, che poi si sarebbe distinto nella foto di moda, Simon Guttmann e Bert Garai tra coloro che crearono le prime agenzie fotografiche. E naturalmente Robert Capa.
Non erano dunque solo fotografi o non erano solo fotoreporter: Moholy-Nagy era un fotografo sperimentale e anche un pittore. Bert Garai non era fotografo anche se fu il fondatore – addirittura agli inizi del Novecento – di un’agenzia importante, la «Keystone Press Agency» di Londra, che aveva anche un ufficio a Montreal. Era un ebreo ungherese che poi si trasferì nel Regno Unito dove scrisse anche un libro: The Man from Keystone (1965). La lista è infinita: «László Elkán, ad esempio, che nella resistenza francese aveva preso il nome di Lucien Hervé, era famoso per le sue foto di architettura e fotografo di fiducia di Le Corbusier. O ancora Paul Almásy, un altro ungherese trasferitosi in Francia, uomo estremamente raffinato», come ricorda Dondero che andò a trovarlo nella sua casa sulle rive della Marna.
«Molti protagonisti degli albori del fotogiornalismo se non erano nati in Ungheria, l’Ungheria l’avevano nel sangue, nell’albero genealogico, nelle radici, o comunque appartenevano a quel mondo mitteleuropeo che aveva prodotto intellettuali colti e raffinati. Simon Guttmann, ad esempio, era nato a Vienna ma era ungherese. E sarà proprio lui a creare la grande “Dephot”, la mitica agenzia berlinese che è forse la grande madre di tutte le agenzie fotografiche. Quella tradizione non si è spenta: penso, per venire all’oggi, a figure come Zoltan Nagy, fotografo ungherese di grande abilità tecnica che vive in Italia».
Gli esordi del fotogiornalismo hanno un ungherese ovunque: è ungherese anche Stefan Lorant, fotografo, regista e fondatore del «Picture Post», il maggior magazine britannico di fotogiornalismo. Lorant a Londra ci va dalla Germania, dove la sua opposizione al nazismo lo costringe all’esilio. Una strada seguita da tanti. Emigrato negli Stati Uniti nel 1940 (il Regno Unito gli ha negato la cittadinanza), Lorant sarà – secondo alcuni – tra i grandi ispiratori del nuovo «Life magazine», la più nota rivista di fotogiornalismo a livello internazionale.
Chi è il fotogiornalista
«Il fotogiornalismo nasce in un ambiente intellettuale dove si intersecano professioni, abilità, curiosità, culture, competenze e non solo mere abilità tecniche. Credo che un bravo fotografo debba avere sempre curiosità intellettuale anche se poi difficilmente, in Italia, questa qualità gli viene riconosciuta. A un fotografo chiedono, in questo Paese, di essere un tecnico: come un bravo idraulico, un buon elettricista. Prima di diventare un fotoreporter, quand’ero cronista di nera e andavo in commissariato col fotografo che mi accompagnava, il mio collega con la macchina fotografica lo facevano accomodare fuori dalla stanza del funzionario. La persona importante era il giornalista, non certo quello che scattava. Direi che in Italia c’è stata della fotografia un’idea “servile”: vieni qua a fotografare l’onorevole, l’impresario, l’attore. Poco rispetto insomma. Poco rispetto innanzi tutto per la persona e poco rispetto per la professione. Quella del fotogiornalista ha invece un peso spesso determinante: racconta i fatti con una sequenza di immagini il più possibile vicine alla realtà, senza mistificazioni, senza costruzioni».
Difficile pensare che a Mario Dondero sarebbe piaciuto il modo di lavorare di Gjon Mili che – racconta il photoeditor di «Life» John Morris nel suo Get the Picture (2002) – obbligò la tennista Alice Marble, trionfatrice a Wimbledon, a simulare il palleggio di una partita di tennis: «Tutto quello che deve fare è colpire la palla... faccia finta che io sia il suo avversario», dice Mili alla campionessa fornendole palla e racchetta in uno studio trasformato per l’occasione in campo da tennis al secondo piano della 23ma strada Est a New York.
«Solo una volta – racconta Dondero – ho costruito una foto. Dovevo fare un ritratto di Sinjavskij, scrittore sopravvissuto al gulag, e andai con Gianni Corbi (allora redattore capo dell’“Espresso” e grande specialista di questioni sovietiche) a casa sua dove lo raggiunsi in giardino. Sinjavskij era terribilmente trasandato e con pantofolacce ai piedi... mi vergognavo per lui. Prima di scattare diedi un calcio a una cassetta lì vicino che andò a coprirgli le estremità e le pantofole... E feci clic».
Il fotogiornalista ideale? «Credo che debba essere una persona poliedrica, flessibile, capace di più cose. È il caso di Claude Dityvon che è anche un valente cineasta o, all’inverso, di Stanley Kubrick che iniziò da fotografo come un altro cineasta, nostro compatriota, Alberto Lattuada. Voglio dire che si dovrebbe contrastare l’iper-specializzazione tipica della cultura americana. Lo penso da sempre, e non per esigenze di mercato che oggi ti obbligano a svolgere più mansioni. I ruoli peraltro vanno rispettati e, sotto questo aspetto, il sindacalismo è un elemento essenziale proprio per la loro difesa».
C’è, nei racconti di Mario Dondero, più di un tipo di fotogiornalista. Ad esempio i fotografi dandy di «Paris Match» con cui, negli anni Cinquanta, Mario condivide a Parigi molte esperienze.
«Facevamo cose diversissime. Loro si occupavano di starlettes, famiglie reali, matrimoni importanti. Avevano sempre impermeabili inglesi e auto sportive a due posti come la MG su cui sedevano con bellissime ragazze. Ma erano generosi – avevano senza dubbio più soldi di me – e di un’abilità tecnica incredibile: non usavano mai il flash, per dirne una, che era allora un’ossessione degli editori italiani. Così che, pur essendo su due frontiere diverse, loro a fare reportage leggeri, io a cercare di documentare e capire la società dove vivevo, era possibile trovare un terreno comune».
Un discorso che ci porterebbe a parlare dei paparazzi italiani, tema che ritorna spesso nel fotogiornalismo nazionale. Per Mario Dondero, comunque, il fotogiornalista per eccellenza è «Robert Capa, ma anche la sua compagna Gerda Taro», morta durante la guerra di Spagna.
«Il fotoreporter è un individualista che però spera sempre di integrarsi in un lavoro collettivo. La sua professione e le sue scelte sono il frutto di una decisione individuale, la genialità di un singolo che non sta seguendo la pianificazione di un gruppo editoriale, anche se poi deve farci i conti; con questo non voglio certo dire che non possa nascere una grande empatia umana e professionale col giornalista con cui si sta lavorando. Questa individualità, comunque, è un segno del fotoreporter e ha molte forme, la prima delle quali è quella del freelance, contrapposta a coloro che noi chiamavamo gli impiegati della fotografia. Quelli cioè che avevano un posto fisso nei giornali, condizione oggi sempre più rara.
Naturalmente ci sono fotografi e fotografi, fotoreporter e fotoreporter ed è inevitabile avere più o meno simpatia per questo o per quello. Io non nascondo la mia per il fotoreporter engagé, impegnato, concerned, come dicono gli anglosassoni, con una forte passione civile e politica – diremmo noi – nel senso alto del termine. Questo però non vuol dire che non ci siano anche grandi fotografi nel cui lavoro l’impegno civile conta poco e che scelgono di rappresentare i costumi della borghesia elegante, anziché le miserie della condizione umana. Penso a Izis, al secolo Israëlis Bidermanas, da molti ritenuto uno dei grandi maestri della fotografia del XX secolo. Sicuramente lo era nell’attenzione formale ed era molto vicino, per il suo spirito poetico, a Ronis e Doisneau. Ma penso anche a Jacques Henri Lartigue». Scrive di lui il Dizionario Larousse della Fotografia: «La carriera di Lartigue non corrisponde ad alcun criterio riconosciuto tipico del fotografo [...]. È prima di tutto un amatore che non si preoccupa di obbedire a regole o di fare delle sue fotografie un prodotto editoriale».
Il ruolo delle agenzie
È forse proprio il carattere individualista del fotografo a favorire la nascita delle agenzie fotografiche, le intermediarie tra il fotoreporter e i quotidiani, i settimanali, i magazine. Quelle redazioni diventano però anche i luoghi dell’elaborazione di idee e di storie da realizzare. «Cenacoli dove si cementano amicizie e si stimola la fantasia. Dove si ragiona».
Anche qui torna lo zampino degli ungheresi. Abbiamo già citato la «Keystone» fondata a Londra da Bert Garai. A Parigi, nel 1933, un altro ungherese, Charles Rado, fonda «Rapho», una delle più antiche agenzie di fotogiornalismo francese. L’impresa ha alti e bassi, ma nel 1946 è rilanciata da Raymond Grosset, che riunisce un gruppo di giovani fotografi, tra cui Robert Doisneau, Jean Dieuzaide, René Maltête (che si dilettava anche di poesia), Janine Niépce (parente alla lontana del pioniere della fotografia Joseph Nicéphore Niépce), Sabine Weiss (svizzera) e Willy Ronis.
È un gruppo che diventerà noto per il suo impegno civile in quella che l’accademia chiama la photographie humaniste, corrente molto vicina ai suoi soggetti, di cui descrive sia il malessere e le difficoltà in una Francia uscita a pezzi dalla guerra, sia il piacere delle cose semplici della vita. Uno dei suoi manifesti, dice ancora l’accademia, può essere la famosa foto di Doisneau Le baiser dell’Hotel de Ville («Life», 1950), in cui due giovani parigini si baciano incuranti dei passanti. Qualcuno indica come fondatori del movimento lo stesso Doisneau, Ronis e Henri Cartier-Bresson. Dondero però non è molto d’accordo con queste associazioni.
«Ho conosciuto personalmente sia Doisneau sia Ronis, due persone ammirevoli, di grande bravura e di grande modestia oltre che di enorme talento. Umanisti certo, ma direi piuttosto che il loro è realismo poetico: sono due figure raffinate e attente alla gente comune il cui impegno non è strettamente politico, come quello che caratterizza, ad esempio, l’opera di Capa o Cartier-Bresson. Inoltre di Ronis e di Doisneau non si può dire esattamente che fossero fotogiornalisti, anche se Doisneau lavorò per molti giornali della sinistra francese tra cui la “Vie ouvrière”. Mi ricordo di averlo visto, ormai celeberrimo, realizzare un reportage per quella rivista, organo del sindacato Cgt, con l’umiltà del più semplice dei reporter. Lui e Ronis erano semmai fotografi capaci di rappresentare alcuni aspetti della vita e, se mi si passa il termine, di accarezzarla».
Torniamo alle agenzie. «Se devo pensare all’agenzia per eccellenza, non c’è dubbio che si tratta della “Dephot” di Simon Guttmann, nata a Berlino nel 1928. In un certo senso è la capostipite di tutte le agenzie, un po’ come Guttmann è il prototipo del creatore di fotogiornalismo».
È nei locali della «Dephot» (Deutscher Photodienst) di Guttmann che si codifica il reportage e si comincia a considerare la sequenza di immagini come lo snodo principale di un racconto. Guttmann avrà anche un periodo francese e poi londinese con la «Report», agenzia fondata a metà degli anni Trenta, che non avrà però lo stesso peso di «Dephot». Guttmann era molto più che un semplice agente, ma torneremo oltre a parlare di lui e del clima che si era creato attorno alla sua figura e ai suoi laboratori, fotografici e di idee.
Il periodo tra le due guerre, anche grazie al grande sviluppo della stampa illustrata, è l’età d’oro delle agenzie fotogiornalistiche. È a loro che il fotografo affida l’aspetto commerciale del suo lavoro, anche se ciò significa esercitare un sempre minor controllo sulla distribuzione delle proprie immagini: «è sempre un gran cruccio nel nostro lavoro», dice Dondero. Un cruccio tale che spingerà Capa e Cartier-Bresson a fondare la «Magnum Photos», la loro propria agenzia, con David Seymour, George Rodger, Rita e Bill Vandivert, Maria Eisner, una milanese di nascita che negli anni Trenta aveva fondato a Parigi l’agenzia «Alliance-Photo». La lista è lunga. Sul fronte francese bisogna ricordare almeno «Reporters associés», «Gamma», la sua costola «Sygma», «Sipa Press» che nel 2011 è stata acquistata dall’agenzia tedesca «Dapd» (Deutscher Auslands-Depeschendienst), «Viva», acquisita nel 1986 da un’altra agenzia, la «NS Rush». In Gran Bretagna si occupa di distribuzione di immagini anche l’agenzia giornalistica «Reuters». Negli Stati Uniti, che ereditano la tradizione europea offuscata dagli anni del nazismo, è una fioritura di agenzie a partire dalla fine degli anni Trenta: la «Associated Press», la «Black Star», la «Upi». Il fenomeno è anche italiano: Grazia Neri ha chiuso da pochi anni l’omonima agenzia, fondata nel 1966, alla cui storia ha dedicato il libro La mia fotografia, interessante racconto di una coraggiosa esperienza. Un’altra antica agenzia italiana è stata «Publifoto», molta strada ha fatto «Contrasto» creata da Roberto Koch. Molte hanno avuto vita breve, altre sono scomparse, altre ancora si sono trasformate, altre hanno visto diversi passaggi di mano.
«Quella delle agenzie è una galassia in grande movimento, ma adesso si sono concentrate in pochissime mani e non sono più soltanto fotografiche, sono polivalenti. Le agenzie americane, per esempio, sono sempre state fenomeni eminentemente editoriali e commerciali; in Europa, invece, le agenzie delle origini erano spesso piccoli cenacoli nati dall’amicizia e dall’impegno civile di alcuni fotografi di grande qualità. Penso a Gilles Caron, morto in Cambogia nel 1970 appena 31enne, il quale per “Gamma” aveva seguito il Vietnam, il Biafra, il maggio francese, il Ciad e, appunto, la Cambogia. Emulo di Capa, Caron è un esempio significativo di quello spirito e “Gamma” lo è stata altrettanto sul mercato mondiale, dove si distingueva per il talento, la qualità delle immagini e la sensibilità delle scelte. Era così anche “Alliance-Photo”, piccola agenzia che accolse Gisèle Freund, scappata dalla Germania perché ebrea. Ad “Alliance-Photo” era già in nuce la struttura di base della futura “Magnum”: ci collaboravano Cartier-Bresson, Capa e David Seymour, detto Chim. Allora le agenzie erano luoghi di aggregazione di fotografi che amavano soprattutto il proprio mestiere. Anche chi le gestiva aveva la stessa passione. Poi sono arrivati gli uomini d’affari e gli affari sono diventati il dato preminente. Scandalosamente preminente, direi. Non è solo un fatto commerciale in sé: c’è un aspetto che riguarda il controllo politico, il controllo del senso critico e della riflessione critica che era la forza delle prime agenzie. Uno spirito che ricordo benissimo e che permeò tutta la mia esperienza parigina nel dopoguerra».
Protagonisti del mondo delle agenzie sono ovviamente i fotografi. Eppure, a ragione, si sentono sfruttati ed è il motivo per cui nacque la «Magnum». Eccone il ricordo di Gisèle Freund nel suo Il mondo e il mio obiettivo: «Capa ebbe l’idea di creare un’agenzia gestita dagli stessi fotografi. Le agenzie servono da intermediarie tra i freelance, i fotografi indipendenti, giornali, riviste ed editori. Di norma trattengono la metà dei proventi, talvolta di più col pretesto che devono dividere gli utili con un’agenzia straniera. Capa c...