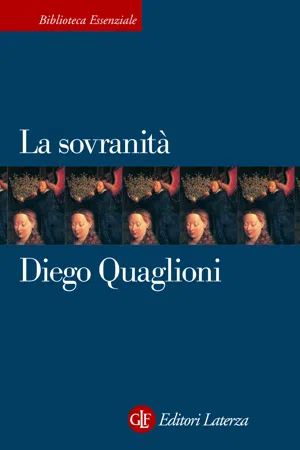
- 156 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La sovranità
Informazioni su questo libro
La crisi odierna dello Stato-nazione mette in discussione il concetto stesso di sovranità. Un invito a riflettere sulle forme del potere e sulle sue manifestazioni all'alba del terzo millennio.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
DirittoCategoria
Storia giuridicaLa sovranità “assoluta”
1. Sovranità e “assolutismo”
Al problema storico-dottrinale della sovranità, come complesso di domande relative alla natura del potere politico e dei suoi limiti, è congiunta la questione dell’“assolutismo” – nella sua dimensione medievale così come nella sua connotazione tipicamente moderna, che della prima non è che lo sviluppo e, per così dire, la “forzatura” – in un ampio tornante della storia. Perciò si è potuto scrivere, anche recentemente, che «non stupisce [...] che la cultura giuridica protomoderna abbia lungamente conservato, nelle sue grandi linee, una raffigurazione tecnica del potere elaborata dai giuristi italiani e francesi fra Due e Trecento, in un contesto ancora largamente antecedente alla nascita dello Stato», e che, osservata in una prospettiva di lungo periodo, tale raffigurazione appare «come una delle strutture profonde della cultura politica europea, destinata a venir erosa poco per volta nel corso dell’età moderna ma anche a resistere, nel suo nucleo essenziale, fino alla crisi definitiva dell’antico regime»1.
L’ambiguità del termine assolutismo è nota e si accompagna alla sua frequente equivocazione, che tende a confondere l’assolutismo con le manifestazioni tipiche delle monarchie europee di diritto divino nell’età matura dell’antico regime. Perciò la storiografia recente ha ravvisato la necessità di rapportare l’assolutismo a una forma specifica di organizzazione del potere, caratteristica rispetto ad altre e da cogliersi sul piano storico più che su quello tipologico-strutturale, con riferimento a una forma storicamente determinata di organizzazione del potere e alle espressioni di pensiero che ne accompagnarono la genesi e il compimento2. È parso dunque che in una prospettiva storica rigorosa l’assolutismo debba essere delimitato da parametri classificatori «attinenti allo spazio culturale dell’Occidente europeo, al periodo storico dell’età moderna e alla forma istituzionale dello Stato moderno»3, sia per distinguerne l’esperienza da quella del dispotismo, sia per separare la concezione e l’organizzazione “assolutistica” del potere dal precedente sistema politico dell’età intermedia e della società ordinata per ceti.
In questo senso la stessa espressione “Stato assoluto”, descrittiva di una fase della storia costituzionale europea, caratterizzata, soprattutto nel corso del Seicento, dalla tendenza alla semplificazione in senso assolutistico della forma di governo monarchica, non implica il riconoscimento della capacità dello “Stato assoluto” di superare completamente la precedente forma statuale (cioè lo “Stato di giustizia” della lunga età intermedia): non perché comune a entrambi fosse «l’assenza del principio-guida della sovranità»4, ma proprio per la reperibilità, in entrambi, di un’idea e di una pratica della sovranità che conservano la loro natura “duplice” e limitata. Appunto perciò si tratta di valutare «quanto le monarchie assolute europee si siano davvero sentite portatrici di un diritto espressione del principio di sovranità, capace in quanto tale di produrre un’integrale abrogazione [...] di quella pluralità di ordinamenti e di diritti, di luogo e di ceto, diffusi sul territorio, che lo Stato giurisdizionale razionalizzava e componeva a unità, ma non eliminava»5. Anche la definizione più astratta dell’assolutismo, come forma di governo in cui il sovrano esercita il potere senza dipendenze o controlli da parte di altre istanze, superiori o inferiori, avendo la sua radice storico-dottrinale nella solutio a legibus, pone immediatamente come decisivo il problema dei limiti del potere. Tale radice infatti «implica autonomia solo da qualsiasi limite legale esterno, tranne che dalle norme poste dalla legge di natura o dalla legge divina; oltreché, quasi sempre, dalle “leggi fondamentali” del regno: si tratta quindi, anche nelle teorizzazioni più radicali, di una assolutezza relativa alla gestione del potere, il quale invece reca dei limiti intrinseci, per eccellenza costituzionali, in rapporto alle credenze e ai valori dell’epoca»6, e distingue sostanzialmente l’assolutismo dal dispotismo e dalla tirannide, come forme politiche in cui l’autorità non ha limiti costituzionali e si esercita in modo arbitrario e oppressivo.
È proprio in tal senso che la configurazione “antidispotica” del filone originario del pensiero assolutistico risulta con chiara evidenza, solo se si rinunci a una riduzione delle maggiori espressioni dottrinali a schema onnicomprensivo e a paradigma “tipologico” dell’assolutismo politico7. La questione dei limiti del potere in relazione alla sua dimensione astrattamente “assoluta”, nei suoi termini più esatti, nasce dalla necessità di intendere come un tema così saldamente radicato nella tradizione giuspubblicistica occidentale, fino dalle sue lontane origini romanistiche, costituisca per la coscienza giuridica e politica moderna un dilemma sempre risorgente, sia quando si voglia illuminare «il modo in cui il dato etico – l’honestas che sollecita il principe a sottomettersi volontariamente alle leggi – possa rivelarsi strumento efficace a salvaguardare la legalità»8, sia quando si intenda stabilire quale ruolo un tale deposito di dottrina abbia giocato nello svolgimento di una visione propriamente moderna della sovranità e dello Stato9.
Nasce di qui l’esigenza, per le dottrine della sovranità nell’età del moderno assolutismo giuridico e politico, di sciogliere un’antitesi e un binomio ampiamente frequentati e variamente discussi nella tradizione di scuola del tardo Medioevo: antitesi tra plenitudo potestatis (“pienezza del potere”) astratta e potere concreto governato dall’equità, cioè, come si usava dire, potestas ordinaria et ordinata: la prima ispirata da istanze assolutistiche, la seconda da esigenze legalitarie; l’una posta come figura astratta, l’altra come manifestazione concreta del governo, ma entrambe coesistenti nelle mani del principe. Si tratta insomma delle due sembianze della sovranità, o della doppia natura della regalità medievale nel paradigma romanistico-canonistico, con la loro doppia vocazione: «L’ufficio eterno e astratto ha la vocazione per la pienezza dei poteri, ma il monarca in quanto essere umano rationabilis è vincolato dalle leggi etiche e dal relativo divieto di ogni arbitrio ingiustificato»10.
Non si può dunque non avvertire insoddisfazione per il modo in cui il termine assolutismo è comunemente usato, a indicare una forma di potere e un corpo di dottrine accomunati dall’idea e dalla pratica della centralizzazione del potere politico, in connessione con i processi di formazione e di piena affermazione dello Stato moderno, come mutamento radicale del rapporto fra diritto e potere, tra le forme stesse di produzione del diritto e i modi di esercizio del potere politico, nel senso della manifestazione compiuta del principio moderno della sovranità. Si è potuto affermare, ad esempio, che la codificazione – come processo culturale e storico mediante il quale si è resa possibile la sovraordinazione della politica al diritto – ha potuto realizzarsi come superamento del cosiddetto “particolarismo giuridico”, cioè della mancanza di unitarietà e di coerenza dell’insieme delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale. Da questo punto di vista la semplificazione del diritto che conduce alle codificazioni si caratterizzerebbe come un processo direttamente politico, coincidente con il «processo di concentrazione del potere dell’assolutismo monarchico, con i suoi corollari di incipiente organizzazione burocratica centrale e di incipiente produzione normativa centrale rispetto all’entità “Stato”»11. La politica accentratrice dell’assolutismo ha potuto essere pertanto considerata come un fattore di unificazione e di “razionalizzazione” del sistema giuridico, precedentemente caratterizzato dalla concorrenza di una pluralità di fonti.
I processi di semplificazione, unificazione e uniformazione del diritto si svolgono dunque, sec...
Indice dei contenuti
- La sovranità: passato e presente
- Il doppio volto della sovranità
- La sovranità “assoluta”
- La parabola della sovranità
- La sovranità nella crisi del moderno
- Bibliografia essenziale
- L’autore
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a La sovranità di Diego Quaglioni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Diritto e Storia giuridica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.