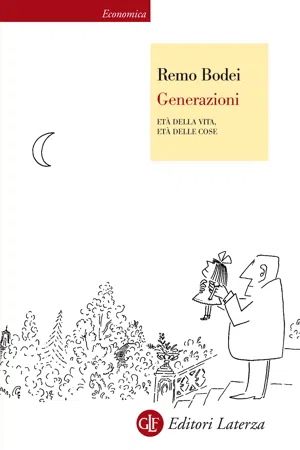II.
Generazioni
1. In termini cronologici, l’allungamento degli ‘estremi’, sia nel caso della giovinezza che in quello della vecchiaia, restringe l’area di influenza della maturità. I giovani e i vecchi, i figli e i nonni guadagnano così maggior spazio e importanza, reale e simbolica, rispetto ai padri, e più in generale, alle persone mature di ‘mezza età’.
Ma quando inizia e finisce – e in che consiste – la maturità? Un’indicazione precisa la offre dapprima la Bibbia. Recita il Salmo 89: «Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti» (per inciso, nel Salmo 127, si trova una efficace immagine della gioventù nel suo proiettarsi verso l’avvenire: «Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza»). Malgrado non fossero propriamente molti quelli che raggiungevano nei secoli e nei millenni passati l’età dei settanta anni, per non parlare degli ottanta, tale suddivisione ideale è stata resa popolare da Dante quando, all’inizio della Commedia, accenna al «mezzo del cammin di nostra vita», rappresentato dal trentacinquesimo anno, come si evince dal Convivio: «E però che lo maestro de la nostra vita Aristotile s’accorse di questo arco di che ora si dice, parve volere che la nostra vita non fosse altro che uno salire e uno scendere: però dice in quello dove tratta di Giovinezza e di Vecchiezza, che giovinezza non è altro se non accrescimento di quella. Là dove sia lo punto sommo di questo arco, per quella disuguaglianza che detta è di sopra, è forte da sapere; ma ne li più io credo tra il trentesimo e quarantesimo anno, e io credo che ne li perfettamente naturati esso ne sia nel trentacinquesimo anno». Aristotele è, tuttavia, meno preciso e lascia una banda di oscillazione di un lustro: «il corpo raggiunge la sua maturità dai trenta ai trentacinque anni, l’anima intorno ai quarantanove».
Negli Oikonomica – attribuiti da alcuni ad Aristotele, ma sicuramente della sua Scuola – il trentacinquesimo anno diventa invece un esatto spartiacque economico, per cui durante i primi trentacinque anni di vita sono i padri che devono aiutare i figli, mentre durante i secondi sono i figli che devono aiutare i padri.
Peraltro, l’età della vecchiaia era piuttosto incerta e variabile e coincideva spesso con quella segnata dall’«impossibilità per l’individuo di mantenersi con le proprie forze e di assolvere i propri compiti e servigi. Senza canoni di categorizzazione omogenei e unanimemente accettati, i vecchi vengono spesso confusi con gli inabili e gli invalidi, nell’ambito di una gamma di età dai confini estremamente frastagliati [...] Se in effetti nell’antichità il termine senex poteva essere applicato tanto a un quarantenne che a un settantenne, con gradazioni diverse a seconda dei gruppi sociali di appartenenza e delle funzioni svolte, i sessant’anni, comunemente scelti dalle statistiche e da molti studiosi contemporanei come turning point verso la vecchiaia, sono gli stessi individuati da sant’Agostino come inizio della senescenza». In assenza di un consolidato ed efficiente apparato di assicurazioni statali o private diffuse (che tuttavia esisteva e in parte funzionava), è all’interno delle famiglie che in prima istanza si regola generalmente il mantenimento delle generazioni e il loro avvicendarsi e in cui la cura dei genitori anziani era – e continua a essere – un modo per ricambiare l’assistenza e l’educazione ricevute.
Va tuttavia messa in conto la differenza tra i modelli teorici e le situazioni concrete, così come va smentita l’idea che nel passato le famiglie fossero caratterizzate dall’affetto e dalla reciprocità (basti pensare, per la Grecia antica, a Le nuvole di Aristofane o alle commedie di Menandro per i rapporti non certo idillici tra genitori e figli o a quelle di Plauto per la rivalità tra padri e figli nell’amore per un’etera) e che i vecchi venissero sempre accolti e curati benevolmente. L’assistenza degli anziani non ricadeva, inoltre, soltanto sulla famiglia, «(intesa come gruppo dei coresidenti e come rete parentale), quanto sulla collettività (rappresentata da reti di amicizia e di vicinato, istituzioni, gesti caritativi, Stato). Uno scenario che smentisce la naturalità del legame solidale tra le generazioni, evidenziandone la costruzione attraverso gli strumenti giuridici e le pratiche sociali di negoziazione tra ambito pubblico/istituzionale e privato/familiare». Nell’antica Grecia, ad esempio, esisteva l’eranos, quale volontario sistema di contributi per assicurarsi la sopravvivenza in caso di impreviste disgrazie o di mancanza di introiti. A Roma le risorse provenivano da una specie di cassa di mutuo soccorso per artigiani o operai appartenenti a corporazioni – le sodalitates o collegia opificum – e, talvolta, dalla distribuzione da parte dello Stato dei beni di chi moriva senza lasciare testamento. I «poveri onesti», gli invalidi (specie se per causa di guerra) avevano a lungo goduto di aiuti e benefici da parte delle istituzioni ecclesiastiche o politiche attraverso parrocchie, ospizi, ospedali, mense e, specie a partire dal Cinquecento, grazie alle Poor Laws di diversi paesi.
Aristotele, tuttavia, nel primo libro della Politica aveva coerentemente posto il sostentamento e la propagazione della vita fisica (della zoé) all’interno della famiglia, in una fase cioè prestatale, caratterizzata dal dominio del marito sulla moglie, dei genitori sui figli e dei padroni sugli schiavi. L’amore dei genitori per i figli piccoli (soprattutto da parte delle madri) è gratuito e intransitivo, non chiede cioè di essere ricambiato. Egli aveva, infatti, riconosciuto che – a differenza dei componenti della «massa», che per ambizione preferiscono essere amati piuttosto che amare – le madri amano i propri figli senza pretendere di essere riamate: «segno ne è il fatto che [...] provano piacere nell’amare, infatti alcune danno i loro figli ad allevare e continuano ad amarli, sapendo di loro, senza cercare di essere amate in contraccambio, se entrambe le cose non sono possibili; ma sembra che a loro basti sapere che stanno bene e li amano, anche se quelli, per ignoranza, non ricambiano affatto con l’amore che si deve a una madre». Da parte dei figli, la vera restituzione di questo amore e di questo aiuto a entrambi i genitori avviene, appunto, al culmine della vita, attorno al trentacinquesimo anno. Per quanto riguarda i reciproci doveri tra le generazioni, anche a prescindere dalla scadenza del trentacinquesimo anno, questo modello aristotelico di restituzione è durato in Europa per quasi due millenni.
In seguito, a prescindere dalle Poor Laws inglesi del Cinquecento e del Seicento o dal Wohlfahrtsstaat programmato dal Codice di leggi prussiano del 1794 (l’Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten), è stato Bismarck ad avere introdotto, tra il 1884 e il 1889, le assicurazioni di malattia e di vecchiaia. In Italia la previdenza sociale ha invece cominciato a prendere corpo, circa un decennio dopo, a partire dalla «Carta della mutualità» del 1898, e da quando Giolitti promosse prima l’istituzione, nel 1900, poi la distribuzione a prezzi controllati, del «chinino di Stato» (a seguito della scoperta di Giovan Battista Grassi che imputava alla zanzara anofele la causa della trasmissione del plasmodio, responsabile della malaria).
Tecnicamente si può parlare di welfare state solo dopo il Social Security Act, promulgato negli Stati Uniti nel 1935, o, meglio ancora, dopo l’introduzione delle politiche sociali nel Regno Unito, varate negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale e formalizzate nel Piano Beveridge che lo caratterizzava come State of Justice, che avrebbe dovuto assicurare la «libertà dal bisogno» a tutti i cittadini. Sebbene per alcuni studiosi il welfare state manchi di consistenza concettuale e si riduca a un processo storico di changing balance of public and private power, una buona definizione è comunque questa: «Con l’espressione ‘Stato sociale’ s’intende l’insieme delle iniziative assunte dai vari paesi nell’ambito dell’assistenza, della previdenza, della sanità, della regolamentazione del lavoro e, più in generale, per la tutela dei ceti più deboli. Frutto della rivoluzione industriale e della necessità di offrire qualche risposta ai gravi problemi sollevati dalla nascita dell’economia di mercato, lo Stato sociale – e, prima di esso, le politiche di lotta alla povertà e all’emarginazione – ha assunto valenza e connotazioni differenti a seconda dei periodi...