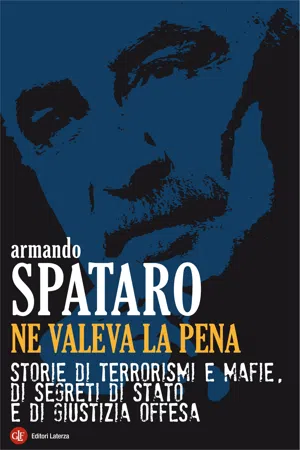Il sequestro di Abu Omar/1: dal 17 febbraio 2003 all’incriminazione della Cia
Hassan Mustafa Osama Nasr, detto Abu Omar al Masri («Abu Omar» significa «Padre di Omar») è nato nel 1963 ad Alessandria d’Egitto ed ha militato in patria nella organizzazione estremistica Jama’a al Islamiya. Nel 1998 era giunto in Italia ottenendo ufficialmente, nel febbraio del 2001, lo status di rifugiato politico. Dal luglio del 2000 si era trasferito a Milano, stabilendosi in via Conte Rosso 18, nello stesso appartamento prima abitato da un altro leader del radicalismo egiziano in Italia, poi morto in Afghanistan in circostanze sconosciute. Abu Omar era diventato in breve imam nella moschea milanese di via Quaranta, nonché un predicatore richiesto in tutte le principali moschee della Lombardia. Già dalla prima metà del 2002, la Digos della Questura di Milano e la Procura di Milano avevano iniziato ad indagare su di lui come sospetto leader di un’associazione terroristica internazionale: le intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche e dei suoi colloqui nella moschea di via Quaranta avevano anche portato all’individuazione di altri possibili membri della stessa associazione.
Tutto questo importante e paziente lavoro investigativo veniva tuttavia vanificato dal suo sequestro: Abu Omar scompariva il 17 febbraio 2003, intorno alle ore 12, in via Guerzoni a Milano, durante il tragitto che quotidianamente percorreva dalla sua abitazione fino alla moschea di viale Jenner. Tre giorni dopo, il 20 febbraio, Nabila Ghali, moglie di Abu Omar, presentava la denuncia di scomparsa del marito, ma già la Digos, ascoltandone le conversazioni al telefono della sua abitazione, aveva colto i segnali di preoccupazione della donna.
Lo stesso 20 febbraio o il mattino dopo, nell’ufficio di Pomarici in Procura, ci ritrovammo con lui io stesso, Stefano Dambruoso (il sostituto che in quel periodo conduceva le principali indagini in tema di terrorismo cosiddetto islamico) e il dirigente della Digos di Milano dell’epoca, Massimo Mazza, in passato stimatissimo investigatore anche nel settore mafioso.
Le prime analisi e valutazioni dei fatti ci videro concordi: se Abu Omar era stato realmente sequestrato – e tutti eravamo nettamente propensi a crederlo – le responsabilità non potevano che essere di servizi segreti stranieri. Quali? Cia e/o Servizi egiziani. Ma eravamo ancora alle prime ipotesi e a un pubblico ministero le ipotesi, per quanto ragionevoli, non possono bastare. Bruno Megale, allora dirigente della Sezione antiterrorismo della Digos di Milano, si mise subito alla ricerca di fatti e prove concrete. Avrò modo di parlare a lungo di questo magnifico «piedipiatti», il vero motore delle incredibili indagini sul sequestro.
Il 26 febbraio, finalmente, la testimonianza di una cittadina egiziana, Merfat Rezk, smuoveva le acque. Riferiva di aver assistito, il 17 febbraio, attorno alle ore 12, in via Guerzoni, a una strana scena: una persona che, per abbigliamento e sembianze, le era parso un islamico, stava mostrando i documenti a un uomo dall’aspetto occidentale. In particolare, la donna aveva precisato che quest’uomo stava parlando al telefono cellulare e sembrava, dunque, effettuare un controllo della persona fermata per strada. Un furgone bianco era parcheggiato vicino ai due uomini. Lei si era distratta per qualche secondo ma, poco dopo, aveva visto il furgone allontanarsi con a bordo l’islamico e chi lo aveva fermato. Circa due anni dopo, il marito della donna ammetterà che la moglie – ormai trasferitasi in Egitto per paura di conseguenze personali – non aveva detto tutta la verità: aveva taciuto di aver anche visto che l’islamico, divincolandosi e chiedendo aiuto, era stato costretto a salire a bordo del veicolo da alcuni uomini.
Il 3 marzo, le autorità Usa in Italia realizzavano un tentativo di depistaggio delle indagini. Ralph Russomando, che risulterà agente della Cia ufficialmente accreditato, con compiti di secondo segretario, presso l’Ambasciata Usa a Roma, consegnava alla polizia italiana un documento in cui si affermava che Abu Omar si trovava in un paese nell’area dei Balcani, dove si era recato spontaneamente.
Intanto, sulla base delle dichiarazioni della teste che aveva visto uno dei rapitori parlare al telefonino, la Digos otteneva dal pm l’autorizzazione ad acquisire i cosiddetti tabulati del traffico dei telefoni cellulari che avevano operato nella zona del sequestro, nel giorno e nella fascia oraria in cui esso si era verificato: la speranza era quella di individuare, attraverso l’analisi delle chiamate effettuate e ricevute dai cellulari, l’utenza del sequestratore che aveva effettuato, o simulato, il controllo dell’identità di Abu Omar.
Un banale errore materiale determinava però un rallentamento di quasi un anno: il sostituto Dambruoso, all’epoca titolare delle indagini, ordinava di acquisire i tabulati del traffico telefonico, ma emetteva il provvedimento in relazione a quelli del 17 marzo del 2003, anziché del 17 febbraio. La svista non veniva notata neppure dalla polizia, sicché le prime analisi furono compiute su dati di nessuna rilevanza. La Digos si accorgeva dello sbaglio solo a marzo del 2004: ad aprile, Dambruoso lasciava la Procura di Milano, per un incarico internazionale presso le Nazioni Unite a Vienna cui era stato destinato dal governo in carica. Toccò a me, in quanto neo-coordinatore del Dipartimento antiterrorismo della Procura, affiancare Pomarici, che già ne era contitolare, nella direzione della delicata inchiesta. La Digos, intanto, sulla base di un secondo provvedimento corretto da Dambruoso stesso, aveva acquisito il traffico telefonico giusto: quello dei cellulari che, tra le ore 11 e le 13 del 17 febbraio 2003, avevano operato nei dintorni di via Guerzoni.
Disporre dei dati, però, non basta: l’esperienza investigativa dimostra che, spesso, troppi dati equivalgono a nessun dato. Occorre essere forniti di adeguato software e servono anche fantasia ed intelligenza nell’utilizzarlo. Altrimenti le macchine sarebbero autosufficienti. L’antiterrorismo della polizia di Milano, fortunatamente, ha a disposizione software e analisti intelligenti e capaci. Il programma, ironia della sorte, era stato in precedenza fornito alla Digos proprio dalla Cia, nel quadro della consueta collaborazione contro il terrorismo internazionale. Ma i poliziotti italiani, evidentemente, sapevano usarlo meglio della Cia e ne conoscevano appieno le potenzialità. Gli analisti, poi, non costano nulla né sono stati chiesti «in prestito» a qualche società privata: sono poliziotti, con facce giovani e sveglissime.
Uno per tutti: M.S. È un giovane assistente di polizia. Tutti hanno visto film o telefilm polizieschi in cui gli esperti di informatica sono in genere rappresentati come giovani estrosi, che vestono in maniera disinvolta, secondo un genuino stile casual. Sembrano tutti fuori dal mondo, assorti nel loro sapere informatico, presi solo dalle macchine cui, digitando, continuano ad impartire ordini. Così è M.S.: capelli lisci ed un po’ lunghi, jeans e maglietta, poche parole e tanta intelligenza. Ma, come i colleghi che con lui lavorano alle tastiere, non è affatto fuori dal mondo. Scava, indaga, mira all’obiettivo e lo raggiunge. E da quel risultato parte alla volta di un traguardo più ambizioso. E poi si interroga sui risultati, sulla loro plausibilità e sul loro grado di compatibilità con i dati fattuali che i suoi colleghi vanno raccogliendo sulla strada, pedinando, osservando, interrogando. Lo chiami per una spiegazione tecnica e lui te la fornisce in termini elementari e comprensibili. Gli fai un’obiezione e te la smonta. Gli chiedi se è possibile ottenere anche un altro tipo di informazione, ma lui ha già interrogato la macchina e te la fornisce all’istante. Questi sono gli uomini di Bruno Megale e della Digos di Milano che hanno individuato i sequestratori della Cia.
Il traffico telefonico acquisito riguardava nella prima fase delle indagini ben 10.718 utenze telefoniche. Una lunga e delicata scrematura consentiva alla Digos di restringere la cerchia di quelle sospette a trenta numeri. Nell’estate del 2004, Megale piombava nel mio ufficio: «Sta venendo fuori l’ira di Dio», fu il suo primo commento. E poi, alludendo alle prove che cercavamo e che finalmente cominciavano ad arrivare, aggiunse: «...ci siamo». Mi spiegò che erano stati individuati diciassette numeri di telefono certamente coinvolti nell’azione. Infatti si trattava di utenze che, sebbene occupanti la stessa «cella» di telefonia mobile e quindi situate a poca distanza l’una dall’altra, si erano scambiate numerose chiamate, quasi tutte di breve durata, intensificatesi tra le 12 e le 12.40 del 17 febbraio del 2003, lasso di tempo in cui era avvenuto il rapimento di Abu Omar. Inoltre, tutte quelle carte Sim erano state attivate tra novembre 2002 e gennaio 2003 ed avevano cessato di funzionare due o tre giorni dopo il sequestro. Risultavano, infine, prive di intestatario o intestate a nominativi fasulli o di persone ignare, in modo da non fare individuare il loro effettivo utilizzatore. Una carta Sim, però, risultava intestata a Monica Adler, cittadina americana: la prima, tra le persone responsabili del sequestro, a essere identificata.
Le indagini si intensificarono nelle settimane successive: si scoprì, così, che, subito dopo il sequestro, gli utilizzatori di quattro di quelle diciassette utenze, insieme a quelli di altri cinque telefoni nel frattempo individuati, avevano compiuto il 17 febbraio un percorso iniziato dalla zona di via Guerzoni, luogo del sequestro, proseguito lungo l’autostrada per Venezia fino all’uscita di Pordenone e terminato nella zona dell’aeroporto di Aviano, dove ha tuttora sede la base dell’Usaf (United States Air Force) e dove erano giunti verso le 16.30. Inoltre, alcuni di questi telefoni avevano chiamato più volte il colonnello americano Joseph Romano, responsabile della sicurezza all’aeroporto di Aviano, nonché il capo della Cia a Milano, Robert Seldon Lady, e varie utenze della Virginia, dove, a Langley, ha notoriamente sede la Cia.
A questo punto, partiva la caccia alla identificazione degli utilizzatori delle carte Sim individuate, incrociando dati di diversa provenienza, tutti tratti dallo studio dei tabulati relativi al traffico telefonico delle schede Sim dal giorno della loro attivazione fino a quello della loro cessazione. Dai tabulati risultavano, con buona precisione, le aree in cui le telefonate erano state effettuate o ricevute. Furono così individuate le presenze degli utenti dei telefoni presso alcuni lussuosi alberghi milanesi, nonché di altre città come Firenze, Venezia, La Spezia, o di paesi come Chiesa di Valmalenco, tutti luoghi dove presumibilmente i sequestratori si erano recati per trascorrervi gradevoli fine settimana. Venivano accertati anche i dati relativi alle loro carte di credito, tessere Frequent Flyers, Viapass e Viacard. Furono acquisiti pure i contratti di noleggio dei veicoli da loro utilizzati, le infrazioni stradali in cui erano incorsi, individuate pure prenotazioni di hotel e biglietti aerei, spesso fatte comunicando i numeri dei telefoni di chi effettuava le prenotazioni stesse: alcuni di quei cellulari erano presenti sul luogo del sequestro il 17 febbraio 2003 e nelle settimane precedenti. Infine, venivano trovate anche le fotocopie di alcuni documenti di identità (passaporti, patenti) esibiti dagli americani negli hotel o utilizzati per i contratti di attivazione delle carte telefoniche: conoscevamo, dunque, alcune delle facce dei sequestratori!
Quasi tutti i nomi degli esecutori e degli organizzatori del sequestro di Abu Omar, insomma, erano saltati fuori uno dopo l’altro: su tutti, quello del capo della Cia a Milano, Robert Seldon Lady, ben conosciuto per la sua veste praticamente ufficiale dalle forze di polizia di Milano, che ne avevano sempre apprezzato qualità professionali e umane. Lady risultava all’epoca del sequestro accreditato come console presso il Consolato Usa di Milano. Ma aveva da tempo lasciato l’incarico e l’Italia.
Intanto, si accertava che Abu Omar, dopo il sequestro, era stato trasferito illegalmente in Egitto. Infatti, sul telefono di casa di Abu Omar, ancora sotto intercettazione, veniva inaspettatamente registrata, il 20 aprile 2004, una conversazione tra la moglie, Nabila Ghali, e il sequestrato, che si trovava ad Alessandria d’Egitto, in casa di parenti. Abu Omar, dopo i saluti, rassicurava la donna dicendole di trovarsi in buona salute, di essere stato vittima di un sequestro e che non poteva al momento allontanarsi dalla città. Chiedeva nello stesso tempo alla consorte di avvisare i «fratelli» milanesi della sua liberazione, raccomandandole però di non far trapelare nulla alla stampa.
Ancora più significative si rivelavano altre telefonate registrate sulla utenza cellulare di Mohammed Reda Elbadry, un altro egiziano legato ad Abu Omar, anch’egli sottoposto ad indagini per sospetta appartenenza a gruppi terroristici. L’8 maggio 2004, Abu Omar diceva a Elbadry di trovarsi ad Alessandria d’Egitto, di essere stato sequestrato, portato direttamente in una base americana e caricato su un aereo militare per il successivo trasferimento. Aggiungeva di essere stato detenuto in Egitto e sottoposto ad interrogatori e violenze. La moglie e l’egiziano amico di Abu Omar venivano così sentiti come testimoni dal pubblico ministero, ma la donna precisava anche che suo marito era stato nuovamente arrestato dalla polizia egiziana: la stampa italiana, infatti, aveva pubblicato la notizia della liberazione di Abu Omar e ciò era stato verosimilmente considerato dagli egiziani una violazione degli obblighi di riserbo assoluto che all’uomo erano stati imposti come condizione del suo rilascio. Abu Omar, dunque, era rimasto libero dal 20 aprile al 12 maggio del 2004, data in cui era ricominciato il suo inferno. Le autorità egiziane non hanno finora mai risposto alle ripetute richieste della Procura di Milano di poterlo interrogare ed acquisire notizie sui tempi e modalità del suo ingresso in Egitto, nonché sulle ragioni della sua detenzione. Ad Abu Omar, dopo la sua definitiva e più recente liberazione, è stato anzi negato il permesso di ritornare in Italia, come egli aveva richiesto.
Avuta conferma che Abu Omar era stato immediatamente trasportato in Egitto dopo il sequestro, si sviluppava con successo anche l’indagine per individuare gli aerei con cui Abu Omar vi era stato illegalmente trasferito. Venivano così acquisiti, grazie anche alla collaborazione di vari ufficiali dell’Aeronautica militare italiana, i dati relativi ai voli di quel giorno. Essi risultavano assolutamente coincidenti pur essendo conservati in sedi diverse, cioè presso gli uffici di Milano e Padova dell’Ente di controllo del volo civile in Italia (Enav), presso l’aeroporto di Aviano e quello di Poggio Renatico (Ferrara) della Nato, entrambi comandati da ufficiali italiani e, infine, presso Eurocontrol di Bruxelles, una sorta di vigile che controlla tutti gli incroci e le rotte degli aerei nei cieli d’Europa. A causa del tempo trascorso, purtroppo, non erano più disponibili le registrazioni informatizzate dei tracciati radar, ma i documenti sequestrati non consentivano alcun dubbio: Abu Omar, giunto ad Aviano, era stato da lì trasportato in volo fino alla base di Ramstein in Germania con un Lear Jet 35, sigla di volo SPAR92, decollato alle ore 18.20 dello stesso giorno del sequestro. Successivamente, da Ramstein, era stato trasferito in volo fino al Cairo con un jet Executive Gulfstream (codice identificativo N85VM) decollato dalla base tedesca alle ore 20.30 dello stesso 17 febbraio.
Philip Morse, uno dei soci della Richmore Aviatio...